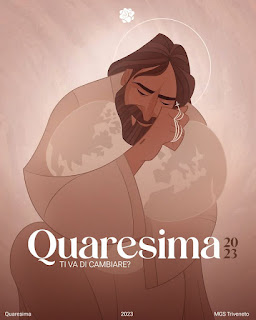"Il Padre nostro". Alla riscoperta delle più importanti preghiere cristiane
(Zenit.org) Nicola Rosetti
Le abbiamo imparate quando eravamo piccoli, spesso le abbiamo mandate giù a memoria e magari continuiamo a ripeterle oggi, più per abitudine che per fede, senza apprezzarne il significato. Stiamo parlando delle preghiere. La spiegazione del loro contenuto può essere oggetto, chiaramente in modo diverso, sia di una catechesi che di una lezione di religione a scuola. Vogliamo iniziare questo percorso di riscoperta a partire dalla preghiera del cristiano: il “Padre Nostro”.
Raccontano i Vangeli di Luca e Matteo che fu lo stesso Gesù a insegnare ai discepoli questa preghiera, ma le parole del Signore sono tutt’altro che frutto di qualcosa di improvvisato. Forse non ci abbiamo mai fatto caso ma le parole del “Padre nostro” sono disposte secondo una precisa struttura.
Lasciamo da parte la versione secondo Luca e prendiamo in esame quella secondo Matteo che è quella che comunemente recitiamo.
La preghiera si compone di una invocazione e di 7 richieste:
1) sia santificato il tuo nome
2) venga il tuo regno
3) sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra
4) Dacci oggi il nostro pane quotidiano
5) rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori
6) e non ci indurre in tentazione
7) ma liberaci dal male.
La struttura
Con l’invocazione il fedele si rivolge a Dio e lo invita all’ascolto delle sue richieste. Fra queste domande, le prime tre riguardano Dio mentre le ultime quattro riguardano l’uomo. Questa divisione la ritroviamo anche, ad esempio, nella recita del rosario, quando la voce guida recita la prima parte e gli altri fedeli recitano la seconda.
La domanda più importante è la quarta. Infatti, oltre a trovarsi in posizione centrale, questa richiesta è incorniciata dalle domande 3 e 5 che sono le uniche a contenere una espansione della frase principale introdotte dalla parola “come”. Ma la sua preminenza sulle altre domande è data dal diretto collegamento con la parola “Padre” contenuta nell’invocazione: infatti è proprio il padre colui che nelle società antiche sfamava i propri figli.
Il significato
Passiamo ora a una breve spiegazione della preghiera.
0) Solo sull’invocazione si potrebbero scrivere molti trattati di teologia! Invocare Dio con la parola “Padre” è una novità introdotta dal cristianesimo. Infatti nell’antichità Dio poteva essere considerato padre degli dei come per i greci, o padre di un popolo, come per Israele. Ma mai nessuna religione si era rivolta alla propria divinità invocandola con una tale confidenza e estendendo la paternità di Dio ad ogni uomo. La parola “nostro” sottolinea la vicinanza di Dio all’orante, mentre le parole “che sei nei cieli” mettono in evidenza l’alterità di Dio rispetto al mondo e quindi la sua distanza o trascendenza.
1) La prima domanda del “Padre nostro” chiede che tutti gli uomini riconoscano la grandezza di Dio come ci illustra Sant’Agostino: “La prima di tutte le cose che si chiedono è questa: sia santificato il tuo nome. E non lo si chiede quasi che il nome di Dio non sia santo, ma perché sia ritenuto tale dagli uomini. Si esprime così il desiderio che Dio si manifesti loro in modo tale che essi non stimino niente più santo di lui e che nessuno temano di offendere più di lui”. Si può collegare questa prima domanda alla virtù teologale della Fede, per mezzo della quale si crede in Dio e nella sua azione salvifica.
2) “Venga il tuo regno” deve essere inteso nello spirito della precedente invocazione, cioè (venga) in noi (Tertulliano). Con questa domanda il fedele è consapevole che l’attuale stato di cose soggiace alla ferita del peccato originale e solo l’intervento escatologico di Dio porrà fine a ogni sofferenza. Il cristiano vive in una continua tensione fra il bene che deve compiere e la perfezione che può giungere solo dall’Alto. Come si può facilmente intuire, questa domanda si può collegare con la virtù teologale della Speranza.
3) Nella logica delle due domande precedenti, si chiede che si compia la volontà di Dio in noi, come ci spiega ancora Sant’Agostino: “Se tu non lo dici, non farà forse Dio la sua volontà? Ricorda ciò che hai proclamato nel credo: Credo in Dio Padre Onnipotente. Se dunque è onnipotente, tu preghi perché sia fatta la sua volontà? Che cosa significa allora Sia fatta la tua volontà? Si compia in me, così che io non opponga resistenza alla tua volontà. Anche in questo caso, tu preghi nel tuo interesse, non tanto chiedendo qualcosa a favore di Dio”. La volontà di Dio non può che essere quella che si realizzi il bene e per questo la terza domanda si può collegare con la virtù teologale della Carità.
4) Per pane quotidiano si possono intendere due cose: il pane materiale (necessario alla vita fisica), oppure quello eucaristico (indispensabile per la vita di fede). Questa domanda, come già detto, si trova in posizione centrale ed è quella che meglio si collega con l’espressione “Padre”.
5) La quinta domanda chiede a Dio di misurarci con la stessa misura con la quale noi misuriamo gli altri. Questo tipo di ragionamento è tipico dell’evangelista Matteo: si legga ad esempio la parabola del servo spietato (Mt 18,23-35).
6) La sesta domanda chiede a Dio di non lasciare soli i suoi figli nell’ora della prova
7) Con la settima ed ultima domanda, si chiede a Dio di farci uscire vincitori dalla prova. Si noti che questa domanda si trova diametralmente opposta a quella che chiede la santificazione del nome del Signore perché Dio e il male stanno agli estremi opposti
Per approfondimenti o informazioni: www.nicolarosetti.it
(Articolo tratto da Àncora Online, il settimanale della Diocesi di San Benedetto del Tronto)