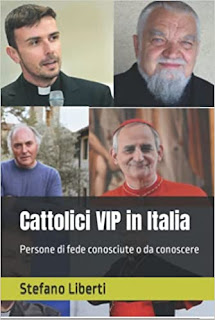Pasqua: le cose da sapere
La Pasqua è il culmine del Triduo pasquale, centro e cuore di tutto l’anno liturgico. È la festa più solenne della religione cristiana che prosegue con l’Ottava di Pasqua e con il tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino alla solennità della Pentecoste.È la festa più importante per i cristiani e significa etimologicamente "passaggio". La data è mobile perché dipende dal plenilunio di primavera mentre l’origine è legata al mondo ebraico, in particolare alla festa di Pesach, durante la quale si celebrava il passaggio di Israele, attraverso il mar Rosso, dalla schiavitù d’Egitto alla libertà.
COSA SIGNIFICA LA PAROLA “PASQUA”?
Deriva dal greco: pascha, a sua volta dall'aramaico pasah e significa propriamente “passare oltre”, quindi “passaggio”. Gli Ebrei ricordavano il passaggio attraverso il mar Rosso dalla schiavitù d’Egitto alla liberazione. Per i cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo.

QUALI SONO LE ORIGINI DI QUESTA FESTA?
Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era in origine legata all'attività agricola ed era la festa della raccolta dei primissimi frutti della campagna, a cominciare dal frumento. Altre feste, solo per ricordarle, erano la Festa delle Settimane, che celebrava la raccolta del grano ai primi di giugno, e la Festa dei Tabernacoli, cioè della vendemmia, a settembre.
In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale della liberazione degli ebrei dalla schiavitù, significato che si aggiunse all’altro, come ricordo della fuga dall’Egitto e del fatto che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti gli stipiti delle porte affinché l’angelo sterminatore, come dice la Bibbia, passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti.
Ancora oggi, la cena pasquale presso gli Ebrei si svolge secondo un preciso ordine detto Seder. Ci si nutre di cibi amari per ricordare l’amarezza della schiavitù egiziana e la stupore della libertà ritrovata.
Per celebrare la Pasqua gli israeliti al tempo di Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme. Anch’egli vi si recava. La sua morte avvenne, infatti, in occasione della pasqua ebraica. Egli per i cristiani è l’agnello pasquale che risparmia dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi (cfr 1Cor 5,7-8)
In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale della liberazione degli ebrei dalla schiavitù, significato che si aggiunse all’altro, come ricordo della fuga dall’Egitto e del fatto che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti gli stipiti delle porte affinché l’angelo sterminatore, come dice la Bibbia, passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti.
Ancora oggi, la cena pasquale presso gli Ebrei si svolge secondo un preciso ordine detto Seder. Ci si nutre di cibi amari per ricordare l’amarezza della schiavitù egiziana e la stupore della libertà ritrovata.
Per celebrare la Pasqua gli israeliti al tempo di Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme. Anch’egli vi si recava. La sua morte avvenne, infatti, in occasione della pasqua ebraica. Egli per i cristiani è l’agnello pasquale che risparmia dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi (cfr 1Cor 5,7-8)
PERCHÉ SI MANGIA L’AGNELLO?
La tradizione di consumare l'agnello per Pasqua deriva dalla Pesach, la Pasqua ebraica. Infatti l'agnello fa parte dell'origine di questa festività. In particolare si fa riferimento a quando Dio annunciò al popolo di Israele che lui lo avrebbe liberato dalla schiavitù in Egitto dicendo "In questa notte io passerò attraverso l'Egitto e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia fra le genti che tra il bestiame". Ordinando, così, al popolo d'Israele di marcare le loro porte con del sangue d'agnello in modo che lui fosse in grado riconoscere chi colpire col suo castigo e chi no. Inoltre in passato esisteva un comandamento riguardo la Pasqua ebraica che diceva di fare l'offerta dell'agnello il giorno 14 del mese ebraico di Nisan e di consumare quella stessa notte il sacrificio di Pesach.
Con il Cristianeismo, il simbolo dell'agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso e il suo sacrificio ha valore di redenzione.
Con il Cristianeismo, il simbolo dell'agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso e il suo sacrificio ha valore di redenzione.
PERCHÉ LA DATA DELLA PASQUA È MOBILE?
Perché è legata al plenilunio di primavera. La datazione della Pasqua, nel mondo cristiano fu motivo di gravi controversie fra le Chiese d’Oriente e d’Occidente, la prima era composta da ebrei convertiti e la celebrava subito dopo la Pasqua ebraica e cioè nella sera della luna piena, il 14 Nisan, primo mese dell’anno ebraico; quindi sempre in giorni diversi della settimana. Solo con il Concilio di Nicea del 325, si ottenne che fosse celebrata nello stesso giorno in tutta la cristianità e cioè adottando il rito Occidentale, fissandola nella domenica che seguiva il plenilunio di primavera. Oggi la celebrazione cade tra il 22 marzo e il 25 aprile denominandola così Pasqua bassa o alta, secondo il periodo in cui capita.
Essendo una festa mobile, determina la data di altre celebrazioni ad essa collegate, come la Quaresima, la Settimana Santa, l’Ascensione, la Pentecoste. La Chiesa contempla per i cattolici l’obbligo del Precetto Pasquale, cioè confessarsi e ricevere l’Eucaristia almeno una volta nel periodo pasquale.
Essendo una festa mobile, determina la data di altre celebrazioni ad essa collegate, come la Quaresima, la Settimana Santa, l’Ascensione, la Pentecoste. La Chiesa contempla per i cattolici l’obbligo del Precetto Pasquale, cioè confessarsi e ricevere l’Eucaristia almeno una volta nel periodo pasquale.

COSA DICONO I VANGELI? DALLA SEPOLTURA “PROVVISORIA” ALLA RISURREZIONE DI GESÙ
Dopo la morte in Croce, la sepoltura di Gesù fu una operazione provvisoria, in quando essendo ormai un’ora serale e si approssimava con il tramonto il Sabato ebraico, in cui è noto era proibita qualsiasi attività, il corpo di Gesù fu avvolto in un lenzuolo candido e deposto nel sepolcro nuovo scavato nella roccia, appartenente a Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinedrio, ma ormai seguace di Gesù. Le operazioni necessarie per questo tipo di sepoltura, che non era l’inumazione nel terreno, e cioè il cospargere il corpo con profumi ed unguenti conservativi e l’avvolgimento dello stesso corpo con fasce o bende (ne abbiamo l’esempio nel racconto di Lazzaro risuscitato dallo stesso Gesù); queste operazioni, dicevamo, furono rimandate a dopo il Sabato dalle pie donne, le quali dopo aver preparato gli aromi e visto dove era stato deposto il corpo di Gesù, alla fine si allontanarono.
Dopo la Parasceve (vigilia del Sabato) quindi appena dopo sepolto Gesù, i sacerdoti ed i Farisei si recarono da Pilato dicendogli che si erano ricordati «che quell’impostore quando era ancora in vita, disse: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: È risorto dai morti. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». E Pilato, secondo il solo Vangelo di Matteo, autorizzò il sigillo del sepolcro e dispose alcune guardie per controllarlo.
Trascorso il Sabato, in cui tutti osservarono il riposo, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e Salome, completarono la preparazione dei profumi e si recarono al sepolcro di buon’ora per completare le unzioni del corpo e la fasciatura; lungo la strada dicevano tra loro, chi poteva aiutarle a spostare la pesante pietra circolare, che chiudeva la bassa apertura del sepolcro, che era composto da due ambienti scavati nella roccia, consistenti in un piccolo atrio e nella cella sepolcrale; quest’ultima contenente una specie di rialzo in pietra, su cui veniva deposto il cadavere. Quando arrivarono, secondo i Vangeli, vi fu un terremoto, un angelo sfolgorante scese dal cielo, si accostò al sepolcro fece rotolare la pietra e si pose a sedere su di essa; le guardie prese da grande spavento caddero svenute. Ma l’Angelo si rivolse alle donne sgomente, dicendo loro: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». Proseguendo con il racconto del Vangelo di Matteo, le donne si allontanarono di corsa per dare l’annunzio ai discepoli.
Va ricordato che la Risurrezione di Gesù viene annunciata da alcune donne, che secondo l’antico Diritto ebraico, erano inabilitate a testimoniare, quindi con questo evento che le vede messaggere e testimoni, viene anche ad inserirsi un evento storico nella socialità ebraica. Quando le donne raggiunsero gli apostoli e riferirono l’accaduto, essi corsero verso il sepolcro, ma Pietro e Giovanni corsero avanti, al sepolcro arrivò per primo Giovanni più giovane e veloce, ma sulla soglia si fermò dopo aver visto il lenzuolo (Sindone) a terra, Pietro sopraggiunto, entrò per primo e constatò che il lenzuolo era per terra, mentre il sudario, usato per poggiarlo sul capo dei defunti, era ripiegato in un angolo, poi entrò anche Giovanni e ambedue capirono e credettero a quanto lo stesso Gesù, aveva detto in precedenza riguardo la sua Risurrezione.
Dopo la Parasceve (vigilia del Sabato) quindi appena dopo sepolto Gesù, i sacerdoti ed i Farisei si recarono da Pilato dicendogli che si erano ricordati «che quell’impostore quando era ancora in vita, disse: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: È risorto dai morti. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». E Pilato, secondo il solo Vangelo di Matteo, autorizzò il sigillo del sepolcro e dispose alcune guardie per controllarlo.
Trascorso il Sabato, in cui tutti osservarono il riposo, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e Salome, completarono la preparazione dei profumi e si recarono al sepolcro di buon’ora per completare le unzioni del corpo e la fasciatura; lungo la strada dicevano tra loro, chi poteva aiutarle a spostare la pesante pietra circolare, che chiudeva la bassa apertura del sepolcro, che era composto da due ambienti scavati nella roccia, consistenti in un piccolo atrio e nella cella sepolcrale; quest’ultima contenente una specie di rialzo in pietra, su cui veniva deposto il cadavere. Quando arrivarono, secondo i Vangeli, vi fu un terremoto, un angelo sfolgorante scese dal cielo, si accostò al sepolcro fece rotolare la pietra e si pose a sedere su di essa; le guardie prese da grande spavento caddero svenute. Ma l’Angelo si rivolse alle donne sgomente, dicendo loro: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». Proseguendo con il racconto del Vangelo di Matteo, le donne si allontanarono di corsa per dare l’annunzio ai discepoli.
Va ricordato che la Risurrezione di Gesù viene annunciata da alcune donne, che secondo l’antico Diritto ebraico, erano inabilitate a testimoniare, quindi con questo evento che le vede messaggere e testimoni, viene anche ad inserirsi un evento storico nella socialità ebraica. Quando le donne raggiunsero gli apostoli e riferirono l’accaduto, essi corsero verso il sepolcro, ma Pietro e Giovanni corsero avanti, al sepolcro arrivò per primo Giovanni più giovane e veloce, ma sulla soglia si fermò dopo aver visto il lenzuolo (Sindone) a terra, Pietro sopraggiunto, entrò per primo e constatò che il lenzuolo era per terra, mentre il sudario, usato per poggiarlo sul capo dei defunti, era ripiegato in un angolo, poi entrò anche Giovanni e ambedue capirono e credettero a quanto lo stesso Gesù, aveva detto in precedenza riguardo la sua Risurrezione.

COME SI COMPONE LA LITURGIA DELLA VEGLIA PASQUALE?
Per Sant’Agostino quella pasquale è “la madre di tutte le veglie sante, durante la quale il mondo intero è rimasto sveglio”. Nel corso di questa notte, la Chiesa celebra la Resurrezione di Cristo, battezzando nuovi cristiani e domandando a coloro che già lo sono, di rinnovare tutti insieme gli impegni del loro Battesimo.
La Veglia pasquale è una celebrazione complessa ed unitaria, che si svolge in quattro momenti successivi:
1) Liturgia della Luce che inizia con la benedizione del fuoco, la preparazione e accensione del cero quale “luce di Cristo”, e la processione con cui è introdotto nella chiesa buia, che è quindi illuminata dai ceri dei fedeli accesi al cero pasquale. Segue il solenne annunzio pasquale, detto anche dalla parola iniziale latina Exultet; 2) Liturgia della Parola con nove letture, sette tratte dall’Antico testamento e le ultime due dal Nuovo; 3) Liturgia Battesimale; 4) Liturgia Eucaristica. Il rito si svolge nella notte, simbolo dell’umanità che senza Cristo è immersa nelle tenebre dell’ignoranza e dell’errore, del peccato e della morte.
La Veglia pasquale è una celebrazione complessa ed unitaria, che si svolge in quattro momenti successivi:
1) Liturgia della Luce che inizia con la benedizione del fuoco, la preparazione e accensione del cero quale “luce di Cristo”, e la processione con cui è introdotto nella chiesa buia, che è quindi illuminata dai ceri dei fedeli accesi al cero pasquale. Segue il solenne annunzio pasquale, detto anche dalla parola iniziale latina Exultet; 2) Liturgia della Parola con nove letture, sette tratte dall’Antico testamento e le ultime due dal Nuovo; 3) Liturgia Battesimale; 4) Liturgia Eucaristica. Il rito si svolge nella notte, simbolo dell’umanità che senza Cristo è immersa nelle tenebre dell’ignoranza e dell’errore, del peccato e della morte.

COS'È LA BENEDIZIONE PASQUALE URBI ET ORBI?
Urbi et Orbi è un’espressione latina che significa "Alla città (di Roma) e al mondo". La benedizione Urbi et Orbi è la prima benedizione fatta da un Papa subito dopo l’elezione al soglio pontificio dalla Loggia centrale della Basilica vaticana. Viene inoltre diffusa dal Pontefice nei giorni di Natale e Pasqua alla folla riunita in piazza San Pietro e in occasioni particolari. La benedizione, solitamente accompagnata da un messaggio, comporta l'assoluzione di tutti i peccati temporali per tutti i presenti in Piazza San Pietro e per coloro che la ricevono per tramite dei vari mezzi di comunicazione.
PERCHÉ SI MANGIANO LE UOVA?
La tradizione di decorare uova risale già ai primi cristiani che pitturavano le uova di rosso, per ricordare il sangue di Cristo, e le decoravano con croci o altri simboli (una tradizione che dura ancora oggi nei paesi ortodossi e cristiano-orientali). La simbologia dell’uovo è evidente: dall’uovo nasce la vita che a sua volta veniva associata con la rinascita del Cristo e quindi con la Pasqua. In realtà, le uova decorate secondo questa simbologia sarebbero andate bene anche per il Natale, in occasione della nascita di Cristo, ma secondo alcuni studi la tradizione delle uova pasquali venne rafforzata da un’usanza tipicamente pasquale: la Quaresima, il periodo di quaranta giorni prima della Pasqua nel quale i credenti sono tenuti al digiuno e all’astinenza. In questo periodo è vietato mangiare carne.
In passato, e tuttora nelle chiese cristiane orientali, era vietato mangiare anche le uova. Era difficile però costringere le galline a non depositare uova in quel periodo, così i primi cristiani si trovavano con un surplus di uova che non potevano mangiare.
Dalla necessità di farci qualcosa sarebbe nata la tradizione di bollirle fino a farle diventare dure come sassi e poi dipingerle con colori sacri e simbolici.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il nome "Pasqua" deriva
dal latino pascha e dall'ebraico pesah e
significa passaggio.
E' la massima festività della liturgia cristiana,
perché celebra la resurrezione di Gesù Cristo.
La datazione della Pasqua
Il Nuovo Testamento narra che Gesù fu crocifisso
alla vigilia della Pasqua ebraica.
Nei primissimi tempi del cristianesimo, i
cristiani di origine ebraica celebravano la Resurrezione di Cristo subito dopo
la Pasqua ebraica, che veniva calcolata in base al calendario lunare babilonese
e cadeva ogni anno in un diverso giorno.
I cristiani di origine pagana celebravano la
Pasqua ogni domenica.
Nacquero così gravi controversie all'interno del
mondo cristiano, che si risolsero nel 325 con il concilio di Nicea in cui si
stabilì definitivamente che la Pasqua doveva essere celebrata da tutta la
cristianità la prima domenica dopo la luna piena seguente l'equinozio di
primavera. Inoltre nel 525 si stabilì che la data doveva trovarsi fra il 22
marzo e il 25 aprile.
Seguiamo ancora alcuni passi di quanto scrive Enzo
Bianchi, questa volta in un articolo pubblicato su La Stampa (Pasqua:
bisogna credere l’incredibile, 24.4.11) per cogliere il significato
spirituale di questa grande festa:
“Pasqua è la festa propria della fede cristiana e se questa risurrezione di Cristo non fosse realtà – ricorda san Paolo – allora la fede sarebbe “vana”, vuota, incapace di dare consistenza alla vita del credente. Davvero i cristiani si sentirebbero come i più miserabili di tutta l’umanità, degli autoillusi da compiangersi… Sì, perché al cuore della fede cristiana vi è questo credere a un “incredibile”: come credere che quel cadavere è risorto? E che quella risurrezione di Gesù di Nazaret possa manifestare i suoi effetti vivificanti su altri esseri umani e ancora oggi? I Vangeli, ben consapevoli di questa difficoltà, testimoniano concordemente la fatica di quanti avevano seguito Gesù sulle strade di Galilea e di Giudea, fino a Gerusalemme, a pervenire alla fede nella risurrezione. Scandalosa era già la morte violenta, ignominiosa di un Messia, ma ancor più scandalosa è la risurrezione del Messia morto in croce. (…) Gesù è risorto perché neanche l’oceano del male e della morte può spegnere l’amore vissuto. Un messaggio così, come può non interessare anche chi non crede in Gesù? L’amore riguarda tutti gli esseri umani!
Ma questo messaggio così forte e liberante è affidato alla povertà dei cristiani. (…) Sì, i credenti devono mostrare che la vita è più forte della morte, e devono farlo nel costruire comunità in cui il “noi” si fa carico di ciascuno e l’“io” rinuncia a prevaricare, nel perdonare senza chiedere il contraccambio, nella gioia profonda che permane anche nelle situazioni di sofferenza e di persecuzione, nella compassione per ogni creatura, soprattutto per gli ultimi e i sofferenti, nella giustizia che porta a operare la liberazione dalle situazioni di morte in cui giacciono tanti esseri umani, nell’accettare di spendere la propria vita per gli altri, nel dare la vita liberamente e per amore, fino a pregare per gli stessi assassini, come tanti testimoni hanno fatto, ancora ai nostri giorni. Ma questo messaggio così forte e liberante è affidato alla povertà dei cristiani. (…) Sì, i credenti devono mostrare che la vita è più forte della morte, e devono farlo nel costruire comunità in cui il “noi” si fa carico di ciascuno e l’“io” rinuncia a prevaricare, nel perdonare senza chiedere il contraccambio, nella gioia profonda che permane anche nelle situazioni di sofferenza e di persecuzione, nella compassione per ogni creatura, soprattutto per gli ultimi e i sofferenti, nella giustizia che porta a operare la liberazione dalle situazioni di morte in cui giacciono tanti esseri umani, nell’accettare di spendere la propria vita per gli altri, nel dare la vita liberamente e per amore, fino a pregare per gli stessi assassini, come tanti testimoni hanno fatto, ancora ai nostri giorni.Paradosso, certo, la risurrezione. Ma, proprio per questo, può essere narrato in modo credibile solo da altri paradossi, da quell’amore folle che arriva ad abbracciare perfino il nemico. Il cuore della fede cristiana è esattamente questo: credere l’incredibile, amare chi non è amabile, sperare contro ogni speranza. Sì, fede, speranza e carità sono possibili in ogni condizione, anche la più sofferta, se si crede alla risurrezione.
Continua idealmente il card.
Martini: la Pasqua è per tutti un invito alla speranza:
“soprattutto per i sofferenti, per le persone anziane, per tutti coloro che sono curvi sotto i pesi della vita, per tutti gli esclusi dai circuiti della cultura predominante, che è (ingannevolmente) quella dello «star bene» come principio assoluto. Vorrei che il saluto e il grido che i nostri fratelli dell’Oriente si scambiano in questi giorni, «Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto», percorresse le corsie degli ospedali, entrasse nelle camere dei malati, nelle celle delle prigioni (…). La Pasqua ci dice che «le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi» (Rom 8,18). (…)In occasione della Pasqua vorrei poter dire a me stesso con fede le parole di Paolo nella seconda Lettera ai Corinzi: «Per questo non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne».(…) Sperare così può essere difficile, ma non vedo altra via di uscita dai mali di questo mondo, a meno che non si voglia nascondere il volto nella sabbia e non voler vedere o pensare nulla. Più difficile è però per me esprimere che cosa può dire la Pasqua a chi non partecipa della mia fede ed è curvo sotto i pesi della vita. (…) Vedo che c’è dentro tutti noi qualcosa di quello che san Paolo chiama «speranza contro ogni speranza» (Rm, 4,18), cioè una volontà e un coraggio di andare avanti malgrado tutto, anche se non si è capito il senso di quanto è avvenuto.
Ma
torniamo alle riflessioni di Enzo Bianchi ora ricavate di
nuovo dal saggio Dare senso al tempo:
«Il solo e vero peccato è rimanere insensibili alla resurrezione» diceva Isacco il Siro, un padre della chiesa antica. (…) Nel giorno di Pasqua ogni cristiano proclama la vittoria della vita sulla morte, perché Gesù il Messia è risuscitato da morte per essere il vivente per sempre: colui che essendo uomo come noi, carne come noi siamo carne, colui che è nato e vissuto in mezzo a noi, colui che è morto di morte violenta, che è stato crocifisso e sepolto, è risorto!O morte, dov’è la tua vittoria? O morte, tu non sei più l’ultima parola per gli uomini, ma sei diventata un passaggio, l’ora dell’esodo dalla vita terrena alla vita eterna, da questo mondo al regno di Dio … Questo dovrebbe essere il canto del cristiano in questo giorno della Pasqua, festa delle feste, perché Cristo è risorto quale primizia di tutti noi, perché la vita regna definitivamente e in ogni creatura è iniziato un processo segreto ma reale di redenzione, di trasfigurazione. (…)A causa dell’angoscia e della paura la brama di vita degli uomini diventa odio, misconoscimento dell’altro, concorrenza, rivalità, sopraffazione. L’angoscia può sfigurare tutto, anche l’amore. Così la morte appare essere attiva e presente non solo nel momento dello spegnimento della vita fisica del corpo umano, ma anche prima: essa è una potenza che compie incursioni nella sfera dell’esistenza e attenta alla pienezza delle relazioni e della vita.Questa è la morte contro la quale Gesù ha lottato fino a riportare la vittoria. L’agonía iniziata da Gesù nell’orto degli Ulivi (Lc 22,44) è una lotta (agón) che si è conclusa con la discesa agli inferi, quando ha sconfitto il diavolo – e dunque la morte e il peccato – in modo definitivo. E Gesù non ha vinto solo la sua morte, ma la Morte: «Con la morte ha vinto la morte», canta oggi la liturgia! (…)La resurrezione di Gesù è dunque il sigillo posto dal Padre sulla lotta del Figlio, sul suo agón: questi, mostrando di avere una ragione per morire (dare la vita per gli altri), ha mostrato che c’è una ragione per vivere (amare, dimorare nella comunione). Allora il Padre lo ha richiamato dai morti facendolo Signore per sempre.Gli uomini tutti, anche se non conoscono Dio e neppure il suo disegno, portano nel loro cuore il senso dell’eternità e tutti si domandano: «Che cosa possiamo sperare?» Essi sanno che, se restano insensibili alla resurrezione, si vietano di conoscere «il senso del senso» della loro vita. Gli uomini attendono, cercano a fatica, e a volte per cammini sbagliati, la buona notizia della vita più forte della morte, dell’amore più forte dell’odio e della violenza. Cristo, risorto e vivente per sempre, è la risposta vera che attende dai cristiani quella narrazione autentica che solo chi ha fatto l’esperienza del Vivente può dare. Dove sono questi cristiani? Sì, oggi ci sono ancora cristiani capaci di questo: ci sono nuovamente martiri cristiani, ci sono nuovamente profeti cristiani, ci sono testimoni che non arrossiscono mai del Vangelo. Ancora una volta giunge dalla tomba vuota, oggi come quel mattino della resurrezione, l’annuncio: «Non temete, non abbiate paura, non siate nell’angoscia! Il Crocifisso è risorto e vi precede!» Sì, è ormai vicina per la chiesa una primavera, una stagione in cui lo Spirito del Risorto si farà presente più che mai, una stagione in cui la Parola di Dio sarà meno rara.E sarà una stagione senza fughe, né evasioni, né spiritualismi, ma segnata dal vivere la risurrezione nell’esistenza, nella storia, nell’oggi, in modo che la fede pasquale diventi efficace già ora e qui. Cosa significa questo secondo i Vangeli? Che i credenti devono mostrare nella compagnia degli uomini la risurrezione, devono narrare agli uomini che la vita è più forte della morte, e devono farlo nel costruire comunità in cui si passa dall’io al noi, nel perdonare senza chiedere reciprocità, nella gioia profonda che permane anche nelle situazioni di pressura, nella compassione per ogni creatura, soprattutto per gli ultimi, i sofferenti, nella giustizia che porta a operare la liberazione dalle situazioni di morte in cui giacciono tanti uomini, nell’accettare di spendere la propria vita per gli altri, nel rinunciare ad affermare se stessi senza gli altri o contro di essi, nel dare la vita liberamente e per amore, fino a pregare per gli stessi assassini.Perché il cuore della fede cristiana sta proprio in questo: credere l’incredibile, amare chi non è amabile, sperare contro ogni speranza. Sì, fede, speranza e carità sono possibili solo se si crede alla risurrezione. Allora, davvero l’ultima nostra parola non sarà la morte né l’inferno, ma la vittoria sulla morte e sull’inferno. La Pasqua apre per tutti l’orizzonte della vita eterna: che questa Pasqua sia Pasqua di speranza per tutti. Veramente per tutti!
ENZO
BIANCHI
Dare senso al tempo
Dare senso al tempo
La data della Pasqua è diversa ogni anno e si
colloca nella domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di
primavera (21 marzo): Pasqua, quindi, cade dal 22 marzo (se il 21 marzo è
sabato ed è luna piena) al 25 aprile.
LE TRADIZIONI PASQUALI: uova, colomba…
I messaggi fondamentali della Pasqua, la Vita che
è più forte della morte (con il sepolcro vuoto), la Pace e lo Spirito, doni del
Risorto, sono espressi simbolicamente attraverso alcune tradizioni che sono ben
diffuse nel mondo:
- · le uova (di cioccolato, con la sorpresa dentro, ma anche le uova sode da mangiare nella colazione pasquale e magari benedette nel sabato santo): sono simbolo della vita, della sorpresa di una vita che vince l’apparente morte.
- · La colomba (dolce tipico pasquale) rappresenta la Pace e lo Spirito donati dal Risorto.