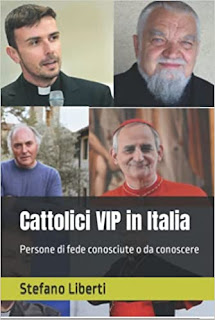L'adolescenza "malata" secondo Galimberti e D'Avenia
Quasi un botta e risposta tra il filosofo Galimberti e lo scrittore D'Avenia sul Corriere di pochi giorni fa sul tema delle problematiche adolescenziali: inizia Galimberti con un'intervista dal titolo: «Stop all’adolescenza perenne. È finita l’idea di bene comune» in cui esprime la sua preoccupazione per le nuove generazioni che sono preda del nichilismo (non riescono a trovare uno scopo nella loro vita) e dell'individualismo edonista (dove sono i soldi l'unico valore ricercato per trovare evasione e piacere personale). Di altra idea (o prospettiva) è D'Avenia che nella sua rubrica settimanale ("Ultimo banco") riprende l'intervista e, indirettamente, gli risponde:
Tornando all'intervista a Galimberti, ho trovato interessanti anche le risposte a domande più "religiose":«Era di mattina molto presto, le strade pulite e deserte. Andavo alla stazione. Confrontando il mio orologio con quello di un campanile, vidi che già era molto più tardi di quanto avessi creduto, dovevo affrettarmi, l’ansia per quella scoperta mi fece incerto della strada, non conoscevo ancora bene quella città; per fortuna lì vicino c’era una guardia, corsi da lui e senza fiato gli domandai la strada. Egli sorrise e disse: “Da me vuoi sapere la via?”. “Sì”, dissi, “perché non riesco a trovarla da me”. “Rinuncia, rinuncia!”, disse e si girò bruscamente, come chi vuole essere solo con la propria risata». Avevo 17 anni quando Franz Kafka mi fece scoprire che la realtà è una metafora della grande narrativa e non viceversa. Il brevissimo racconto s’intitola Rinuncia e mi è tornato in mente leggendo, sulle pagine di questo giornale, la recente intervista a Umberto Galimberti che denuncia: «i ragazzi non stanno bene, ma non capiscono nemmeno perché. Gli manca lo scopo. Per loro il futuro da promessa è divenuto minaccia. Bevono tanto, si drogano, vivono di notte anziché di giorno per non assaporare la propria insignificanza sociale. Nessuno li convoca». Personalmente vedo anche altri ragazzi, statisticamente meno numerosi o rappresentati, ma non per questo meno rilevanti, e sono altresì convinto che il dolore dell’insignificanza sia una risorsa educativa e non un capolinea, ma: «Nessuno li convoca». Perché? Manca la chiamata, l’assenza di scopo infatti riguarda chi lo scopo dovrebbe mostrarlo, gli educatori: «Nel 1979, quando cominciai a fare lo psicoanalista — prosegue Galimberti — i problemi erano a sfondo emotivo, sentimentale e sessuale. Ora riguardano il vuoto di senso».
Nichilismo e individualismo sono, oggi, la Grande Rinuncia alla vita.Il vuoto di senso ha i suoi guardiani, come racconta Kafka: essi non dicono che non ci sia una strada, ma scherniscono chi la cerca, voltandosi dall’altra parte, con una risata. Sono coloro che, a vario titolo, annichiliscono (la radice è la stessa di nichilismo) le vite loro affidate. In qualsiasi ambito (politico, economico, professionale, educativo…), i burocrati della Rinuncia non spingono ma spengono la vita: attorno a loro fioriscono censura, invidia, calunnia, disunione, sospetto, paura, menzogna, sotterfugio, sopruso, violenza… La loro risata «di spalle» suona a scherno, ma tradisce la paura di essere smascherati, perché la chiamata a cui hanno rinunciato non viene meno: una voce sussurra dentro di noi e, nel nostro cuore, se non siamo già vittime della Rinuncia o addirittura agenti della sua Burocrazia, cova sempre un po’ dell’ardore dell’Ulisse dantesco. Lo rappresenta lo stesso Kafka in un altro micro-racconto: Partenza. Scritto nello stesso anno di Rinuncia (1922), ne è l’altra faccia: «Ordinai di andare a prendere il mio cavallo dalla stalla. Il servo non mi capì. Andai io stesso nella stalla, sellai il mio cavallo e vi montai. In lontananza sentii suonare una tromba, chiesi al servo che cosa volesse dire. Egli non lo sapeva e non aveva sentito niente. Presso il portone mi trattenne e domandò: “Signore, dove vai?”. “Non lo so – dissi – solo via di qua, solo via di qua. Sempre via di qua, solo così posso raggiungere la mia meta”. “Conosci allora la tua meta?”, chiese. “Sì – risposi – Te l’ho detto: ‘Via-di-qua’. Ecco la mia meta”. “Non hai viveri con te”, disse. “Io non ne ho bisogno – dissi – il viaggio è così lungo, che dovrò morire di fame, se non ricevo nulla sulla via. Nessuna provvista mi può salvare. Per fortuna è un viaggio veramente immenso (ungeheure)”». Il finale sembra paradossale, ma paradossali sono le verità essenziali dell’arte di vivere.La meta del viaggio è Via-di-qua: via dalla rinuncia al senso della vita. La Partenza è il primo atto di ribellione necessario contro la Rinuncia, perché chi rinuncia si trova, prima o poi, senza vita o addirittura contro la vita. Chi è vicino a noi non capirà: solo noi abbiamo sentito il suono della convocazione. Siamo noi a decidere e niente di quello che ci hanno dato finora può «salvarci», perché il cammino è lungo quanto tutta la nostra anima, sulla cui irripetibile via non ci si può nutrire di nessun’altra provvista se non quella che vi si trova o vi si riceve, perché solo la ricerca di senso rende il senso già presente. Possiamo certo ignorare la chiamata, ma si ripresenterà, con il passare del tempo, più forte e dolorosa, quanto più vicina sarà l’ultima chiamata, quella per cui la Partenza sarà inevitabile. Cacciamo via i guardiani, interni o esterni, dell’assenza di scopo. Andiamo Via-da-qua, via dall’ultimo banco della vita: la Rinuncia. È l’ora della Partenza. Il viaggio sarà (Kafka usa ungeheur, parola tedesca bellissima per estensione di significato e centrale nella sua creazione artistica): enorme, tremendo, spaventoso, immenso, straordinario, incredibile. Proprio come la vita.
«Il denaro è diventato l’unico generatore simbolico di valori. Non sappiamo più che cosa è bello, vero, giusto, santo. Pensiamo solo a che cosa è utile. Ho visto salire una ragazza con un’arpa sul treno Milano-Venezia. Un signore distinto ha cominciato a porle domande. Alla fine l’ha raggelata: “Scusi, signorina, ma qual è il suo business?”».
Per questo costruiamo solo «cristogrill» al posto delle cattedrali?
«Padre David Maria Turoldo celebrò le mie nozze. Sosteneva che le chiese oggi sono ridotte a garage in cui è parcheggiato Dio. Ma la gente per credere ha bisogno della liturgia, del canto, dell’organo, dell’incenso. L’ho detto anche a papa Francesco. E ho aggiunto: Santità, lei ha messo le persone davanti ai princìpi, però ha un polmone solo, lavora come un pazzo, è pieno di nemici; stia attento a non morire, altrimenti dopo ne eleggono uno che rimette i princìpi davanti alle persone. Lui ha riso e mi ha abbracciato, sussurrando: “Si ricordi che Dio salva le persone, non i princìpi”».
Il cardinale Gianfranco Ravasi, suo compagno di liceo, l’ha convertita?
«No, io resto greco. Non mi colloco neppure fra i laici, i quali sono credenti in un’altra maniera. Per me la morte è una cosa seria, mentre i cristiani pensano che dopo vi sia la vita eterna».
Tuttavia sul cristianesimo ha scritto un saggio.
«È diventato la religione del cielo vuoto, ha completamente smarrito il senso del sacro, e questo mi procura tanta rabbia. La dimensione religiosa è essenziale nell’uomo. Perché negare che la fede offra conforto a tante persone?».