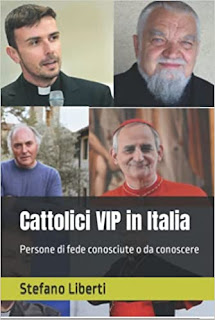I giovani increduli e quelli da provocare
Secondo articolo:I giovani non religiosi non sono ai margini, sono la maggioranza. Non si tratta di una nuova religione, ma di un nuovo soggetto sociale fra le religioni e le credenze giovanili. È una delle rivoluzioni silenziose che sta cambiando il panorama delle nostre società occidentali.Le nuove generazioni hanno un’identità religiosa “altra”, ancora difficilmente definibile. Nella coscienza giovanile confessioni e religioni sono ormai marginali, anche se non in tutte le nazioni. Quelli che le ricerche sociologiche della religione chiamano i nones (da no religion) potrebbero diventare la più forte “religione” in Occidente. La provocazione intellettuale è di Guillame Cuchet (su Études, settembre 2019, pp. 79–92).La discussione sull’orientamento religioso o non religioso dei giovani è assai vivace anche in Italia. Si possono ricordare i volumi di Armando Matteo (La prima generazione incredula, Rubettino 2009) e di Franco Garelli (Piccoli atei crescono, Mulino 2016).Quello ipotizzato da Cuchet è il rovesciamento della lettura ancora prevalente: i non-religiosi non sono ai margini, sono ormai il centro. Da settore periferico sono diventati la coscienza comune delle generazioni giovanili dell’Occidente. Ciò che è ancora difficile decifrare è l’identità di questo corpo sociale che veleggia fra ateismo, agnosticismo, indifferenza, credenza libera. Se è chiaro l’abbandono della pratica e dell’identità confessionale cristiana, molto meno comprensibile è la “pasta” di cui i nones si alimentano.Da decifrare
Si possono identificare alcune radici nelle tradizioni storiche attive in Europa dalla fine dell’800, come i liberi pensatori, i positivisti o gli spiritualisti non cristiani. Diversamente dagli USA in cui la frattura sarebbe più netta.Si possono anche porre dei dubbi sull’affidabilità delle ricerche. Il Pew Research Center parla, ad esempio, di una permanenza religiosa in Europa per il 71% degli abitanti. Si può sottolineare la diversità di appartenenza che emerge dalle inchieste fra i giovani musulmani europei. Il loro consenso alla fede ha caratteristiche assai diverse da quello dei cristiani.Rimangono tuttavia i dati che certificano un addio alla religione dei padri o dei nonni. Negli USA i nones sono il 21%, in Europa il 54%. E, all’interno del continente europeo, sono il 70% nel Regno Unito, il 64% in Francia, il 75% in Svezia, l’80% in Estonia, il 91 % in Cechia. Molto meno in Polonia, il 17%. Essi sembrano confermare l’ex-culturazione del cristianesimo. Si giovano della crescente fluidità delle identità personali (sessuali, politiche, culturali) e della psicologizzazione massiccia delle mentalità, come delle nuove forme di ascesi (alimentari, sportive o neo-orientali).In tale contesto va collocata l’emergenza della presenza musulmana. Se, dal punto di vista della pratica e del consenso, è ormai la seconda religione dei giovani europei, non sembra tuttavia in grado di risultare suggestiva o di riferimento per la grande maggioranza.Nella vasta area dei non religiosi (nones) emerge una disponibilità ad aprirsi ad un’altra storia. La domanda di senso e di spiritualità che li attraversa difficilmente potrà accontentarsi di una posizione critica alla tradizione. La semplice rottura non è indefinitivamente trasmissibile. Ed è su questo fronte che è possibile aprire i tesori della tradizione cristiana, rendendoli comprensibili in un contesto “non religioso”.Cuchet chiude il suo saggio identificando nei nones tre aree prevalenti.La prima è quella dei secolarizzati. Atei e agnostici cresceranno e difficilmente entreranno in dialogo con il cristianesimo.La seconda è quella transizionale: quanti cioè non fanno della loro area non credente il punto di arrivo.Infine, gli spiritualisti che, pur estranei a un credo e alle istituzioni ecclesiali, hanno una forte domanda di interiorità e una spiccata ricerca di senso.
Con i giovani, per riconoscere, interpretare, scegliere: è l’intento della lettera pastorale per l’anno 2019-2020 scritta dal vescovo di Concordia-Pordenone. S’intitola, citando il Vangelo di Luca e il racconto dei due discepoli sulla strada di Emmaus, «... e camminava con loro». Un libretto corposo, quasi un documento, perché, scrive il presule nella premessa, «man mano che procedevo nella stesura, mi sono sempre di più reso conto del variegato mondo degli adolescenti e dei giovani, ricco e pieno di potenzialità ma anche problematico e complesso; stimolante e provocante anche per noi adulti e per le nostre comunità cristiane». Nella lettera — di cui pubblichiamo uno stralcio — trovano spazio alcune riflessioni e pagine dell’esortazione apostolica post-sinodale, ai giovani e a tutto il popolo di Dio, «Christus vivit» di Papa Francesco.
Noi adulti spesso ci riteniamo esperti nel classificare e nell’inglobare tutto e tutti in un’unica cornice. Ci basta dire “giovani” per parlare in modo indistinto del variegato e complesso mondo dei giovani. Per fortuna che i giovani non si lasciano incasellare all’interno dei nostri schemi predefiniti. Questo capita anche nelle nostre comunità cristiane, con l’aggravante che spesso ci rifacciamo a un passato con nostalgia e con le solite frasi: i giovani non sono più come una volta; non partecipano più alla santa messa e alle attività della parrocchia; sono lontani dalla fede e dalle problematiche religiose; non sappiamo cosa fare per ascoltarli e incontrarli perché sono interessati ad altro. Non vale la pena scoraggiarci, piangerci addosso o cercare di chi è la colpa. Importante è prendere coscienza che è giunto il tempo, come ci ricordava il Papa, «di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è sempre fatto così”. Invito tutti a essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori» (Evangelii gaudium, 33).
Con coraggio e con passione, vi invito a non aver paura di ascoltare, incontrare e annunciare agli adolescenti e ai giovani delle nostre comunità la bellezza dell’incontro con il Signore Gesù. Se ci vedono attenti a loro, vicini e preoccupati della loro vita e felicità, saranno capaci di ascoltarci e di accoglierci, permettendoci di entrare nella loro storia. Buttiamoci alle spalle i luoghi comuni e le paure e affrontiamo con serenità la sfida che ci sta davanti. I tempi sono cambiati, ma non è cambiato il cuore dei giovani. Nel passato si ragionava per decenni. Oggi, invece, si deve ragionare a breve termine, quasi di anno in anno. La vita si è fatta accelerata, vorticosa. Timori e paure hanno preso il posto di benessere e certezze. Ecco perché non è facile guardare alle nuove generazioni, che gli studiosi chiamano millennials. È la generazione diventata maggiorenne nel nuovo millennio, dai 18 ai 35 anni, sempre connessi a internet e spesso definiti negativamente.
Non dobbiamo nasconderci che viviamo in una società in profonda crisi, non solo economica, ma di valori e di senso della vita. Sono in crisi le grandi istituzioni, erose dall’individualismo esasperato, dagli interessi di parte, dagli scandali e dalla corruzione, facendo così aumentare, soprattutto nei giovani precarietà e insicurezza. Ne deriva una generazione giovanile delusa, orfana di interlocutori credibili, capaci di ascolto e di mettersi in gioco, capaci, con la loro presenza, di aprire orizzonti e non di alzare barriere e muri. L’inarrestabile globalizzazione ha spostato il baricentro della società ponendolo nel consumismo, motore dell’economia, ritenuto sorgente di benessere e felicità. Così i giovani si trovano appiattiti sul presente, immersi nella “cultura del frammento”, vivendo alla giornata, senza passato e senza radici, senza sogni e passioni. Una cultura giovanile che molti definiscono dell’eccesso, senza nessun limite. Il limite è visto come nemico della vita, capace di tarpare le ali, e pertanto da eliminare al più presto per soddisfare al massimo i desideri del momento. Moderazione, prudenza e temperanza sono vocaboli desueti e impopolari. Ciò porta a mettere al primo posto il piacere a ogni costo, senza fare i conti con le limitazioni del proprio corpo e le regole della società e del vivere insieme. In pochi anni siamo passati da una società che metteva il bene comune al di sopra di tutto a un individualismo esasperato, che mette il proprio io e i propri bisogni al centro. Eliminando così principi e valori oggettivi, i giovani si trovano senza nulla a cui aggrapparsi per orientare la propria vita e le scelte future. “Tutto e subito” diventa lo slogan di tanti che impostano la propria vita privi di costanza e di fatica quotidiana, preferendo il facile all’impegnativo.
Per non fare di ogni erba un fascio, credo importante soffermarmi su un aspetto relativo all’età. Quando talvolta negli incontri e nella visita pastorale, si parla di giovani e di giovinezza, si vede comparire un ventaglio che va dalle scuole medie a uomini e donne maturi. Distinguere è un primo passo, non per dividere o per aumentare la categorizzazione e la frammentazione della pastorale, ma per fare serie e attente riflessioni e proposte sia al mondo degli adolescenti, che ancora sono presenti in parrocchia, sia ai giovani che si vedono sempre meno e che spesso non sappiamo come e dove incontrare e avvicinare. A metà strada tra l’infanzia e l’età adulta, l’adolescenza è un periodo particolare della vita di grandi cambiamenti fisici, psicologici ed emotivi, di tempeste ormonali e di sbalzi di umore e di stati d’animo. A volte la crescita fisica non va di pari passo con la maturazione. È l’età delle scuole superiori, oggi chiamata primaria di secondo grado. L’adolescente mette tutto in discussione volendo essere indipendente e facendo fatica ad accogliere i suggerimenti e gli interventi dei genitori e degli adulti. Si sente già grande, anche se non riesce a fare delle scelte motivate. Alla continua ricerca di punti di riferimento, gli adolescenti li trovano più facilmente nel mondo dello spettacolo, dello sport, della moda e della musica. Per loro è più facile rapportarsi e dialogare con gli amici e i coetanei che con i genitori e gli educatori, che sentono assillanti, sempre con il fiato sul collo, incapaci di ascolto e di ostacolo alla loro libertà. In questa età gli adolescenti fanno fatica a rendersi pienamente conto degli sbagli e di quello che non è giusto fare, perché preoccupati più dell’esserci e di vivere in prima persona, senza condizionamenti, volendo sperimentare, prima di tutto, la faticosa libertà di scegliere. Ecco perché, purtroppo, in questi anni anche nel nostro territorio e in numerose scuole, si verificano di frequente episodi di anoressia, bulimia, vandalismo, bullismo, dipendenze da social network, alcol, droghe.
Tuttavia non è giusto ridurre l’età della adolescenza solo ai problemi che essa pone e che i ragazzi vivono. La progressiva indipendenza che cercano e che iniziano a vivere, volenti o nolenti, è una solida e necessaria base per affrontare la vita e per fare scelte mature e responsabili. Ogni traguardo personale, in positivo e in negativo, sarà di aiuto per il cammino successivo. Finito il ciclo scolastico, i giovani hanno la piena consapevolezza che devono compiere un passaggio fondamentale nella loro vita, con decisioni importanti e scelte di vita da fare. Continuare con gli studi universitari o scegliere una professione, anche se il traguardo di un lavoro stabile si fa sempre più lontano e, talvolta, poco desiderabile. Tutti siamo consapevoli che non è facile offrire una descrizione della realtà giovanile. Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Christus vivit, ci ricorda che esistono molte differenze sociali, culturali e religiose all’interno anche dello stesso paese, tanto da parlare di pluralità di mondi giovanili, aggiungendo che la gioventù non è un oggetto che si può analizzare astrattamente, perché non esiste la gioventù ma i giovani, con le loro vite concrete (cfr. 68; 71).
Un fenomeno interessante e positivo, che coinvolge anche tanti giovani del nostro territorio, lo possiamo individuare nel volontariato e nella generosità di molti di fare qualcosa per gli altri, di perdere del proprio tempo per chi è più bisognoso. A fronte di mille emergenze del territorio (umanitarie, ambientali e sociali), da sempre troviamo giovani che prontamente rispondono alla chiamata e si offrono generosamente per assistere, soccorrere, ricostruire, formando una catena di amore e di solidarietà. Nessuno vive per se stesso e solo per se stesso. Nel servire gli altri, il giovane scopre che la sua felicità e il suo bene dipendono dalle relazioni che ognuno costruisce, custodisce e sviluppa ogni giorno. Un giovane che comprende l’essere debitore verso gli altri sente di avere responsabilità del futuro della società e dell’umanità intera.
C’è una domanda che ritorna spesso nei miei pensieri a cui non sono ancora capace di rispondere: «Perché i giovani del nostro tempo fanno fatica a porsi le domande e gli interrogativi fondamentali della vita? Spesso anche loro si trovano davanti a situazioni difficili e complicate, a eventi drammatici e, dopo un po’, tutto ritorna come prima. Perché non si lasciano provocare in profondità?». Viviamo in un tempo che ha smarrito il gusto di farsi delle domande, forse perché si è perso il senso della vera felicità, scambiata come il semplice star bene, il vivere senza problemi, accontentandoci di qualche soldo e piacere della vita. Qualche anno fa, padre Ermes Ronchi, nel predicare gli esercizi spirituali al Santo Padre e alla curia romana (Le nude domande del Vangelo, San Paolo, 2016), si è soffermato sull’importanza e sulla necessità che ognuno si faccia delle domande e si lasci interrogare dal Signore. Le domande disarmano e aprono al nuovo della vita perché sono un dono inatteso. Le risposte definiscono mentre le domande suggeriscono. Le definizioni chiudono, gli interrogativi invitano ad andare oltre e intraprendere un cammino. La forma del punto di domanda ricorda quella di un amo da pesca, che entra nel profondo del nostro cuore per aiutarci a cercare, a uscire alla luce e vivere in pienezza. La sua forma è anche simile all’artiglio dell’aquila che ti solleva e non ti lascia più. Immagini che ci dicono quanto è necessario avere il coraggio e la forza di porre le domande essenziali della vita. Le domande favoriscono il cammino di crescita della persona perché, progressivamente, aiutano a uscire da se stessi e aprirci agli altri e al “mistero”.
di Giuseppe Pellegrini