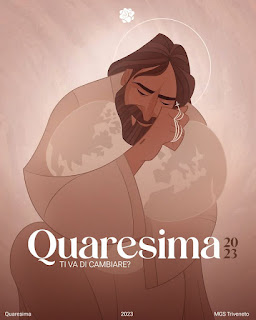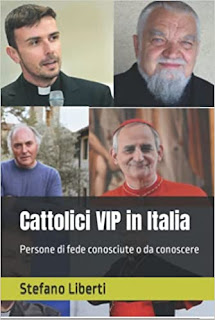L’ideale cristiano e la nostra fragilità
Riprendo le mie riflessioni sulla "vita sessuale tra Chiesa e società"
La Chiesa,
fedele a Gesù Cristo, ci invita a guardare all’orizzonte, alla meta della
nostra vita, all’ideale che ci parla di pienezza, felicità, realizzazione delle
nostre potenzialità e del progetto che Dio ha iscritto nelle nostre membra. Se
lo sguardo deve essere rivolto a tale orizzonte, alzando la testa ed evitando
di rimanere avvinghiati alla terra come galline interessate solo a cercare il
proprio mangime, non si deve dimenticare la fragilità - anch’essa costitutiva
della nostra condizione umana - i limiti, le ferite, gli sbagli, il bisogno di
perdono, di guarigione, di sostegno, di accompagnamento che ogni essere umano
si porta dentro. Non si deve dimenticare che dietro a scelte moralmente
criticabili e oggettivamente sbagliate ci sono persone fragili e con una storia
spesso dolorosa, già ferita da fallimenti e abusi: queste, più che sentirsi
criticate, hanno bisogno di sentirsi accolte, amate, accompagnate, sostenute,
valorizzate. Solo dopo possono (e debbono) essere aiutate a comprendere gli
errori fatti e offrire loro la possibilità di dare una svolta positiva, alta,
bella alla propria vita.
Essere
fedeli all’ideale evangelico non può tradursi in “un
ideale teologico troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano
dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità” delle persone, le
quali vivono in un “cammino dinamico di crescita e realizzazione”[1].
Dio
ha messo questo tesoro – la vita e l’amore - in “vasi di creta”[2],
immagine paolina della nostra fragilità. I giapponesi utilizzano una tecnica
che valorizza i vasi proprio a partire dalle loro crepe: si chiama “Kintsugi” e consiste nel riparare un
oggetto rotto riempiendo la spaccatura con dell’oro. Essi credono che, quando
qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, diventa più bello. Gesù ha fatto
qualcosa del genere: si è chinato davanti ad ogni “vaso rotto” guarendo e
valorizzando le potenzialità insite nella persona. Lo ha fatto facendoci
sentire amati, donandoci la sua attenzione, rialzandoci per farci riprendere il
cammino, indicando la vera meta del pellegrinare. Dopo la Resurrezione Gesù ha
continuato a mostrare le sue ferite come segno distintivo della sua storia
umana, del dono della sua vita, di un amore smisurato, gratuito, vivificante,
offerto a prezzo della sua vita. Le ferite hanno mostrano che abbiamo
combattuto per qualcosa che ne valesse la pena, abbiamo vissuto con intensità,
senza risparmiarci.
Si racconta la
storia di un uomo che era morto e che, salito al cielo, viene accolto da un
angelo che gli dice: “Mostrami le tue ferite”. Egli risponde: “Ferite? Non ne
ho”. E l’angelo a lui: “Dunque non hai mai trovato nulla per cui valesse la
pena di battersi?”. La fede nella resurrezione significa credere che le ferite
che riceviamo non sono mortali e che possiamo correre il rischio di essere
vulnerabili[3].
Più
volte gli avversari di Gesù cercano di metterlo in difficoltà e non è un caso
che ricorrano a casi riguardanti la sessualità umana, come nella discussione
sull’indissolubilità del matrimonio. Gesù risponde invitandoci a non rinnegare l’ideale e, allo stesso
tempo, rispettare la fragilità delle persone concrete che si hanno davanti; a
condannare il peccato, non il peccatore; a tendere alla misura alta,
all’ideale, al sogno di Dio senza negare la possibilità drammatica di fallire.
L’ideale proposto non si pone tanto come regola, ma come obiettivo verso cui
far tendere la nostra esistenza. Non possiamo giudicare l’agire umano a partire
da un ideale altissimo e umanamente irraggiungibile come quando Gesù chiede: “Siate perfetti com’è perfetto il Padre
vostro che è nei cieli”, o, secondo la versione lucana, “Siate
misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli”[4] o in base
all’incapacità di amare i propri nemici e di amarci reciprocamente come lui ci
ha amati. Queste indicazioni sono fari che ci indicano il cammino da compiere,
la direzione da prendere. Così è, a mio parere, per l’amore totale e
indissolubile che è richiesto alla famiglia, la quale si troverà sempre a fare
i conti con i propri limiti e sbagli.
Gesù
è venuto per i peccatori, come un medico che viene per guarire i malati; non ha
disdegnato di condividere la mensa con loro, al punto da essere accusato di
essere un “mangione e un beone”, un “amico dei pubblicani e dei peccatori”[5].
È proprio dall’accusa
di accogliere i peccatori e di mangiare con loro che nascono le tre parabole
della misericordia, l’ultima delle quali è il celebre racconto del Padre
misericordioso e dei suoi due figli. Il figlio maggiore ha l’atteggiamento
intollerante dei farisei e degli scribi: ligi alle regole, escludono e
condannano coloro che le infrangono, rifiutandosi di riconoscerli come
fratelli. Più volte, nei Vangeli, Gesù si scontra con chi si crede giusto e
carica gli altri di pesi insopportabili che, loro, non sono disposti a toccate
nemmeno con un dito[6].
A Gesù non interessa la legge per la legge, ma la salvezza dell’uomo, verso cui
la legge deve mettersi a servizio. Se deve scegliere tra il rispetto del riposo
sabbatico e la carità nei confronti di una persona, non esita a tralasciare il
rispetto del sabato per aiutare gli altri perché “il sabato” (e il discorso vale per ogni altra regola) “è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato”[7].
“Fratelli” – scrive san Paolo – “siete
stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per
vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli
altri”[8]. E ai Corinzi ricorda: “Tutto è lecito! Ma non tutto è utile! Tutto
è lecito! Ma non tutto edifica!”[9]. E ancora: “Siete stati riscattati da Cristo a caro
prezzo; non diventate schiavi degli uomini”[10] (1 Cor. 7,23). E’ inoltre ben
consapevole di come il marasma interiore, a volte autodistruttivo, ci porti a
fare delle scelte che non sempre corrispondono a ciò che sentiamo e sappiamo
essere la cosa giusta e buona da fare:
Io non
riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io
faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io
riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il peccato
che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il
bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti
io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio (Rm 7,15-19).
San Paolo dice di non capire quello che fa, perché sperimenta,
come tutti noi, che ci sono in lui delle spinte che lo inclinano al male e che
non riesce a dominare.
L’esperienza di san Paolo è anche la nostra: quante volte ci siamo proposti di rimanere calmi e pazienti, di non dire neanche una parola e invece, subito dopo, abbiamo perso la pazienza e abbiamo detto quello che non volevamo dire? Quante volte si vorrebbe dominare qualche impulso sensuale e invece vi ci troviamo coinvolti, nonostante la nostra volontà contraria? Siamo allora schiavi dei nostri istinti e dei nostri bisogni? No, ma non possiamo neanche minimizzarne le forze. Abbiamo bisogno di regole che ci tengano in carreggiata, che ci aiutino a realizzare la nostra volontà, le scelte fatte, le decisioni prese. Abbiamo bisogno della “grazia”, cioè di un aiuto divino che ci sostenga e ci illumini nei momenti di buio e di prova (“non abbandonarci alla tentazione”, preghiamo secondo l’insegnamento del nostro Signore). San Paolo non vuole negare o diminuire la responsabilità dell’uomo, ma riconosce la fragilità in cui si trova e che è la causa per cui fa ciò che disapprova e riconosce come male. Questa causa è, secondo la tradizione cristiana, la concupiscenza che proviene dal peccato originale e che è stata acuita dai peccati personali.
L’esperienza di san Paolo è anche la nostra: quante volte ci siamo proposti di rimanere calmi e pazienti, di non dire neanche una parola e invece, subito dopo, abbiamo perso la pazienza e abbiamo detto quello che non volevamo dire? Quante volte si vorrebbe dominare qualche impulso sensuale e invece vi ci troviamo coinvolti, nonostante la nostra volontà contraria? Siamo allora schiavi dei nostri istinti e dei nostri bisogni? No, ma non possiamo neanche minimizzarne le forze. Abbiamo bisogno di regole che ci tengano in carreggiata, che ci aiutino a realizzare la nostra volontà, le scelte fatte, le decisioni prese. Abbiamo bisogno della “grazia”, cioè di un aiuto divino che ci sostenga e ci illumini nei momenti di buio e di prova (“non abbandonarci alla tentazione”, preghiamo secondo l’insegnamento del nostro Signore). San Paolo non vuole negare o diminuire la responsabilità dell’uomo, ma riconosce la fragilità in cui si trova e che è la causa per cui fa ciò che disapprova e riconosce come male. Questa causa è, secondo la tradizione cristiana, la concupiscenza che proviene dal peccato originale e che è stata acuita dai peccati personali.
[1] Papa Francesco, Amoris
laetitia, n.36.
[2] 2 Cor 4,7,
[3] T. Radcliffe, Amare
nella libertà, Qiqajon 2007, p.66-67
[4] Mt 5,48 e Lc 6,36.
[5] Mt 11,19
[6] Cfr. Lc 11,46
[7] Mc 2,27
[8] Gal 5,13
[9] 1 Cor 10,23
[10] 1 Cor 7,23