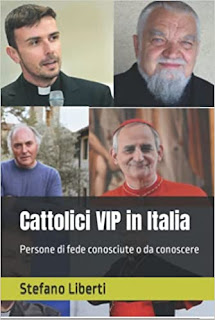Amori tossici (e femminicidi)
Non esiste una “dolce metà” che viene a donarmi una integrità
altrimenti impossibile: siamo esseri unici, interi in noi stessi, anche se
bisognosi di affetto e di calore umano. Dovrebbero convincersene coloro che portano
avanti rapporti dove ci si fa più male che bene, dove si rinfacciano le
mancanze dell’altro più che riconoscerne i pregi, dove si è incapaci di
parlarsi con sincerità per paura di ferire l’altro o, peggio, per paura di essere
feriti e abbandonati, dove la dipendenza affettiva è tale da far perdere ogni
libertà.
Tante coppie si
formano non per scelta, ma per un certo fatalismo; non per pienezza d’amore, ma
per paura di sentire un vuoto affettivo nella propria esistenza. L’incapacità
di saper stare bene da soli spinge le persone a rifugiarsi nell’amore come antidepressivo,
come droga, come sedativo… L’arte di saper stare bene da soli, invece, apre a
un grande privilegio: quello di poter scegliere con chi stare[1].
Il
controllo ossessivo (“Dove sei stata?” “Con chi sei stata?” Perché torni a
quest’ora?” “Chi è quel collega?”) non è amore. Spingerti ad isolarti da tutti
(“Non voglio che ti incontri con le tue amiche, con la tua famiglia”; “Devi
sempre pensare a me”; “Io e te stiamo bene da soli”) non è espressione di un
amore sano. Rinfacciarti sempre ogni colpa (“Sei tu che mi fai innervosire”; “Quando
sono nervoso devi stare zitto”, “Se litighiamo è colpa tua”; “Sei tu che non mi
capisci”) non è amore. Umiliarti (“Sei noiosa come la vita che mi fai fare”; “Guardati,
sei impresentabile!”; “Non sei capace di fare niente”…) non è amore. Tutte
queste situazioni sono piuttosto sintomi allarmanti di un rapporto logoro e
logorante che deve essere risanato o interrotto.
Negli
anni ’80 una psicologa americana, Robin Norwood, scriveva:
Quando giustifichiamo i suoi malumori, il suo cattivo
carattere, la sua indifferenza, o li consideriamo conseguenze di un’infanzia
infelice e cerchiamo di diventare la sua terapista, stiamo amando troppo.
Quando non ci piacciono il suo carattere, il suo modo
di pensare e il suo comportamento, ma ci adattiamo pensando che se noi saremo
abbastanza attraenti e affettuosi lui vorrà cambiar per amor nostro, stiamo
amando troppo.
Quando la relazione con lui mette a repentaglio il
nostro benessere emotivo, e forse anche la nostra salute e la nostra sicurezza,
stiamo decisamente amando troppo[2].
Con
le sue riflessioni ha contribuito allo studio della “dipendenza affettiva”, una
situazione patologica che rende una persone dipendente da un’altra, come fosse
la sua droga. Può confondersi con l’innamoramento, ma ne differisce per durata
e modalità.
Il
dipendente dedica completamente tutto sé stesso all’altro, al fine di
perseguire esclusivamente il suo benessere e non anche il proprio, come
dovrebbe essere in una relazione “sana”. I dipendenti affettivi, solitamente
donne, nell’amore vedono la risoluzione dei propri problemi, che spesso hanno
origini profonde quali “vuoti affettivi” dell’infanzia[3].
Spesso
il soggetto dipendente sceglie partner problematici e segnati da altre forme di
dipendenza. Negando i propri bisogni si pone al servizio completo e senza
riserve del suo amato che deve aiutare o addirittura “salvare”. Ha il terrore
dell’abbandono e il suo aiuto è volto a cercare di rendere l’altro a sua volta
dipendente dal suo aiuto. Ne consegue che non si
è più in grado di uscire da una relazione che si ammette essere senza speranza,
insoddisfacente, umiliante e spesso autodistruttiva. “Si diventa capaci di
giustificare completamente l’altro e di colpevolizzarsi in tutto”[4].
Virginia
era una ragazzina vivace, molto estroversa, piena di amiche. In terza media ha
iniziato ad uscire con il bullo della sua classe: un ripetente che aveva fama
di spacciare ed aveva avuto comportamenti violenti nei confronti di altri
compagni di classe. Ma era bello, affascinante, capace di farla sentire
desiderata e protetta. Come non cadere nelle sue mani? In fondo aveva anche lui
un fondo di dolcezza e lei sapeva che tanti suoi atteggiamenti da duro
nascondevano la sua fragilità e nascevano da una situazione familiare
disastrata. Virginia si era convinta di poterlo aiutare, che con il suo amore l’avrebbe
cambiato. Così non è stato: scene di gelosia e comportamenti violenti avevano
iniziato a minare il loro rapporto. Lui aveva preteso e ottenuto di stare da
soli, l’aveva obbligata ad evitare le sue amiche (del resto, per paura, le loro
madri avevano già imposto che chiudessero quell’amicizia pericolosa). Ma lei gli
voleva bene e lui, tra un litigio e l’altro, sembrava contraccambiare questi
sentimenti. Avevano presto iniziato ad avere rapporti completi e questa
intimità li aveva uniti profondamente… come se fossero incatenati l’uno
all’altra. I genitori di Virginia si sono accorti del pericolo ma, troppo
deboli e incapaci di trovare una soluzione, hanno alternato momenti di durezza
con altri di eccessiva fiducia e tolleranza. Quel ragazzo, di fronte al loro
rapporto in crisi, ha reagito come sapeva fare meglio: minacciando, facendo
scenate, mostrandosi violento, urlando la sua frustrazione. Senza di lei non
era più capace di vivere ed era disposto a tutto pur di non perderla.
Una
storia come tante, questa volta a lieto fine, nonostante le ferite lasciate
nella ragazza ora sedicenne: è rimasta senza amiche, con tante paure, chiusa
spesso in casa, ma viva. Altre sono state meno fortunate di lei, uccise da chi
diceva di amarle troppo. Come Noemi, sedici anni, uccisa dal fidanzato
diciassettenne: un ragazzo con problemi psichiatrici, geloso e violento, ma che
Noemi non voleva o non riusciva a lasciare. Nel suo ultimo post su facebook
aveva condiviso un elenco di situazioni che sono espressione di un amore
malato:
Non è amore se ti fa male. Non è amore se
ti controlla. Non è amore se ti fa paura di essere ciò che sei. Non è amore, se
ti picchia. Non è amore se ti umilia. Non è amore se ti proibisce di indossare
i vestiti che ti piacciono, Non è amore se dubita delle tue capacità
intellettuali. Non è amore se non rispetta la tua volontà. Non è amore se fai
sesso. Non è amore se dubita continuamente della tua parola. Non è amore se non
si confida con te. Non è amore se ti impedisce di studiare o lavorare. Non è
amore se ti tradisce. Non è amore se ti chiama stupida e pazza. Non è amore se
piangi più di quanto sorridi. Non è amore se colpisce i tuoi figli o i tuoi
animali. Non è amore se mente continuamente. Non è amore se ti diminuisce, se
ti confronta, se ti fa sentire piccola. Il nome è abuso. E tu meriti l'amore.
Molto amore. C'è vita fuori da una relazione abusiva. Fidati!.
Ma Noemi non si è
fidata, probabilmente non ci è riuscita. Ogni volta tornava da lui, anche
l’ultima tragica sera in cui il suo giovane amore gli ha tolto la vita.
Sul femminicidio
Ma come
può un uomo, in nome dell’amore, arrivare ad uccidere la donna che dice di
amare e magari uccidere anche i figli che con lei ha generato? Non è una
novità: fino a pochi decenni fa per gelosia o per tradimento si poteva uccidere
ed essere giustificati o almeno condannati con una pena più lieve. Ma che amore
è quello che giunge ad uccidere colei a cui diciamo di voler bene? E’ un amore
deviato, patologico: non voglio il tuo bene, ma solo il bene che tu mi
garantisci. Senza di te non posso più vivere, e allora ti elimino per poter
continuare a sopravvivere.
Michela
Marzano, la filosofa che molto ha parlato di amore (ora anche attraverso un
romanzo dal titolo eloquente: “L’amore che mi resta”[5]),
ha cercato di commentare una drammatica serie di femminicidi che hanno messo
fine alla vita di giovanissime donne. Si chiede: “Cosa sta accadendo ai nostri
uomini? Quale frattura identitaria li rende così fragili e al tempo stesso così
pericolosi?” La sua risposta è che non sanno accettare la frustrazione della
perdita, il vuoto di una vita che sembrava aver trovato un senso nel rapporto
con quella donna.
E’ come – scrive
ancora la Marzano - se la propria felicità e il proprio equilibrio dipendessero
completamente da queste donne-bambine che li fanno sentire importanti e che ,
però, non possono poi andarsene via e lasciarli soli a fare i conti con quel
vuoto che si spalanca. Perché poi è sempre così che succede: quando la persona
amata se ne va via, ci si sente persi, distrutti, soli, frantumati. Si apre il
baratro dell’abbandono e si deve imparare ad andare avanti lo stesso, anche se
all’inizio è difficile e doloroso e sembra quasi impossibile[6].
A chi
la accusa di fare i “salti mortali per non ripetersi, ma anche per non
generalizzare” (effettivamente si tratta di alcuni uomini che non sono capaci
di vivere l’abbandono, non il genere maschile nel suo complesso), risponde
Michele Serra sottolineando come “in una società tendenzialmente no-limits trovarsi di fronte al limite,
per giunta il proprio limite, rende pazzi” e richiederebbe “corsi di
sconfitta”. Perché – prosegue la Marzano – “non è certo un’altra persona a
poter colmare le nostre mancanze o a evitarci le frustrazioni. Il vuoto che ci portiamo
dentro, con un’altra persona, lo possiamo al limite attraversare”. Banalità
certo, ma che mostrano ancora di più la fragilità dei nostri giovani, sempre
più incapaci di affrontare il proprio vuoto e le proprie sconfitte.