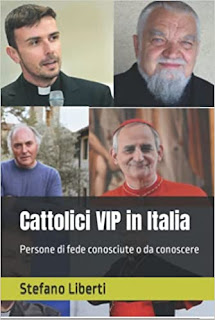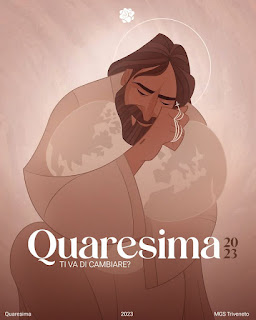Sulla vecchiaia (secondo Enzo Bianchi)
"Il Fatto Quotidiano" del 22 aprile ne ha pubblicato un interessante estratto che è possibile leggere sul blog "Alzo gli occhi verso il cielo". Lo stesso blog propone anche un commento di Recalcati, celebre psicoterapeuta, pubblicato su La Stampa del 13 aprile. Ne riporto l'inizio:
Lasciare la presa: è un’arte non facile, eppure è la prima da esercitarsi nella vecchiaia.Il sito ufficiale del Monastero di Bose propone un testo scritto diversi anni fa in "Le parole della spiritualità" in cui Enzo Bianchi parla sempre della "Vecchiaia":
È l’arte del distacco, del saper prendere una distanza, dell’accettare di non poter più tenere in mano tutte le corde. Questo distacco cambia a seconda delle persone: per alcuni è dovuto alle leggi del lavoro che pongono un termine all’esercizio della professione; per altri dipende da una loro libera scelta. Vi è comunque sempre un’alternativa: continuare come prima, come se gli anni sopraggiunti non avessero un significato e non richiedessero un necessario mutamento, oppure prepararsi ad abbandonare la funzione, il posto, l’occupazione, lasciando ad altri, alle nuove generazioni, la possibilità di subentrare e di portare avanti ciò che per noi umani resta sempre inadempiuto.
Arrivare a dire "grazie'' per il passato e "sì'' al futuro significa compiere un'operazione spirituale veramente essenziale.
«Io individuo quattro motivi per cui la vecchiaia sembra triste: primo, perché allontana dall' attività; secondo, perché indebolisce il corpo; terzo, perché nega quasi tutti i piaceri; quarto, perché non dista molto dalla morte.» A questo giudizio di Cicerone (De senectute), oggi noi potremmo aggiungere un ulteriore motivo che rende penosa la vecchiaia. Ed è questo: l'era della tecnica ha spiazzato e reso fuori luogo l'adagio che legava vecchiaia e sapienza e vedeva nell' anziano il depositario di una memoria, di un'esperienza che lo rendeva elemento fondamentale nel gruppo sociale. La «sapienza dell'anziano» pare relitto di un passato ormai remoto oppure ancora presente in civiltà non toccate dal progresso tecnologico e informatico che ci paiono ancora più distanti. L'anziano, nel contesto di una società che esalta la produttività, l'efficienza e la funzionalità, si trova emarginato, reso superfluo, inutile, e spesso egli stesso «si sente di peso» ai familiari e alla società. In simile contesto la vecchiaia appare come un passaggio faticoso da una condizione in cui si è definiti dal lavoro o dal ruolo sociale, a una sorta di zona morta di pura negatività, la «pensione», un limbo in cui si è definiti da ciò che non si è più e non si fa più.
Per quanto il discorso sulla vecchiaia sia in realtà un discorso plurale che deve diversificarsi in ogni anziano prestando attenzione alle particolari situazioni di salute fisica e mentale in cui ciascuno si viene a trovare, è pur vero che la vecchiaia è vita a pieno titolo, è una fase particolare di un cammino esistenziale, non una mera anticamera della morte. «La vecchiaia si offre all'uomo come la possibilità straordinaria di vivere non per dovere, ma per grazia» (K. Barth). Già di per sé essa è uno stadio della vita che non tutti arrivano a conoscere: lo stesso Gesù non ha conosciuto la vecchiaia. Dunque essa è anzitutto un dono che può essere vissuto con gratitudine e nella gratuità: si è più sensibili agli altri, alla dimensione relazionale, ai gesti di attenzione e di amicizia; inoltre è la grande occasione per operare la sintesi di una vita. Arrivare a dire «grazie» per il passato e «sì» al futuro significa compiere un' operazione spirituale veramente essenziale soprattutto in vista dell'incontro con la morte: l'integrazione della propria vita, la pacificazione con il proprio passato.La vecchiaia è così il tempo dell'anamnesi, del ricordo, e del racconto: si ha il bisogno di narrare, di dire la propria vita, per poterla assumere vedendola accolta da un altro che la ascolta e la rispetta. E questo racconto può divenire trasmissione di un' esperienza di fede: il Salmo 71, la «preghiera di un vecchio», ne è un bell'esempio. Nell'indubbia decadenza fisica e mentale, nel venir meno delle forze, nella riduzione delle possibilità che la vecchiaia comporta vi è però anche la possibilità di affrontare in modo più diretto le domande che la vita pone, senza le evasioni e le illusioni che le molteplici attività potevano consentire quando si era più giovani. Che cosa valgo? Che senso ha la vita? Perché morire? Che significano le sofferenze e le perdite di cui l'esistenza è piena? E anche la domanda religiosa, anche la fede può acquisire coscienza e profondità: «Finché era più giovane, l'uomo poteva ancora immaginarsi di essere lui stesso ad andare incontro al suo Signore. L'età deve diventare per lui l'occasione per scoprire che invece è il Signore che gli viene incontro per assumere il suo destino» (K. Barth).Vi è dunque un proprium di ciascuna fase della vita: anche di fronte alla vecchiaia si tratta anzitutto di accettarla pienamente e questo consentirà di non viverla come tempo di rimpianto e di nostalgia, ma di coglierla come tempo di essenzializzazione e di interiorizzazione proprio all'interno di quel movimento di «assunzione della perdita» che assimila la vecchiaia a un movimento di kénosi. «Ciò che la giovinezza troverà al di fuori, l'uomo nel suo meriggio deve trovarlo nell'interiorità» (C. G. Jung). Lì si svela la fecondità possibile della vecchiaia (cfr. Salmo 92, 15: «Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi»), una fecondità manifestata nella tenerezza e nella dolcezza, nell' equilibrio e nella serenità... È il tempo in cui una persona può affermare di valere per ciò che è e non per ciò che fa. Ovvio che questo non dipende solamente da lui, dall'anziano, ma anche e particolarmente da chi gli sta intorno e dalla società che può accompagnarlo nel compito di vivere la vecchiaia come compimento e non come interruzione O come fine. Anzi, la vecchiaia è un momento di verità che svela come la vita sia costitutivamente fatta di perdite, di assunzione di limiti e di povertà, di debolezze e negatività. La vecchiaia, ponendo l'uomo in una grande povertà, lo mette anche in grado di cogliersi nella sua verità, quella che si svela al di là di ogni orpello e di ogni esteriorità. Forse non è un caso che, per Luca, il Vangelo si apra con due figure di anziani: Simeone e Anna che riconoscono e indicano Gesù come Messia. L'anziano fa segno, indica, trasmette un sapere. Ed è, con la sua vecchiaia pacificamente assunta davanti a Dio e davanti agli uomini, un segno di speranza e un esempio di responsabilità.A recensire il libro interviene anche la biblista Rossana Virgili su Avvenire: "Enzo Bianchi: La vecchiaia non è un viaggio nel deserto":
Interessante- a mio avviso - anche un'intervista ad Enzo Bianchi pubblicata su Il Sole 24 ore il 14 gennaio scorso: Enzo Bianchi: «Coltivo la vita, il silenzio, la speranza»:«Il contatto con i vecchi non è disdicevole e tenere i bambini lontano da loro quando non sono più autosufficienti significa non trasmettere il senso e l’esperienza della vita a chi dovrà affrontarla. Ci renderemo conto, prima o poi, cosa può significare la rimozione dei vecchi e della loro condizione dal tessuto quotidiano »? Con questa domanda Enzo Bianchi pone, nel cuore del suo nuovo libro dedicato alla vecchiaia – La vita e i giorni (Il Mulino, pagine 138, euro 13) – la questione centrale che preme sul lettore. Dopo aver introdotto gli anni della vecchiaia attraverso la metafora delle stagioni, quindi descritto una sorta di fenomenologia delle sue manifestazioni fisiche e morali, dato una serie di citazioni dal “grande Codice” della Bibbia de senectute, Bianchi impone l’urgenza di una riflessione: quella dell’importanza della prossimità alla vecchiaia, alla finitezza, all’esperienza del limite. Rispetto a un tema che viene trattato con estrema sobrietà, specialmente in Italia, dove le pubblicazioni a esso dedicate sono pochissime – a fronte di una percentuale di popolazione di over sessantacinquenni che sfiora il quinto di quella complessiva! – o ad ardite affermazioni antropologiche d’oltralpe che postulano la scomparsa della vecchiaia (si pensi alla vecchiaia come “interluogo” di Marc Augè, in Il tempo senza età. La vecchiaia non esiste), la penna di Enzo Bianchi si esprime con il caratteristico coraggio e candore e con una naturalezza persino più dolce rispetto ad altri temi da lui già trattati.La lettura proietta una visione dell’esperienza diretta dell’autore che ne compone, ad un tempo, un duplice racconto: quello della memoria della vecchiaia degli altri, filtrata dai suoi occhi di ragazzo, e quello del suo stesso corpo che, nell’attualità, la esperisce descrivendo la realtà con uno sguardo laico, privo di ogni sorta di retorica, ma anche intento a scavare significati nuovi e profondi. L’introitus conferito alla metafora delle stagioni crea una cornice di pace e di armonia su tutte le età, compresa quella dell’autunno che viene a dare i suoi gialli dorati, i violacei, i rossi sanguigni sui pampini privati dei loro grappoli, sulle colline del Monferrato, dove l’autore è nato. Le sagome dei vecchi che tralucono dagli occhi infantili sono quelle dei nonni seduti accanto ai nipotini vicino al fuoco che si accendeva nelle case appena fatta notte e che attendeva una lunga serata in cui tutti si scaldavano insieme sia del camino, sia della compagnia delle parole e della vita comune. Benché siano concretamente poche le righe in cui viene descritta quella vecchiaia, quell’immagine antica segna la mente del lettore di straniante nostalgia e ne rivela la grande – e notata – distanza col presente in cui «i nonni sono presenza utile, ma saltuaria» e quella prossimità affatto familiare è divenuta impensabile.Con i piedi per terra, senza alcuno sconto alle facili illusioni che vorrebbero esorcizzare i fantasmi di un “paese che non è per vecchi” – come al contrario avviene, ahimè, troppo spesso e in varie maniere – le pagine cominciano a condurre, lievemente, al futuro che vuol dire “prepararsi” a quell’esodo che è la vecchiaia, vivendola piuttosto come un «compito e una sfida», come un tempo propizio per curare la vita interiore e, per chi è credente, per imparare a sperare nell’eternità. «Speranza folle? Ma è quella che nasce dalla fede e si nutre della convinzione che qualcosa di eterno lo abbiamo vissuto nella nostra vita: l’amore». Ed è proprio su questo snodo che appare lo spunto illuminante del messaggio di questo libro: sul fatto che la vecchiaia non si vive da soli, ma «si costruisce insieme (…) ognuno di noi è chiamato ad commoriendum et ad convivendum », secondo la parola di Paolo ai Corinti ( 2Cor 7,3). Che la vecchiaia non può essere un viaggio solitario nel deserto; deve, invece, innestarsi in un ordo amoris umano e divino. Qui sta la sapienza di questo piccolo, ma grande libro. Che sì, come dice il citato García Márquez: «La morte non arriva con la vecchiaia, ma con la solitudine».Una sapienza che affonda le sue radici nella “vecchiaia” della nostra civiltà: «Non è buono che l’essere umano sia solo» recita la Genesi biblica (2,18) e ancor qualche millennio prima di essa, uno dei racconti più antichi del mondo descriveva proprio l’imbarazzo della morte e il desiderio di sfuggire alla vecchiaia con il mito dell’eterna giovinezza (N.K.Sanders, a cura di, L’epopea di Gilgamesh). Una pianta che si chiamava: “Vecchio ringiovanisci” e che cresceva sui fondali di un mare remoto di acque di morte e che un re di nome Gilgamesh andò a cercare giungendo fino a trovarla. Ma curioso è ricordare perché lo fece: non per sé stesso, non per cancellare le rughe della sua stessa fronte e apparire più giovane, ma per amore del suo migliore amico. Vedendo il corpo tanto amato di lui iniziare a corrompersi, il re di Uruk iniziò il suo viaggio. Tutto nasce e vive soltanto per amore: la vita, i giorni, la fede e pure l’eternità. Quel rifiorire della luce – mediterranea! – che il delizioso testo del monaco di Bose ricorda come tipica invocazione di chi sta per morire. Come quella che brilla negli occhi di due vecchi che continuano ad amarsi, nonostante i tradimenti e i dolori degli anni, con tenerezza di grazia, senza età. «Ecco cosa mi è permesso di sperare e non solo a me cristiano, ma a tutti gli umani, religiosi o no: l’amore che vince la morte è un messaggio che vale la pena di vivere già qui e ora». Una stupenda conclusio.
Il sole del primo mattino riscalda la terra gelata. Cielo terso. La brina colora di bianco i prati, sulla strada che porta al Monastero di Bose, prime colline del Biellese. Il parcheggio anche nei giorni feriali è pieno di auto dei visitatori che vengono su dalla pianura. Attratti da questo luogo dove il lavoro e il silenzio sono la regola. La diversità un valore. Enzo Bianchi vive qui.Teologo, scrittore, ascoltato da Papi e ricercato nei caminetti televisivi della domenica sera («più di una volta l’anno non accetto di andare in tv»). Ha fondato questo monastero post conciliare di vita comune tra cattolici, ortodossi e protestanti nel 1965. Non è mai voluto diventare sacerdote. Ma è rimasto laico. Un fratello. Il prossimo 3 marzo, Enzo compirà 75 anni. Già da un anno ha lasciato il priorato ai fratelli più giovani. Quando è qui e non è in giro per il mondo per le sue conferenze, vive tra gli spazi stretti della comunità e la sua cella: una casetta in cima alla collina, ai margini del bosco, che domina la pianura. Continua a scrivere, a studiare. Coltiva il suo orto, contempla la natura. «Camminare è essenziale per me. Quando cammino vivo con più consapevolezza il fatto che la nostra esistenza è un cammino. Andare a piedi ti aiuta a contemplare. Ti aiuta a sviluppare l’attenzione alle cose e agli altri. Lo stupore. La curiosità». Quando si trova in qualche città cerca sempre di passeggiare. Il modo migliore per conoscere un posto. «Mi piace perdermi nelle città che non conosco, osservo la gente, le case. Guardare mentre cammini aiuta a discernere. E porta alla prossimità. Ti avvicina all’altro da te. Persone o cose». Qui a Bose il suo percorso preferito è il sentiero che porta fin su alle serre, accanto ai grandi sassi che contengono la massicciata di terra. «Tante volte mi appoggio a quelle pietre esposte al sole. Mi rimandano il loro calore. In certo senso anche le pietre mi comunicano vita. E io lo sento. Sento il loro calore. Pensare alle cose e alle persone. Avvicinarsi ad esse fino ad avere una forma di contatto mi aiuta a dare un senso alla vita. A sentirmi parte del tutto».
L’inverno è la stagione del pane che lievita al caldo, del focolare, della notte che viene presto, della neve e del freddo. «Ultimamente, con l’avanzare dell’età, come le foglie che si seccano e cadono giù, passo sempre più spesso giornate solitarie. Provo due sentimenti. Il primo è la tristezza di doversene andare: io amo la vita. La vita è buona. Questa prospettiva mi rende triste. Non sono contento di morire e la morte mi fa ancora paura. Il secondo sentimento che provo è quello di vicinanza alle persone, gli animali, le cose...». Mentre lo racconta entra nella stanza Saba, un cagnolino trovatello adottato dalla comunità. Si accuccia accanto a lui. Dopo un po’ sale su una sedia vuota. Regale prende il suo posto come la regina biblica da cui prende il nome. «Mi segue ovunque e mi fa un’enorme compagnia. Sapere che non sono solo mi sprigiona dentro una gioia senza fine».
Quando si diventa anziani diventa importante il contatto. Il corpo va riconosciuto. «Il vero incontro con un malato terminale non è quando gli parli ma quando gli fai una carezza. L’amore fraterno, umano, deve essere vissuto nella carne, nel corpo. Non può essere un sentimento astratto». Detto da un monaco suona un po’ rivoluzionario, dopo secoli di repressione della corporeità di certo cristianesimo, non vissuto nelle sue implicazioni umane e sociali.
Enzo Bianchi gira l’Italia e spesso è all’estero per presentare i suoi libri e portare le sue parole di saggezza. Ma nei tre mesi invernali, da vent’anni ormai, rifiuta tutti gli inviti pubblici. «Non faccio conferenze». Resta a Bose. «Sono tre mesi di silenzio. Seguo le stagioni. Scrivo. Penso e mi serbo del tempo per me».
Il nostro incontro di oggi è un’eccezione. Lui predilige i rapporti umani, l’incontro con le persone. La cosa stupefacente per un uomo della sua età è che non disdegna i rapporti virtuali attraverso i social network: ha un profilo molto seguito su Twitter dove ogni giorno lui stesso posta un “cinguettio”: «Tra le 20 e le 24 scrivo un pensiero sulla giornata che si è appena conclusa». Ha 24mila follower e ogni tweet raggiunge 40- 50mila visualizzazioni. Nutrire il cuore delle persone con il digitale. «Non faccio niente di speciale. Scrivo un pensiero di sapienza umana. E ricevo ogni giorno dalle 180 alle 200 risposte: “Avevo bisogno di questo”. “Mi dai fiducia”. “Mi dai speranza”. “Mi ricordi le cose essenziali”. Quando scrivo un pensiero religioso i commenti arrivano a 500. A volte arrivano anche insulti, come quando parlo dei migranti. Mi danno del musulmano. Qui a Bose ne ospitiamo sei di migranti. Senza pigliare un soldo dallo Stato». Musulmani in un monastero cristiano. Semi di convivenza pacifica e di dialogo.
L’unica regola che vige a Bose è il silenzio. Ci sono momenti in cui si lavora o si pranza accanto a monaci e monache, ma restando in silenzio. A terra ci sono cartelli che vietano di infrangere il silenzio e di accedere in certe aree della comunità, come i divieti che impediscono alle auto di entrare nei centri storici delle città. «Il silenzio è il mezzo per entrare dentro sé». La campana suona alle 8 di sera. Tutti i monaci entrano nelle celle e «facciamo silenzio fino all’alba. Noi abbiamo 12 ore al giorno di solitudine». Nelle celle non ci sono né tv né computer. «C’è la solitudine che serve per la vita interiore. Per andare in profondità. Altrimenti il celibato diventa una castrazione. La solitudine ti fa conoscere i nostri abissi. Il monachesimo ti fa conoscere l’ateismo. Il nulla che a volte ci abita. Esperire a questi momenti e poi risalire è una grande esperienza».
In tanti salgono fino a Bose durante l’anno, più che per ascoltare per essere ascoltati. Persone che cercano di entrare in contatto con se stessi. «A volte arriva qualcuno per confessare dei peccati terribili. Abissi innominabili tanto che si vergognano di confessarsi nelle chiese. Alla sera quando mi capita di incontrare qualcuno così mi sento esausto». La società sempre connessa ha bisogno di questo, forse. Di un contatto, di parlare, di un incontro, di riconciliarsi. Dei tanti che vengono qui ogni anno il 60% sono cristiani, il 40% non credono. Tutti chiedono di essere ascoltati.
Barba bianca lunga, ben curata. Gli occhi fondi e blu. Le mani grandi che parlano dell’amore per la terra. La cella ai margini del bosco, il suo regno. Nella piccola casetta c’è un tavolo davanti a una grande finestra che si apre sulla pianura. «Nella notte son lì da solo davanti alla vetrata. Vedo le luci di Vercelli, vedo Novara fino al chiarore di Milano. E immagino tutta la gente che va a dormire, le pene che portano, le fatiche del giorno appena passato, i malati. Quella visione mi suscita una preghiera spontanea. La preghiera diventa facile, sorge da dentro».
Davanti alla cella ci sono tanti alberi. Un ulivo che ha piantato lui stesso anni fa e che ogni inverno lo fa palpitare «perché temo non sopravviva al gelo». E poi dei roveri. Grandi querce. «Ce n’è una che ha almeno 500 anni». Mentre ne parla si illumina come per un figlio, mi mostra sul telefonino una foto con lui che abbraccia la vecchia quercia: prova a cingerla con le braccia ma non vi riesce, arriva solo a metà della circonferenza di questo albero maestoso. «Quando vado da lei l’abbraccio. È una fonte di comunione per me. Io adesso ci sono. Quando me ne andrò lei, la grande quercia, resterà ancora qui. Ed era qui prima che arrivassi. Mi dà senso alla vita». Ha un piccolo orto che cura personalmente. «Coltivare per me è molto importante. Mi dice che la vita trionfa, così come l’amore vince sulla morte». Ora sta scrivendo un libro sulla vecchiaia. «Ci lavoro da un anno ormai, uscirà in primavera». Parla di come si può viver bene anche da vecchi: «È un libro esistenziale, non un saggio, a partire dalla mia esperienza. È tutto parte dello stesso gioco: accettare il tempo che passa».
Sul momento difficile che sta vivendo il mondo con i conflitti, le guerre religiose, gli attentati terroristici, confida di avere molta paura. «Da 20 anni avanziamo a piccoli passi verso la barbarie. Il disprezzo per gli avversari, gli uni contro gli altri, ti dice della corruzione di un clima. Quando c’erano le ideologie il mondo era diviso in due ma il rispetto per l’avversario c’era sempre. Ora è tutto frammentato da tensioni xenofobe e localistiche che sono delle vergogne, da indifferenza più assoluta. Temo il rancore degli scarti della società contro di noi». Quello che è avvenuto in Francia con le banlieue e con gli attentati dei giovani immigrati di seconda generazione che diventano terroristi. «Ma abbiamo anche noi una responsabilità: dove piglia le armi l’Isis? Gliele diamo noi. Questa è la follia umana. Dopo i disastri delle due guerre mondiali nel Novecento siamo tornati al punto di partenza. Non accendo più la tv perché persino nei talk show per le casalinghe è solo violenza verbale».
Una speranza? «L’umanità ha la forza per risollevarsi. Il progresso non è accrescimento sempre. La storia ce lo insegna. Noi proveniamo dagli animali. L’uomo è cresciuto grazie al suo spirito e alla sua mente. Ci vuole una insurrezione delle coscienze e degli animi per dire basta a questa barbarie. Intanto cominciamo a mangiare insieme e a dividere la tavola. Fare famiglia. Vuol dire contribuire, nel nostro piccolo, a far avanzare l’umanità».