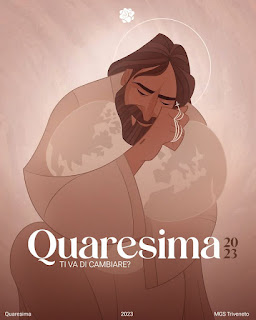Padre Pino Puglisi a 25 anni dal martirio. Video e riflessioni varie
Papa
Bergoglio è appana tornato dalla Sicilia, il 15 settembre, dove è andato per ricordare don Pino Puglisi, il prete
di Brancaccio ucciso dalla mafia 25 anni fa, nel giorno del suo compleanno: era
il 15 settembre 1993. Aveva 56 anni.
Padre Antonio Maria Sicari, che da anni ci dona splendide sintesi
storiche e spirituali di vite di santi, ha dedicato al sacerdote siciliano un
capitolo del suo volume Ottavo libro dei ritratti di santi, edito da Jaca Book,
Milano, 2004.
Ripresentiamo questo testo, perché risalti ancor più tutto lo spessore spirituale che ha dato forza alle scelte di don Puglisi (1937-1993).
Ripresentiamo questo testo, perché risalti ancor più tutto lo spessore spirituale che ha dato forza alle scelte di don Puglisi (1937-1993).
«Cristo è nei suoi martiri», dicevano i
primi cristiani, convinti che quei primi «santi» (titolo che allora era
attribuito soltanto a chi testimoniava la fede col sangue) fossero il
prolungamento dell’umanità di Cristo.
Poi, cessata l’epoca delle persecuzioni, il martirio divenne più raro, ma sembrò evidente che la stessa santa testimonianza poteva essere data con una adesione umile e quotidiana alla persona di Gesù e col compimento generoso della sua volontà.
Ai nostri giorni un’altra evidenza si sta imponendo: i credenti possono essere perseguitati non solo con forme estreme, che esigono la testimonianza esplicita e coraggiosa data in un atto supremo e conclusivo, ma in giorni e giorni di ostilità crescente, di ricatti sistematici, di minacce certe anche se non chiaramente definite.
Possono essere metodicamente aggredite la fede del cristiano, la sua carità, la sua fame e sete di giustizia, la sua passione per la verità, la sua affezione alla Chiesa. E il martirio può accadere in mille forme, anche anonime: a volte il martire è un volto indistinto tra centinaia di altri volti ugualmente sfigurati; a volte il martirio è nascosto in una morte apparentemente casuale che però è stata accuratamente programmata o anche solo sollecitata dai persecutori; a volte il «sì» del martire a Cristo è nascosto nel no che egli dice ai violenti di questo mondo. Già all’inizio degli anni Cinquanta del XX secolo Charles Journet, un celebre teologo, avvertiva: «Può accadere che l’epoca in cui siamo entrati conoscerà una forma di martirio molto povera, molto spoglia, senza nulla di spettacolare per la fede della comunità cristiana — dato che lo spettacolare sta passando tutto nel campo della Bestia —, un epoca in cui sarà chiesto ai martiri, prima di morire corporalmente per Cristo, d’essere avviliti e di rinunciare alla gioia di poter confessare Gesù in faccia al mondo». Tutto questo dobbiamo premettere parlando del «martirio» di padre Puglisi. Non tocca, infatti, a noi anticipare il giudizio della Chiesa, che è ancora in formazione. Tuttavia abbiamo già delle indicazioni molto significative.
Fu lo stesso padre Pino a rivelare la sua anima e la sua disponibilità cosciente al martirio. Lo fece un anno prima di morire, intervenendo a Trento, al convegno annuale del movimento «Presenza del Vangelo»:
«La testimonianza cristiana è una testimonianza che diventa martirio... Dalla testimonianza al martirio il passo è breve, anzi è proprio questo che dà valore alla testimonianza... Il testimone è testimone di una presenza del Cristo presente dentro, anzi dovrebbe diventare trasparenza di questa presenza. E testimonia la presenza di Cristo attraverso la sua vita vissuta proprio con questo desiderio costante di vivere in perfetta comunione con Lui, sempre più profonda con Lui, in una fame e sete di Lui... Essere testimone soprattutto per chi conserva rabbia nei confronti della società che vede ostile... A lui il testimone deve infondere speranza... facendo comprendere che la vita vale se è donata...»
Dopo la morte, i più autorevoli giudizi sulla sua vicenda non faranno che riprendere questa anticipata confessione.
«Padre Puglisi è morto per avere avuto fame e sete di giustizia», dirà il suo arcivescovo.
«Padre Pino Puglisi fu un coraggioso ministro del Vangelo», dirà il papa.
Nella vita di questo umile prete palermitano non ci fu un giorno preciso in cui gli fu chiesto di rinnegare Cristo, e nel quale egli poté offrire gloriosamente la sua vita. Ci fu, invece, un’intera esistenza sacerdotale, durante la quale egli imparò ad amare Cristo più di se stesso e ad amare «tutto ciò che è di Cristo». Così quando. negli ultimi anni della sua vita, gli affidarono parrocchiani, vittime abituali del sopruso dei violenti, egli li difese — parlando con chiarezza e agendo con efficacia — rimettendo a Dio la cura della sua vita ripetutamente minacciata, fino a quando gliela tolsero in un istante, nascondendo l’arma dietro un finto gesto di rapina.
Fu un «martirio povero», simile a quello dell’Eucaristia — pane spezzato e sangue versato — che si lascia consumare ogni giorno. Il suo sacrificio resta indubbiamente legato alla lotta contro la mafia, ma egli non fu sconfitto in una lotta programmata contro un qualsivoglia nemico. Egli combatté semplicemente la buona battaglia del suo sacerdozio. E quando incontrò il Male lo avversò con tutte le sue forze per difendere i suoi figli. Morì per loro, in una strada della sua parrocchia, ma il suo sacrificio gettò una luce nuova su un fenomeno sociale che non era solo quello di semplice criminalità organizzata — come molti pensavano — ma era piuttosto l’adesione sistematica a un vero e proprio «regno del peccato». In Sicilia era già risuonato il «grido del cuore» di Giovanni Paolo II, improvvisato nella Valle dei Templi ad Agrigento: «Dio ha detto: non uccidere! L’uomo, qualsiasi agglomerazione umana o la mafia, non può calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili: convertitevi! Per l’amore di Dio! Mafiosi convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio e dovrete rendere conto delle vostre malefatte».
Era il maggio del 1993. Due mesi dopo la mafia avrebbe risposto mettendo una bomba davanti alla cattedrale del papa (S. Giovanni in Laterano) a Roma. Altri due mesi e avrebbe decretato l’uccisione dei prete palermitano. Si scoprirà poi che in ambedue i casi gli esecutori appartenevano al «gruppo di fuoco» della mafia di Brancaccio, paese natale di padre Pino! Sarà riflettendo sull’assassinio di padre Pino Puglisi (e sugli orrori che dietro ad esso si nascondevano) che i vescovi di Sicilia arriveranno non solo a condannare la criminalità mafiosa e i suoi delitti, ma a proclamare assieme e ufficialmente: «L’incompatibilità col Vangelo è intrinseca alla mafia, per se stessa, per le sue motivazioni e per le sue finalità, oltre che per i mezzi e per i metodi adoperati. La mafia appartiene, senza possibilità di eccezione, al regno del peccato e fa dei suoi operai altrettanti operai del Maligno».
Padre Pino non aveva a difesa e a stimolo del suo operato un simile autorevole pronunciamento. Al contrario, fu il suo martirio a provocarlo. Così un semplice sacerdote, con la sua carità senza confini e senza paure, accelerò l’elaborazione di un giudizio che per la Chiesa era ormai necessario e improrogabile. Obbedendo alla sua missione sacerdotale «fino all’effusione del sangue», egli non svelò soltanto l’iniquità dei violenti, ma accrebbe la coscienza e il senso di responsabilità della sua Chiesa.
Padre Pino Puglisi aveva passato a Brancaccio solo la prima infanzia, trascorsa in una famiglia di buoni cristiani, che non gli mise ostacoli quando a 16 anni decise di entrare in seminario. I suoi studi durante la guerra erano stati precari, aveva trascorso molte ore sui campi o aiutando il papà nella bottega di calzolaio, ma aveva incontrato un prete buono e dotto che l’aveva aiutato privatamente nello studio del greco e del latino, necessari per intraprendere gli studi liceali. Ricevette il suddiaconato a 21 anni, ed era il tempo in cui i giovani seminaristi dovevano scegliere definitivamente per il celibato.
Sulla tradizionale immaginetta-ricordo Pino fece scrivere: «Accetta, Signore, l’olocausto della mia vita» e, poiché assieme agli studi di greco gli era venuta la passione per le etimologie, aveva annotato: «Olocausto vuoi dire bruciare tutta la propria esistenza sull’altare della Croce». Aveva scelto, dunque, quell’espressione, con pienezza di coscienza. Profezia?
Noi pensiamo che si tratti piuttosto di quel misterioso gioco in cui Dio, a volte, ci coinvolge: ci fa chiedere qualcosa di grande, di estremamente impegnativo, di cui non comprendiamo bene le conseguenze, e poi ci esaudisce. Egli agisce con noi come i buoni genitori fanno con i loro bambini: accettano seriamente e con gratitudine delle promesse che i piccoli fanno in maniera un po’ sventata, e poi le usano pedagogicamente per aiutarli a crescere.
Di fatto, padre Pino, nel giorno in cui si offrì — corpo e anima — al suo Signore, chiese anche di poter essere «consumato interamente» e oggi noi sappiamo che fu esaudito. Fu ordinato prete (nel santuario della Madonna dei Rimedi) quando non aveva ancora 23 anni. Il primo decennio di sacerdozio lo passò come viceparroco nelle periferie, e lavorò come cappellano in un istituto di orfani. Come accade a tutti i giovani preti, si interessava soprattutto dei ragazzi. Ma gli veniva anche spontaneo, già allora, appoggiare le rivendicazioni della povera gente che in quegli anni veniva ammassata in «villaggi popolari», tirati su alla meno peggio, senza acqua, né luce, ne strade, né scuole o servizi d’alcun genere. Evidentemente i benpensanti non mancarono di accusarlo d’essere «un prete rosso». La vera passione di padre Pino (che l’accompagnerà sempre) era quella di “educare” i giovani, anche se i suoi tentativi si scontravano, a volte, con le incomprensioni di qualche vecchio parroco che non ne condivideva i metodi. Erano gli anni tumultuosi del Concilio Ecumenico Vaticano II e delle prime contestazioni postconciliari, tutti parlavano di dialogo e di aggiornamento, ed egli annotava: “Un prete deve saper dialogare su quattro fronti: con la realtà, con gli altri, con se stesso e con Dio”.
Si interrogava su “come parlare di Dio ai giovani» per riuscire «ad entrare in comunicazione con il loro mondo». Si interessava delle vicende dei santi e del loro metodo pedagogico (l’affascinava soprattutto san Giovanni Bosco). Precisava le sue idee sulla Chiesa («La Chiesa è un’assemblea di persone che pregano... Può essere edificata solo pregando e studiando, celebrando e discutendo, amando e lavorando...»). Si riprometteva di rapportarsi con ogni uomo in base alla «vocazione fondamentale» di ciascuno, quella di «entrare in comunione con Dio, un Dio che è amore ed è pieno di tenerezza»; ed era deciso a muoversi apostolicamente con libertà, fedele all’indicazione di papa Giovanni XXIII, che esortava i cristiani «a non confondere mai l’errore con l’errante».
Era insomma un giovane prete entusiasta che non temeva di sbilanciarsi sul terreno della carità e dell’impegno sociale, e su quello della creatività pedagogica. Evidentemente non piaceva a tutti e infastidiva gli amanti del quieto vivere. Così, quando il cardinale di allora, dimissionario, lo inviò parroco a Godrano (una sperduta frazione di Corleone, a 740 metri di altitudine), dove nessuno voleva andare, ci fu chi pensò a una meritata punizione.
Padre Pino accettò: «Non sono figli di Dio anche quelli di Godrano?», disse, e annunciò con umorismo agli amici che era divenuto «il parroco più altolocato della diocesi». Al paese trovò una chiesetta danneggiata dal terremoto, frequentata da tre vecchiette di numero, e una canonica lesionata e gelida.
Ma il freddo invernale era niente rispetto al freddo che c’era nei cuori della gente. a causa di una faida che da vent’anni teneva Godrano in una morsa di paura e di vendette a catena. Si contavano già quindici omicidi e ad ogni morto il paese, spaccato in due, aspettava la ritorsione dell’altra parte. Per intravedere la linea di sangue che divideva il paese, bastava guardare l’assemblea quelle due volte all’anno che la chiesa si riempiva per invincibile tradizione, a Pasqua e a Natale: la gente si disponeva in due masse distinte e compatte, con le donne quasi tutte vestite a lutto. Fu l’unica volta che padre Pino vacillò: «Non so fare il prete, disse. Non ce la faccio più a fare il prete!». Il prete è un servo di tutti, ma che accade se tutti gli fanno capire che non hanno bisogno di lui?
Padre Puglisi aveva una sola risorsa vincente: sapeva trattare con i bambini, ed ebbe la fortuna che un amico glielo ricordasse.
Per attirarli ricorse alle tecniche più sofisticate di allora: comprò un proiettore per diapositive e, quando la voce si sparse, in parrocchia comparvero i primi visetti incuriositi. Poi passò dalle immagini alla realtà: iniziò a fare catechesi facendo sceneggiare ai bambini le parabole di Gesù (ed egli stesso si improvvisava attore). Poi gli venne in aiuto da Palermo un gruppetto di scout. a gestirgli un po’ di doposcuola. Poi inventò una breve «vacanza al mare» per quei bambini che il mare non l’avevano mai visto. E quando la domenica giunsero in visita i papà e le mamme, ancora sospettosi, videro allibiti i loro figli che giocavano amichevolmente assieme e che si autogestivano tutti i servizi del campo. Iniziò così la ricostruzione della parrocchia. Restava il nucleo infrangibile delle famiglie direttamente coinvolte nella faida.
Chiamò allora in aiuto un movimento di laici, d’ispirazione francescana, che si dedicavano a forme di «missione popolare». In Avvento e in Quaresima tutte le famiglie della parrocchia furono visitate e invitate a «gruppi di ascolto del Vangelo» che si tenevano nelle case. Così tornò a risuonare in paese, prima timidamente poi con forza sempre maggiore, la parola «perdono»; ma ad ascoltarla c’erano ormai persone che si sentivano ribollire le viscere, non solo dell’antico astio, ma anche di un po’ di tenerezza.
Erano contadini abituati a pensare che perdonare significasse essere deboli e piegarsi alle angherie o, ancor peggio, rinnegare la fedeltà ai propri morti. E scoprivano, invece, che il perdono poteva essere una forza incredibile di rinnovamento e di riscatto, anche per i morti.
Finì che la gelida canonica divenne calda d’amore e di gente, anche se la chiamavano «il Colosseo», perché aveva le porte sempre spalancate.
Il paese fu così pacificato, e la gente riprese subito a litigare con padre Pino perché voleva a tutti i costi che i ragazzi andassero in città a continuare gli studi dopo la terza media. Ma ormai quel prete l’amavano davvero, tanto che, quando in città gli rubarono la misera Cinquecento con cui di solito scarrozzava una decina di bambini alla volta, i parrocchiani si tassarono per comprargli una 126. Tutti sapevano che padre Pino era poverissimo e viveva del pane e del latte che essi stessi gli regalavano. E il fornaio gli portava personalmente una grossa pagnotta ogni settimana. Si manteneva povero non perché volesse fare il prete contestatore, ma perché aveva deciso di essere un prete «francescano», come diceva. Quando, dopo sette anni, gli offrirono un posto prestigioso in diocesi (il cardinale Pappalardo, giunto a Palermo subito dopo l’invio di Puglisi a Godrano, voleva nominarlo padre spirituale del Seminario Maggiore), padre Pino rifiutò: scrisse al cardinale di non sentirsi «né adatto, né capace» per quell’incarico; ma in realtà non aveva cuore di abbandonare quei suoi parrocchiani appena riscattati, né di abbandonare gli altri poveri che da tempo soccorreva in una bidonville della periferia di Palermo, detta dello «Scaricatore».
Si trattava di una serie di catapecchie a una sola stanza, lungo il fiume Oreto, dove si ammassavano cenciaioli, pescatori, factotum, venditori ambulanti, domestiche a ore, donne e ragazzi abbandonati...
La sua piccola parrocchia gli lasciava molto tempo libero e padre Pino s’era spontaneamente offerto di collaborare con le «assistenti sociali missionarie» della diocesi (c’era anche questo a Palermo!), che organizzavano corsi di licenza elementare per adulti e centri di assistenza per famiglie in difficoltà.
Lui poi si faceva aiutare da un gruppetto di ragazzi — scelti tra i liceali ai quali insegnava religione — inculcando loro sistematicamente una verità che riteneva irrinunciabile: fare i volontari voleva dire «lavorare per restituire la dovuta dignità a chi ne era stato privato».
A Palermo c’era negli anni Settanta un indubbio fervore per allacciare il rinnovamento teologico e pastorale voluto dal Concilio Vaticano II al rinnovamento che la città invocava anche sul piano sociale e politico. L’emergenza mafia — con le sue trame oscure e delittuose, con tutto il suo vischioso intreccio al mondo dell’economia e della politica — cominciava ad interrogare la Chiesa e ad inquietare gli animi.
Si levavano voci che denunciavano l’insensibilità dei cristiani (non esclusi alcuni vescovi e preti) a riguardo dell’incompatibilità del sistema mafioso a tutti i livelli (dall’appartenenza alla contiguità, al sostegno indiretto, alla richiesta e fruizione di favori) con la professione della fede.
Certo, tutti i cristiani condannavano le attività criminose, ma non tutti comprendevano il livello socio-politico del problema, anche se la mafia ormai insanguinava la città pur di proteggere ed estendere i suoi molteplici, estesissimi tentacoli. Padre Pino non era, né per natura né per convinzione, un rivoluzionario o un agitatore. Era indubbiamente interessato ad approfondire il problema e ne percepiva i risvolti: era soprattutto convinto che tra fede e carità dovesse esserci spazio per ogni resistenza, ogni denuncia e ogni lotta, ma era altresì persuaso che fosse imprescindibile partire dalla testimonianza della vita.
Sapeva di dover riflettere e non si sottraeva ad alcun confronto o dialogo anche con i confratelli più «schierati», ma manteneva la sua autonomia di giudizio.
Molti si domandavano: che cosa deve fare il prete in una Chiesa come quella di Palermo, posta in situazione di frontiera? Padre Pino sentiva il dolore della domanda, ma si chiedeva: come dev’essere fatto un prete?
Del prete gli interessavano indubbiamente l’intelligenza e la competenza nell’affrontare i problemi (quando morirà troveranno il suo appartamentino stipato di 3.500 volumi, l’unica ricchezza che teneva in casa e che occupava tutto lo spazio disponibile); ma gli interessava soprattutto il cuore dei ministri di Dio. O meglio: gli interessava quel centro della persona in cui mente e cuore si decidono irrevocabilmente per Dio. Una decisione integrale che si chiama santità. Sul finire degli anni Settanta, dunque, padre Pino Puglisi era ritenuto dal suo vescovo persona adatta a ricoprire il ruolo di padre spirituale del Seminario Maggiore (tradizionalmente affidato a sacerdoti di provata vita interiore).
Non si ritenne adatto al compito, ma vale qui la pena anticipare che questo compito dovrà comunque accettarlo nell’ultimo anno della sua vita, e lo eserciterà pur restando parroco di Brancaccio. Nel 1978 cominciò a insegnare religione al Liceo Vittorio Emanuele e qui lo raggiunse la nomina a direttore del Centro Diocesano per le Vocazioni; in seguito diverrà responsabile del Centro Regionale, e poi consigliere del Centro Nazionale.
Gli anni Ottanta — il terzo decennio del suo sacerdozio, durato in tutto trentatré anni — li passò, così, a coltivare la passione della sua vita: aiutare schiere di giovani a comprendere e realizzare la propria vocazione.
I «centri vocazionali» erano allora una novità e c’era tutto da inventare: padre Puglisi cominciò a organizzare e vivacizzare in maniera sistematica dei campi scuola per ragazzi delle diverse età: il campo-base (sempre autogestito perché voleva che i ragazzi imparassero la bellezza del servizio reciproco) serviva a spiegare che nella vita può anche essere facile dire di «sì», ma il problema vero è quello di sapere dove andare, di dare il proprio assenso con la gioia e l’entusiasmo di chi ha scelto una meta che vale.
«Sì, ma verso dove?», questo era lo slogan che campeggiava sul poster programmatico. E non era solo un problema di preti o di consacrati, ma di tutti i cristiani, a ognuno dei quali Dio voleva affidare «un servizio unico, irripetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri per dare vita a vere comunità...».
E padre Pino sosteneva che tutta la pastorale parrocchiale avrebbe dovuto essere impostata in termini vocazionali. Lo ripeterà perfino a Brancaccio, giudicando l’opera della mafia, alla radice, come distruzione sistematica della vocazione cristiana di bambini, ragazzi, adulti, famiglie. A coloro che erano chiamati al matrimonio lasciava questa consegna: «Amandovi, dite al mondo che Dio c’è», e spiegava loro quanto fosse brutta una casa in cui le porte si aprono verso l’esterno: «Pare che ti sbattano in faccia la porta. Invece la famiglia deve accogliere!». Ma sapeva di dover essere particolarmente attento a coloro che sono chiamati «a mettersi al servizio della vocazione altrui», e s’era messo egli stesso alla guida di una «comunità giovanile vocazionale» che preparava ragazzi per il seminario, con una forma di stabile convivenza.
Che cosa, poi, fosse un prete lo diceva quel poster che gli era caro e che egli metteva sempre in evidenza: un grande orologio senza lancette, e la scritta: «Per Cristo a tempo pieno». Nel 1990, dunque, padre Puglisi fu nominato parroco a Brancaccio, dove resterà tre anni, gli ultimi della sua vita.
Era una borgata periferica che, in seguito, giornalisti e magistrati avrebbero definito «ad alta densità mafiosa». In realtà ciò significava che circa 8.000 abitanti — tra i quali non mancavano famiglie buone e oneste — erano abbandonati in mano a una consolidata dinastia mafiosa, mentre le autorità civili e politiche erano in parte assenti, in parte impotenti e in parte complici.
Sarà lo stesso parroco a presentare così la parrocchia ai volontari accorsi ad aiutarlo. C’erano — diceva — quattro strati sociali: gli antichi abitanti del posto, un tempo proprietari agricoli, divenuti ricchi con la vendita dei terreni, e tra essi allignavano la mentalità e il potere mafiosi; c’erano i braccianti di un tempo, rimasti disoccupati e in estrema povertà, che vivevano in catapecchie, anche dieci persone in una sola stanza; c’era una presenza di borghesi frettolosi e distratti nei palazzi nuovi; e poi c’erano più di 200 famiglie deportate dal centro storico e ammassate in palazzoni costruiti dalla mafia, acquistati e gestiti dal Comune con traffici per lo meno strani.
Erano in gran parte famiglie sradicate, povere culturalmente e moralmente, tra le quali erano diffusi l’analfabetismo, l’evasione scolare dei bambini, le coppie irregolari, il lavoro nero, lo spaccio di droga, l’abitudine al furto, la più assoluta trascuratezza igienico-sanitaria.
Da questo bacino la mafia traeva i suoi manovali, ed era l’unico potere riconosciuto dal quale sperare qualche favore. A tale scopo il degrado era mantenuto e favorito: mancava una rete fognaria, mancava una scuola media, mancava un distretto socio-sanitario, mancavano spazi verdi, mancava l’erogazione regolare dell’acqua potabile, era scarsa perfino l’illuminazione.
Bambini in età scolare avevano per casa e per scuola la strada dove — con la compiacenza e lo stimolo degli adulti — si allenavano ai piccoli furti, alla prepotenza, alla vendetta, alla violenza (seviziando animali randagi), ed assorbivano quella mentalità che li gettava infallibilmente in braccio alla mafia.
Possiamo immaginare la pena di padre Puglisi e dei suoi collaboratori, quando — dopo l’assassinio del giudice Falcone — ne videro un gruppo correre trionfante per le strade del quartiere gridando: «La mafia è forte! La mafia vince!». Quando verrà celebrato il processo ai mandanti e agli esecutori dell’uccisione di padre Pino, emergerà un vero inferno; i capimafia della zona gestivano bande diversificate per obiettivi: organizzazione di omicidi e di «lupare bianche», incendi di negozi, estorsioni e riscossione del «pizzo», rapine ai Tir che transitavano in viale della Regione e sull’autostrada Palermo-Catania, riciclaggio di denaro sporco, traffico di armi e di stupefacenti, prostituzione, organizzazione di stragi anche a livello nazionale.
Ma già allora tutti sapevano che certi scantinati di quei palazzoni tirati su dalla mafia e apparentemente abbandonati al primo venuto servivano come deposito d’armi e di droga, centro di scommesse clandestine e prostituzione anche minorile. E padre Pino e i suoi amici si intestardivano a chiedere che quegli scantinati fossero risanati e tramutati in scuola media!
«Rievangelizzare e ricristianizzare il quartiere»: questo fu l’obiettivo che il nuovo parroco si propose. Il suo primo intervento riguardò la parrocchia in senso stretto (a partire dalla chiesa e dagli ambienti parrocchiali). Decise di ripulirla da ogni collusione: la volle, perciò, libera dai politici che venivano a chiedere voti in cambio di promesse; libera da comitati che organizzavano la festa patronale e la usavano come trampolino di lancio per ostentare il loro potere e i loro traffici; libera da sudditanze che spingevano a chiedere come favore ciò che era un diritto; libera da questue che rendevano i beneficati ossequiosi verso eventuali benefattori; libera dalle paure. Il secondo intervento riguardò i parrocchiani: ce n’erano di buoni e ne trovò alcuni che si erano già alleati formando un libero «Comitato Intercondominiale», impegnato nel tentativo di dotare il quartiere dei servizi essenziali. E fu nei loro riguardi che padre Pino mostrò tutta la sua santa genialità.
Si dice spesso che il carisma del prete è quello della «carità pastorale» con cui deve servire il popolo che gli è affidato. Ma «carità pastorale» significa anzitutto amore a Cristo al punto da somigliargli. Ed è anzitutto questo amore personale che padre Pino chiedeva a se stesso, per poterlo poi chiedere anche ai volontari e ai parrocchiani. Per quanto degradato fosse il quartiere, egli osava impostare la questione fondamentale esattamente così: «Come parlare di Cristo? Dobbiamo cercare di presentare da innamorati la figura di Cristo, per sperare che ci stiano a sentire. Ciascuno di noi dovrà fare da mediatore, dovremmo fare innamorare gli altri di Cristo, ma logicamente occorre che già noi siamo carichi di questo innamoramento». È questo coraggio nel parlare di «innamoramento di Cristo», al punto da volere collaboratori «carichi di innamoramento», che fa di padre Pino Puglisi una figura atipica, tra molti preti che si lasciano sì afferrare e sommergere dai bisogni sociali, ma non si curano abbastanza di innamorare di Gesù se stessi e la propria gente.
Evidentemente resta poi anche il problema di trarre dalla propria «carità pastorale» tutta l’energia operativa di cui la gente ha bisogno.
Non pochi preti restringono la propria «carità pastorale» alle questioni spirituali e morali, senza accorgersi che essa chiede, per sua natura, di penetrare in tutti i risvolti della realtà, soprattutto là dove l’uomo è oppresso nella sua umanità: la carità cristiana esige di farsi sempre più «materiale», in una incarnazione irresistibile. Ma anche tra coloro che vorrebbero essere socialmente operosi, non mancano tragici errori di prospettiva: a volte i ministri di Dio, quando vedono i cosiddetti laici «impegnati» — cioè desiderosi di vivere il dinamismo comunionale e missionario della Chiesa — subito se li chiamano attorno e li trascinano a sostenere le cosiddette attività parrocchiali, facendoli diventare, nel migliore dei casi, un prolungamento del prete.
Padre Pino, come sappiamo, aveva riflettuto per anni sul tema e sui problemi delle diverse vocazioni, e aveva acquisito una spiccata sensibilità verso la missione dei laici frequentando, con immutata simpatia, assistenti sociali, gruppi di Azione Cattolica, della Fuci, associazioni e movimenti ecclesiali di varia estrazione. Ciò l’aiutò a non cadere nell’errore di attrarre a sé i laici.
Al contrario, mobilitò se stesso in mezzo ai laici: si aggregò a quelli che già agivano, condivise le loro giuste cause, partecipò alle loro rivendicazioni, e li formò nell’atto stesso di coinvolgersi. Insomma: visse il suo carisma (la «carità pastorale») donandolo e trasfondendolo in coloro che vivevano nel quartiere la sua stessa «missione» cristiana.
Fece il parroco tradizionalmente (e «tradizionalmente» pregava, diceva Messa, predicava, faceva catechesi, amministrava i sacramenti...), ma questo era solo l’inizio; poi andava a mettere la sua «carità pastorale» là dove i suoi cristiani agivano, lottavano, soffrivano, gioivano.
Creava in tal modo un vero «movimento parrocchiale», assecondando il muoversi della sua gente e animandola con la sua stessa anima.
Perciò accompagnava i suoi laici quando bisognava andare a trattare con la burocrazia comunale per avere la scuola (lo fece anche la mattina del giorno in cui fu ucciso); era con loro quando bisognava intervenire sulla stampa o alla televisione per denunciare un risanamento sempre promesso e mai attuato; c’era quando bisognava coinvolgere il quartiere in qualche giusta causa (e i banchetti per la raccolta di firme per avere il distretto sanitario li fece mettere davanti alla porta della chiesa); c’era quando chiesero ripetutamente l’interessamento del presidente della Repubblica; c’era quando si trattò di mobilitare il quartiere in una festa commemorativa per Falcone e Borsellino (una festa con lo slogan «rancaccio per la vita!»); c’era quando si trattò di chiedere udienza al presidente della Commissione parlamentare antimafia (due giorni prima che l’uccidessero)...
Non faceva l’agitatore politico o l’assistente sociale, ma non diceva nemmeno «tocca ai laici farlo»: come i laici erano con lui in chiesa, così lui era con i laici in strada o in Comune, perché il corpo ecclesiale è uno solo. E c’era per un duplice motivo: sia per insegnare che il Vangelo predicato in parrocchia era destinato a «incarnarsi nel territorio della parrocchia»; sia in forza del suo stesso celibato sacerdotale.
Nel suo quartiere incarnare il Vangelo voleva dire rischiare la vita, e — se la rischiava chi aveva moglie e figli — come poteva non rischiarla lui che era rimasto «vergine» (cristianamente: innamorato solo di Cristo) proprio per poter curare e difendere il suo gregge? Spiegava agli amici: «Voi avete famiglia. Io non ho nessuno. Non ho né moglie né figli, e anche se mi ammazzano non mi interessa», e si preoccupava che non andassero a trovarlo a tarda ora, perché non facessero brutti incontri.
D’altra parte proprio quello era un tipico e tradizionale avvertimento mafioso: «Lascia perdere, e pensa alla famiglia!». Perciò si vedeva padre Puglisi accompagnare i suoi laici e attrarre su di sé l’attenzione: non certo per ostentare la propria bravura, o coraggio, ma quasi per suggerire che potevano sacrificare lui, se un sacrificio era necessario. Intanto i mafiosi e i benpensanti (anche qualcuno che gli era più vicino) spargevano la voce che quel prete, per la sua voglia di protagonismo. «faceva fare brutta figura al quartiere». Cominciarono a ucciderlo così. Ma l’opera più inaccettabile ai mafiosi — quella che esprimeva tutta la «carità» del prete e tutto il progetto rivoluzionario dei suoi laici — fu la creazione del centro di accoglienza «Padre Nostro».
C’era in vendita una palazzina cadente, situata a trecento metri dalla casa dei boss. S’informò sul prezzo: chiedevano 180 milioni di lire. Ma quando seppero che voleva acquistarla il prete, la richiesta balzò subito a 290 milioni. Sapevano tutti che non aveva una lira. Ma padre Puglisi accettò la sfida: chiese aiuto all’arcivescovo, a numerosi confratelli, ai tanti amici che s’era fatto nel corso della vita, e per il resto ipotecò il suo stipendio di insegnante. Ma espose l’elenco delle offerte e degli offerenti alle porte della chiesa.
L’idea gli era venuta da quando si era accorto che la mafia non solo s’era appropriata delle più belle parole cristiane (come «famiglia», «onore», «amicizia» «fedeltà») stravolgendole, e stravolgendo perfino alcuni riti e devozioni cristiane, ma di fatto insegnava e diffondeva una specie di parodia vissuta del Padre nostro. Anzi, assieme ad alcuni amici, padre Pino aveva provato a esplicitare l’«antipreghiera del mafioso»: quella di chi si rivolge al suo boss riconoscendolo come Padrino della famiglia, il cui nome dev’essere onorato; la cui volontà dev’essere fatta a costo della vita; che dà a tutti i suoi picciotti pane e lavoro; che non ammette il perdono perché è infamità; e che solo può liberare i suoi fedeli dal rischio di cadere in mano dei poliziotti e della Legge. Così è sempre stato e così sarà sempre... Su questo raffronto padre Puglisi impostò anche, per i suoi parrocchiani, una serie di incontri dal titolo significativo: «Itinerario per una catechesi sul Padre nostro a confronto con la cultura e la mentalità mafiose».
E se a qualcuno può sembrare esagerata o esasperata la formulazione di una simile «antipreghiera» e relativa catechesi, gli gioverà leggere — nella sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Palermo — che a Brancaccio il boss in carica era nominato «Madre Natura» («Madre Natura ha mandato a dire di fare questo omicidio»), e il responsabile del «gruppo di fuoco» era noto come «u Signuri» («il Signore», cioè Dio) perché — dicevano i mafiosi nel loro incerto italiano — «aveva il potere di salvare le persone e di poterle ammazzare. Bastava una sua parola per morire o per campare una persona». Ed era anche universalmente noto che il vecchio boss della zona (in carcere da tempo) era soprannominato «il Papa». Così fu creato il «Centro ’Padre Nostro’» (guidato da due religiose «Sorelle dei Poveri» e gestito da un folto gruppo di volontari e amici), in modo che la preghiera insegnata da Gesù potesse mostrare tutta la sua bellezza e la sua efficacia. Vi si tenevano lezioni di recupero scolastico per ragazzi e per adulti; c’era una bibliotechina per adolescenti; un piccolo deposito di medicinali, di giocattoli, di vestiti; vi si poteva avere un pasto caldo (in certi periodi ne furono distribuiti quasi cento al giorno) o trovare sostegno infermieristico e anche consulenza legale) Si organizzavano visite domiciliari, visite ai ragazzi racchiusi nel carcere minorile e alle loro famiglie. E non mancava una piccola macchia di verde per respirare e un giardinetto dove si poteva passeggiare (padre Pino lo usava per i colloqui personali con i ragazzi). Ma la più profonda azione educativa del Centro si realizzava per il solo fatto della sua esistenza e per il nome che aveva. Fin dall’inizio padre Pino s’era immaginato i bambini del quartiere che si dicevano l’un l’altro: «Andiamo al Padre Nostro!», «Io vado al Padre Nostro!», e la strada risuonava di quella notizia ch’era già in se stessa una professione di fede! E difatti uno dei ritornelli dei mafiosi, durante il processo, per motivare l’omicidio, sarà: «Lui si prendeva i bambini.., per non farli cadere, diciamo, nelle mani della mafia...». Fu dopo la «marcia per la vita», organizzata per ricordare la strage di Capaci, che iniziarono intimidazioni sistematiche.
Il giorno dopo la manifestazione fu bruciato il furgone della ditta che eseguiva i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. Poi danneggiarono la povera macchina del prete. Poi furono incendiate contemporaneamente le porte di casa dei tre membri più attivi del Comitato Intercondominiale, poi vennero minacciati dei ragazzi, uno dei quali fu pestato a sangue e inviato con l’ambasceria: «Digli al prete che ci deve lasciar lavorare in pace!». Il Giornale di Sicilia ne diede notizia: «Attentati in serie contro la parrocchia antimafia», ma padre Pino scosse la testa commentando: «Il mio lavoro è sempre stato ’per’, non ’anti’».
E dopo l’incendio delle porte dì casa dei suoi amici aveva sì stigmatizzato il fatto in predica. ma aveva anche inviato un accorato appello ai mandanti: “Sono qui. Sono disposto a parlare. Voi avete vissuto da piccoli in questa chiesa e quindi anche voi siete figli di questa chiesa. A questo punto vi aspetto e ne parliamo...”. E ancora: “Mi rivolgo anche ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi, conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi cerca di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile...”. Preferirono ucciderlo, tentando di far passare l’omicidio per il delitto di un tossicodipendente. Ed era così indifeso che non dovettero affaticarsi nell’esecuzione. Era il giorno del suo compleanno: al mattino aveva celebrato due matrimoni, poi s’era recato in Comune per l’ennesimo inutile tentativo di ottenere quella sospirata scuola media; al pomeriggio si era intrattenuto con alcuni amici per fare insieme un po’ di festa e per ricevere un biglietto di auguri; poi aveva preparato alcuni genitori al battesimo dei loro bambini; poi s’era diretto verso casa per un ultimo incontro con due sposi che desideravano parlargli. Il gruppetto che doveva eliminarlo era nei paraggi, solo per un primo sopralluogo, per studiare la situazione. Ma la situazione era così semplice, la vittima così esposta, che ritennero inutile attendere. Mentre padre Pino infilava la chiave nel portoncino di casa, una mano lo prevenne e si posò sul suo borsello: «Padre, questa è una rapina», disse il complice. Padre Pino si voltò appena: «Me l’aspettavo», disse, con un indimenticabile sorriso buono, mentre l’esecutore gli sparava alla nuca.
Si «aspettava» di dover dare la vita proprio in quell’istante? Non lo sappiamo, perché non vide il suo assassino o forse ne percepì solo confusamente la presenza minacciosa alle spalle.
Ma certo aspettava il compimento della Via Crucis sulla quale s’era liberamente incamminato: sapeva che ogni violenza che lo raggiungeva era una «sacra stazione» del suo cammino verso il Calvario.
In quegli ultimi anni — pur essendo parroco a Brancaccio e padre spirituale del Seminario Maggiore — non aveva voluto abbandonare un incarico a cui teneva molto, quello di cappellano in una casa-rifugio per ragazze madri.
Proprio a loro il giorno prima aveva fatto una stranissima predica sulla passione di Gesù. Aveva detto:
«Quando noi abbiamo paura o proviamo una sensazione intensa di calore, scattano le contrazioni sotto la pelle. Lì ci sono come delle borsette piene che si svuotano e fanno uscire il sudore. Ma quando la contrazione è più forte, perché la paura è diventata angoscia, tensione insopportabile, si rompono i capillari. Ecco perché si dice che Cristo sudò sangue... Sudò sangue per la paura umana del dolore. E sulla croce implorò il Padre di evitargli l’amaro calice prima di unirsi al Suo volere. Tutto questo ci fa sentire ancora di più Cristo vicino a noi, come un fratello. Da questo abbiamo conosciuto l’amore di Dio. Egli ha dato la vita per noi e anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli”. Ora sappiamo che cosa aspettava padre Pino Puglisi: aspettava il momento in cui Cristo crocifisso l’avrebbe abbracciato e stretto a Sé.
Poi, cessata l’epoca delle persecuzioni, il martirio divenne più raro, ma sembrò evidente che la stessa santa testimonianza poteva essere data con una adesione umile e quotidiana alla persona di Gesù e col compimento generoso della sua volontà.
Ai nostri giorni un’altra evidenza si sta imponendo: i credenti possono essere perseguitati non solo con forme estreme, che esigono la testimonianza esplicita e coraggiosa data in un atto supremo e conclusivo, ma in giorni e giorni di ostilità crescente, di ricatti sistematici, di minacce certe anche se non chiaramente definite.
Possono essere metodicamente aggredite la fede del cristiano, la sua carità, la sua fame e sete di giustizia, la sua passione per la verità, la sua affezione alla Chiesa. E il martirio può accadere in mille forme, anche anonime: a volte il martire è un volto indistinto tra centinaia di altri volti ugualmente sfigurati; a volte il martirio è nascosto in una morte apparentemente casuale che però è stata accuratamente programmata o anche solo sollecitata dai persecutori; a volte il «sì» del martire a Cristo è nascosto nel no che egli dice ai violenti di questo mondo. Già all’inizio degli anni Cinquanta del XX secolo Charles Journet, un celebre teologo, avvertiva: «Può accadere che l’epoca in cui siamo entrati conoscerà una forma di martirio molto povera, molto spoglia, senza nulla di spettacolare per la fede della comunità cristiana — dato che lo spettacolare sta passando tutto nel campo della Bestia —, un epoca in cui sarà chiesto ai martiri, prima di morire corporalmente per Cristo, d’essere avviliti e di rinunciare alla gioia di poter confessare Gesù in faccia al mondo». Tutto questo dobbiamo premettere parlando del «martirio» di padre Puglisi. Non tocca, infatti, a noi anticipare il giudizio della Chiesa, che è ancora in formazione. Tuttavia abbiamo già delle indicazioni molto significative.
Fu lo stesso padre Pino a rivelare la sua anima e la sua disponibilità cosciente al martirio. Lo fece un anno prima di morire, intervenendo a Trento, al convegno annuale del movimento «Presenza del Vangelo»:
«La testimonianza cristiana è una testimonianza che diventa martirio... Dalla testimonianza al martirio il passo è breve, anzi è proprio questo che dà valore alla testimonianza... Il testimone è testimone di una presenza del Cristo presente dentro, anzi dovrebbe diventare trasparenza di questa presenza. E testimonia la presenza di Cristo attraverso la sua vita vissuta proprio con questo desiderio costante di vivere in perfetta comunione con Lui, sempre più profonda con Lui, in una fame e sete di Lui... Essere testimone soprattutto per chi conserva rabbia nei confronti della società che vede ostile... A lui il testimone deve infondere speranza... facendo comprendere che la vita vale se è donata...»
Dopo la morte, i più autorevoli giudizi sulla sua vicenda non faranno che riprendere questa anticipata confessione.
«Padre Puglisi è morto per avere avuto fame e sete di giustizia», dirà il suo arcivescovo.
«Padre Pino Puglisi fu un coraggioso ministro del Vangelo», dirà il papa.
Nella vita di questo umile prete palermitano non ci fu un giorno preciso in cui gli fu chiesto di rinnegare Cristo, e nel quale egli poté offrire gloriosamente la sua vita. Ci fu, invece, un’intera esistenza sacerdotale, durante la quale egli imparò ad amare Cristo più di se stesso e ad amare «tutto ciò che è di Cristo». Così quando. negli ultimi anni della sua vita, gli affidarono parrocchiani, vittime abituali del sopruso dei violenti, egli li difese — parlando con chiarezza e agendo con efficacia — rimettendo a Dio la cura della sua vita ripetutamente minacciata, fino a quando gliela tolsero in un istante, nascondendo l’arma dietro un finto gesto di rapina.
Fu un «martirio povero», simile a quello dell’Eucaristia — pane spezzato e sangue versato — che si lascia consumare ogni giorno. Il suo sacrificio resta indubbiamente legato alla lotta contro la mafia, ma egli non fu sconfitto in una lotta programmata contro un qualsivoglia nemico. Egli combatté semplicemente la buona battaglia del suo sacerdozio. E quando incontrò il Male lo avversò con tutte le sue forze per difendere i suoi figli. Morì per loro, in una strada della sua parrocchia, ma il suo sacrificio gettò una luce nuova su un fenomeno sociale che non era solo quello di semplice criminalità organizzata — come molti pensavano — ma era piuttosto l’adesione sistematica a un vero e proprio «regno del peccato». In Sicilia era già risuonato il «grido del cuore» di Giovanni Paolo II, improvvisato nella Valle dei Templi ad Agrigento: «Dio ha detto: non uccidere! L’uomo, qualsiasi agglomerazione umana o la mafia, non può calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili: convertitevi! Per l’amore di Dio! Mafiosi convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio e dovrete rendere conto delle vostre malefatte».
Era il maggio del 1993. Due mesi dopo la mafia avrebbe risposto mettendo una bomba davanti alla cattedrale del papa (S. Giovanni in Laterano) a Roma. Altri due mesi e avrebbe decretato l’uccisione dei prete palermitano. Si scoprirà poi che in ambedue i casi gli esecutori appartenevano al «gruppo di fuoco» della mafia di Brancaccio, paese natale di padre Pino! Sarà riflettendo sull’assassinio di padre Pino Puglisi (e sugli orrori che dietro ad esso si nascondevano) che i vescovi di Sicilia arriveranno non solo a condannare la criminalità mafiosa e i suoi delitti, ma a proclamare assieme e ufficialmente: «L’incompatibilità col Vangelo è intrinseca alla mafia, per se stessa, per le sue motivazioni e per le sue finalità, oltre che per i mezzi e per i metodi adoperati. La mafia appartiene, senza possibilità di eccezione, al regno del peccato e fa dei suoi operai altrettanti operai del Maligno».
Padre Pino non aveva a difesa e a stimolo del suo operato un simile autorevole pronunciamento. Al contrario, fu il suo martirio a provocarlo. Così un semplice sacerdote, con la sua carità senza confini e senza paure, accelerò l’elaborazione di un giudizio che per la Chiesa era ormai necessario e improrogabile. Obbedendo alla sua missione sacerdotale «fino all’effusione del sangue», egli non svelò soltanto l’iniquità dei violenti, ma accrebbe la coscienza e il senso di responsabilità della sua Chiesa.
Padre Pino Puglisi aveva passato a Brancaccio solo la prima infanzia, trascorsa in una famiglia di buoni cristiani, che non gli mise ostacoli quando a 16 anni decise di entrare in seminario. I suoi studi durante la guerra erano stati precari, aveva trascorso molte ore sui campi o aiutando il papà nella bottega di calzolaio, ma aveva incontrato un prete buono e dotto che l’aveva aiutato privatamente nello studio del greco e del latino, necessari per intraprendere gli studi liceali. Ricevette il suddiaconato a 21 anni, ed era il tempo in cui i giovani seminaristi dovevano scegliere definitivamente per il celibato.
Sulla tradizionale immaginetta-ricordo Pino fece scrivere: «Accetta, Signore, l’olocausto della mia vita» e, poiché assieme agli studi di greco gli era venuta la passione per le etimologie, aveva annotato: «Olocausto vuoi dire bruciare tutta la propria esistenza sull’altare della Croce». Aveva scelto, dunque, quell’espressione, con pienezza di coscienza. Profezia?
Noi pensiamo che si tratti piuttosto di quel misterioso gioco in cui Dio, a volte, ci coinvolge: ci fa chiedere qualcosa di grande, di estremamente impegnativo, di cui non comprendiamo bene le conseguenze, e poi ci esaudisce. Egli agisce con noi come i buoni genitori fanno con i loro bambini: accettano seriamente e con gratitudine delle promesse che i piccoli fanno in maniera un po’ sventata, e poi le usano pedagogicamente per aiutarli a crescere.
Di fatto, padre Pino, nel giorno in cui si offrì — corpo e anima — al suo Signore, chiese anche di poter essere «consumato interamente» e oggi noi sappiamo che fu esaudito. Fu ordinato prete (nel santuario della Madonna dei Rimedi) quando non aveva ancora 23 anni. Il primo decennio di sacerdozio lo passò come viceparroco nelle periferie, e lavorò come cappellano in un istituto di orfani. Come accade a tutti i giovani preti, si interessava soprattutto dei ragazzi. Ma gli veniva anche spontaneo, già allora, appoggiare le rivendicazioni della povera gente che in quegli anni veniva ammassata in «villaggi popolari», tirati su alla meno peggio, senza acqua, né luce, ne strade, né scuole o servizi d’alcun genere. Evidentemente i benpensanti non mancarono di accusarlo d’essere «un prete rosso». La vera passione di padre Pino (che l’accompagnerà sempre) era quella di “educare” i giovani, anche se i suoi tentativi si scontravano, a volte, con le incomprensioni di qualche vecchio parroco che non ne condivideva i metodi. Erano gli anni tumultuosi del Concilio Ecumenico Vaticano II e delle prime contestazioni postconciliari, tutti parlavano di dialogo e di aggiornamento, ed egli annotava: “Un prete deve saper dialogare su quattro fronti: con la realtà, con gli altri, con se stesso e con Dio”.
Si interrogava su “come parlare di Dio ai giovani» per riuscire «ad entrare in comunicazione con il loro mondo». Si interessava delle vicende dei santi e del loro metodo pedagogico (l’affascinava soprattutto san Giovanni Bosco). Precisava le sue idee sulla Chiesa («La Chiesa è un’assemblea di persone che pregano... Può essere edificata solo pregando e studiando, celebrando e discutendo, amando e lavorando...»). Si riprometteva di rapportarsi con ogni uomo in base alla «vocazione fondamentale» di ciascuno, quella di «entrare in comunione con Dio, un Dio che è amore ed è pieno di tenerezza»; ed era deciso a muoversi apostolicamente con libertà, fedele all’indicazione di papa Giovanni XXIII, che esortava i cristiani «a non confondere mai l’errore con l’errante».
Era insomma un giovane prete entusiasta che non temeva di sbilanciarsi sul terreno della carità e dell’impegno sociale, e su quello della creatività pedagogica. Evidentemente non piaceva a tutti e infastidiva gli amanti del quieto vivere. Così, quando il cardinale di allora, dimissionario, lo inviò parroco a Godrano (una sperduta frazione di Corleone, a 740 metri di altitudine), dove nessuno voleva andare, ci fu chi pensò a una meritata punizione.
Padre Pino accettò: «Non sono figli di Dio anche quelli di Godrano?», disse, e annunciò con umorismo agli amici che era divenuto «il parroco più altolocato della diocesi». Al paese trovò una chiesetta danneggiata dal terremoto, frequentata da tre vecchiette di numero, e una canonica lesionata e gelida.
Ma il freddo invernale era niente rispetto al freddo che c’era nei cuori della gente. a causa di una faida che da vent’anni teneva Godrano in una morsa di paura e di vendette a catena. Si contavano già quindici omicidi e ad ogni morto il paese, spaccato in due, aspettava la ritorsione dell’altra parte. Per intravedere la linea di sangue che divideva il paese, bastava guardare l’assemblea quelle due volte all’anno che la chiesa si riempiva per invincibile tradizione, a Pasqua e a Natale: la gente si disponeva in due masse distinte e compatte, con le donne quasi tutte vestite a lutto. Fu l’unica volta che padre Pino vacillò: «Non so fare il prete, disse. Non ce la faccio più a fare il prete!». Il prete è un servo di tutti, ma che accade se tutti gli fanno capire che non hanno bisogno di lui?
Padre Puglisi aveva una sola risorsa vincente: sapeva trattare con i bambini, ed ebbe la fortuna che un amico glielo ricordasse.
Per attirarli ricorse alle tecniche più sofisticate di allora: comprò un proiettore per diapositive e, quando la voce si sparse, in parrocchia comparvero i primi visetti incuriositi. Poi passò dalle immagini alla realtà: iniziò a fare catechesi facendo sceneggiare ai bambini le parabole di Gesù (ed egli stesso si improvvisava attore). Poi gli venne in aiuto da Palermo un gruppetto di scout. a gestirgli un po’ di doposcuola. Poi inventò una breve «vacanza al mare» per quei bambini che il mare non l’avevano mai visto. E quando la domenica giunsero in visita i papà e le mamme, ancora sospettosi, videro allibiti i loro figli che giocavano amichevolmente assieme e che si autogestivano tutti i servizi del campo. Iniziò così la ricostruzione della parrocchia. Restava il nucleo infrangibile delle famiglie direttamente coinvolte nella faida.
Chiamò allora in aiuto un movimento di laici, d’ispirazione francescana, che si dedicavano a forme di «missione popolare». In Avvento e in Quaresima tutte le famiglie della parrocchia furono visitate e invitate a «gruppi di ascolto del Vangelo» che si tenevano nelle case. Così tornò a risuonare in paese, prima timidamente poi con forza sempre maggiore, la parola «perdono»; ma ad ascoltarla c’erano ormai persone che si sentivano ribollire le viscere, non solo dell’antico astio, ma anche di un po’ di tenerezza.
Erano contadini abituati a pensare che perdonare significasse essere deboli e piegarsi alle angherie o, ancor peggio, rinnegare la fedeltà ai propri morti. E scoprivano, invece, che il perdono poteva essere una forza incredibile di rinnovamento e di riscatto, anche per i morti.
Finì che la gelida canonica divenne calda d’amore e di gente, anche se la chiamavano «il Colosseo», perché aveva le porte sempre spalancate.
Il paese fu così pacificato, e la gente riprese subito a litigare con padre Pino perché voleva a tutti i costi che i ragazzi andassero in città a continuare gli studi dopo la terza media. Ma ormai quel prete l’amavano davvero, tanto che, quando in città gli rubarono la misera Cinquecento con cui di solito scarrozzava una decina di bambini alla volta, i parrocchiani si tassarono per comprargli una 126. Tutti sapevano che padre Pino era poverissimo e viveva del pane e del latte che essi stessi gli regalavano. E il fornaio gli portava personalmente una grossa pagnotta ogni settimana. Si manteneva povero non perché volesse fare il prete contestatore, ma perché aveva deciso di essere un prete «francescano», come diceva. Quando, dopo sette anni, gli offrirono un posto prestigioso in diocesi (il cardinale Pappalardo, giunto a Palermo subito dopo l’invio di Puglisi a Godrano, voleva nominarlo padre spirituale del Seminario Maggiore), padre Pino rifiutò: scrisse al cardinale di non sentirsi «né adatto, né capace» per quell’incarico; ma in realtà non aveva cuore di abbandonare quei suoi parrocchiani appena riscattati, né di abbandonare gli altri poveri che da tempo soccorreva in una bidonville della periferia di Palermo, detta dello «Scaricatore».
Si trattava di una serie di catapecchie a una sola stanza, lungo il fiume Oreto, dove si ammassavano cenciaioli, pescatori, factotum, venditori ambulanti, domestiche a ore, donne e ragazzi abbandonati...
La sua piccola parrocchia gli lasciava molto tempo libero e padre Pino s’era spontaneamente offerto di collaborare con le «assistenti sociali missionarie» della diocesi (c’era anche questo a Palermo!), che organizzavano corsi di licenza elementare per adulti e centri di assistenza per famiglie in difficoltà.
Lui poi si faceva aiutare da un gruppetto di ragazzi — scelti tra i liceali ai quali insegnava religione — inculcando loro sistematicamente una verità che riteneva irrinunciabile: fare i volontari voleva dire «lavorare per restituire la dovuta dignità a chi ne era stato privato».
A Palermo c’era negli anni Settanta un indubbio fervore per allacciare il rinnovamento teologico e pastorale voluto dal Concilio Vaticano II al rinnovamento che la città invocava anche sul piano sociale e politico. L’emergenza mafia — con le sue trame oscure e delittuose, con tutto il suo vischioso intreccio al mondo dell’economia e della politica — cominciava ad interrogare la Chiesa e ad inquietare gli animi.
Si levavano voci che denunciavano l’insensibilità dei cristiani (non esclusi alcuni vescovi e preti) a riguardo dell’incompatibilità del sistema mafioso a tutti i livelli (dall’appartenenza alla contiguità, al sostegno indiretto, alla richiesta e fruizione di favori) con la professione della fede.
Certo, tutti i cristiani condannavano le attività criminose, ma non tutti comprendevano il livello socio-politico del problema, anche se la mafia ormai insanguinava la città pur di proteggere ed estendere i suoi molteplici, estesissimi tentacoli. Padre Pino non era, né per natura né per convinzione, un rivoluzionario o un agitatore. Era indubbiamente interessato ad approfondire il problema e ne percepiva i risvolti: era soprattutto convinto che tra fede e carità dovesse esserci spazio per ogni resistenza, ogni denuncia e ogni lotta, ma era altresì persuaso che fosse imprescindibile partire dalla testimonianza della vita.
Sapeva di dover riflettere e non si sottraeva ad alcun confronto o dialogo anche con i confratelli più «schierati», ma manteneva la sua autonomia di giudizio.
Molti si domandavano: che cosa deve fare il prete in una Chiesa come quella di Palermo, posta in situazione di frontiera? Padre Pino sentiva il dolore della domanda, ma si chiedeva: come dev’essere fatto un prete?
Del prete gli interessavano indubbiamente l’intelligenza e la competenza nell’affrontare i problemi (quando morirà troveranno il suo appartamentino stipato di 3.500 volumi, l’unica ricchezza che teneva in casa e che occupava tutto lo spazio disponibile); ma gli interessava soprattutto il cuore dei ministri di Dio. O meglio: gli interessava quel centro della persona in cui mente e cuore si decidono irrevocabilmente per Dio. Una decisione integrale che si chiama santità. Sul finire degli anni Settanta, dunque, padre Pino Puglisi era ritenuto dal suo vescovo persona adatta a ricoprire il ruolo di padre spirituale del Seminario Maggiore (tradizionalmente affidato a sacerdoti di provata vita interiore).
Non si ritenne adatto al compito, ma vale qui la pena anticipare che questo compito dovrà comunque accettarlo nell’ultimo anno della sua vita, e lo eserciterà pur restando parroco di Brancaccio. Nel 1978 cominciò a insegnare religione al Liceo Vittorio Emanuele e qui lo raggiunse la nomina a direttore del Centro Diocesano per le Vocazioni; in seguito diverrà responsabile del Centro Regionale, e poi consigliere del Centro Nazionale.
Gli anni Ottanta — il terzo decennio del suo sacerdozio, durato in tutto trentatré anni — li passò, così, a coltivare la passione della sua vita: aiutare schiere di giovani a comprendere e realizzare la propria vocazione.
I «centri vocazionali» erano allora una novità e c’era tutto da inventare: padre Puglisi cominciò a organizzare e vivacizzare in maniera sistematica dei campi scuola per ragazzi delle diverse età: il campo-base (sempre autogestito perché voleva che i ragazzi imparassero la bellezza del servizio reciproco) serviva a spiegare che nella vita può anche essere facile dire di «sì», ma il problema vero è quello di sapere dove andare, di dare il proprio assenso con la gioia e l’entusiasmo di chi ha scelto una meta che vale.
«Sì, ma verso dove?», questo era lo slogan che campeggiava sul poster programmatico. E non era solo un problema di preti o di consacrati, ma di tutti i cristiani, a ognuno dei quali Dio voleva affidare «un servizio unico, irripetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri per dare vita a vere comunità...».
E padre Pino sosteneva che tutta la pastorale parrocchiale avrebbe dovuto essere impostata in termini vocazionali. Lo ripeterà perfino a Brancaccio, giudicando l’opera della mafia, alla radice, come distruzione sistematica della vocazione cristiana di bambini, ragazzi, adulti, famiglie. A coloro che erano chiamati al matrimonio lasciava questa consegna: «Amandovi, dite al mondo che Dio c’è», e spiegava loro quanto fosse brutta una casa in cui le porte si aprono verso l’esterno: «Pare che ti sbattano in faccia la porta. Invece la famiglia deve accogliere!». Ma sapeva di dover essere particolarmente attento a coloro che sono chiamati «a mettersi al servizio della vocazione altrui», e s’era messo egli stesso alla guida di una «comunità giovanile vocazionale» che preparava ragazzi per il seminario, con una forma di stabile convivenza.
Che cosa, poi, fosse un prete lo diceva quel poster che gli era caro e che egli metteva sempre in evidenza: un grande orologio senza lancette, e la scritta: «Per Cristo a tempo pieno». Nel 1990, dunque, padre Puglisi fu nominato parroco a Brancaccio, dove resterà tre anni, gli ultimi della sua vita.
Era una borgata periferica che, in seguito, giornalisti e magistrati avrebbero definito «ad alta densità mafiosa». In realtà ciò significava che circa 8.000 abitanti — tra i quali non mancavano famiglie buone e oneste — erano abbandonati in mano a una consolidata dinastia mafiosa, mentre le autorità civili e politiche erano in parte assenti, in parte impotenti e in parte complici.
Sarà lo stesso parroco a presentare così la parrocchia ai volontari accorsi ad aiutarlo. C’erano — diceva — quattro strati sociali: gli antichi abitanti del posto, un tempo proprietari agricoli, divenuti ricchi con la vendita dei terreni, e tra essi allignavano la mentalità e il potere mafiosi; c’erano i braccianti di un tempo, rimasti disoccupati e in estrema povertà, che vivevano in catapecchie, anche dieci persone in una sola stanza; c’era una presenza di borghesi frettolosi e distratti nei palazzi nuovi; e poi c’erano più di 200 famiglie deportate dal centro storico e ammassate in palazzoni costruiti dalla mafia, acquistati e gestiti dal Comune con traffici per lo meno strani.
Erano in gran parte famiglie sradicate, povere culturalmente e moralmente, tra le quali erano diffusi l’analfabetismo, l’evasione scolare dei bambini, le coppie irregolari, il lavoro nero, lo spaccio di droga, l’abitudine al furto, la più assoluta trascuratezza igienico-sanitaria.
Da questo bacino la mafia traeva i suoi manovali, ed era l’unico potere riconosciuto dal quale sperare qualche favore. A tale scopo il degrado era mantenuto e favorito: mancava una rete fognaria, mancava una scuola media, mancava un distretto socio-sanitario, mancavano spazi verdi, mancava l’erogazione regolare dell’acqua potabile, era scarsa perfino l’illuminazione.
Bambini in età scolare avevano per casa e per scuola la strada dove — con la compiacenza e lo stimolo degli adulti — si allenavano ai piccoli furti, alla prepotenza, alla vendetta, alla violenza (seviziando animali randagi), ed assorbivano quella mentalità che li gettava infallibilmente in braccio alla mafia.
Possiamo immaginare la pena di padre Puglisi e dei suoi collaboratori, quando — dopo l’assassinio del giudice Falcone — ne videro un gruppo correre trionfante per le strade del quartiere gridando: «La mafia è forte! La mafia vince!». Quando verrà celebrato il processo ai mandanti e agli esecutori dell’uccisione di padre Pino, emergerà un vero inferno; i capimafia della zona gestivano bande diversificate per obiettivi: organizzazione di omicidi e di «lupare bianche», incendi di negozi, estorsioni e riscossione del «pizzo», rapine ai Tir che transitavano in viale della Regione e sull’autostrada Palermo-Catania, riciclaggio di denaro sporco, traffico di armi e di stupefacenti, prostituzione, organizzazione di stragi anche a livello nazionale.
Ma già allora tutti sapevano che certi scantinati di quei palazzoni tirati su dalla mafia e apparentemente abbandonati al primo venuto servivano come deposito d’armi e di droga, centro di scommesse clandestine e prostituzione anche minorile. E padre Pino e i suoi amici si intestardivano a chiedere che quegli scantinati fossero risanati e tramutati in scuola media!
«Rievangelizzare e ricristianizzare il quartiere»: questo fu l’obiettivo che il nuovo parroco si propose. Il suo primo intervento riguardò la parrocchia in senso stretto (a partire dalla chiesa e dagli ambienti parrocchiali). Decise di ripulirla da ogni collusione: la volle, perciò, libera dai politici che venivano a chiedere voti in cambio di promesse; libera da comitati che organizzavano la festa patronale e la usavano come trampolino di lancio per ostentare il loro potere e i loro traffici; libera da sudditanze che spingevano a chiedere come favore ciò che era un diritto; libera da questue che rendevano i beneficati ossequiosi verso eventuali benefattori; libera dalle paure. Il secondo intervento riguardò i parrocchiani: ce n’erano di buoni e ne trovò alcuni che si erano già alleati formando un libero «Comitato Intercondominiale», impegnato nel tentativo di dotare il quartiere dei servizi essenziali. E fu nei loro riguardi che padre Pino mostrò tutta la sua santa genialità.
Si dice spesso che il carisma del prete è quello della «carità pastorale» con cui deve servire il popolo che gli è affidato. Ma «carità pastorale» significa anzitutto amore a Cristo al punto da somigliargli. Ed è anzitutto questo amore personale che padre Pino chiedeva a se stesso, per poterlo poi chiedere anche ai volontari e ai parrocchiani. Per quanto degradato fosse il quartiere, egli osava impostare la questione fondamentale esattamente così: «Come parlare di Cristo? Dobbiamo cercare di presentare da innamorati la figura di Cristo, per sperare che ci stiano a sentire. Ciascuno di noi dovrà fare da mediatore, dovremmo fare innamorare gli altri di Cristo, ma logicamente occorre che già noi siamo carichi di questo innamoramento». È questo coraggio nel parlare di «innamoramento di Cristo», al punto da volere collaboratori «carichi di innamoramento», che fa di padre Pino Puglisi una figura atipica, tra molti preti che si lasciano sì afferrare e sommergere dai bisogni sociali, ma non si curano abbastanza di innamorare di Gesù se stessi e la propria gente.
Evidentemente resta poi anche il problema di trarre dalla propria «carità pastorale» tutta l’energia operativa di cui la gente ha bisogno.
Non pochi preti restringono la propria «carità pastorale» alle questioni spirituali e morali, senza accorgersi che essa chiede, per sua natura, di penetrare in tutti i risvolti della realtà, soprattutto là dove l’uomo è oppresso nella sua umanità: la carità cristiana esige di farsi sempre più «materiale», in una incarnazione irresistibile. Ma anche tra coloro che vorrebbero essere socialmente operosi, non mancano tragici errori di prospettiva: a volte i ministri di Dio, quando vedono i cosiddetti laici «impegnati» — cioè desiderosi di vivere il dinamismo comunionale e missionario della Chiesa — subito se li chiamano attorno e li trascinano a sostenere le cosiddette attività parrocchiali, facendoli diventare, nel migliore dei casi, un prolungamento del prete.
Padre Pino, come sappiamo, aveva riflettuto per anni sul tema e sui problemi delle diverse vocazioni, e aveva acquisito una spiccata sensibilità verso la missione dei laici frequentando, con immutata simpatia, assistenti sociali, gruppi di Azione Cattolica, della Fuci, associazioni e movimenti ecclesiali di varia estrazione. Ciò l’aiutò a non cadere nell’errore di attrarre a sé i laici.
Al contrario, mobilitò se stesso in mezzo ai laici: si aggregò a quelli che già agivano, condivise le loro giuste cause, partecipò alle loro rivendicazioni, e li formò nell’atto stesso di coinvolgersi. Insomma: visse il suo carisma (la «carità pastorale») donandolo e trasfondendolo in coloro che vivevano nel quartiere la sua stessa «missione» cristiana.
Fece il parroco tradizionalmente (e «tradizionalmente» pregava, diceva Messa, predicava, faceva catechesi, amministrava i sacramenti...), ma questo era solo l’inizio; poi andava a mettere la sua «carità pastorale» là dove i suoi cristiani agivano, lottavano, soffrivano, gioivano.
Creava in tal modo un vero «movimento parrocchiale», assecondando il muoversi della sua gente e animandola con la sua stessa anima.
Perciò accompagnava i suoi laici quando bisognava andare a trattare con la burocrazia comunale per avere la scuola (lo fece anche la mattina del giorno in cui fu ucciso); era con loro quando bisognava intervenire sulla stampa o alla televisione per denunciare un risanamento sempre promesso e mai attuato; c’era quando bisognava coinvolgere il quartiere in qualche giusta causa (e i banchetti per la raccolta di firme per avere il distretto sanitario li fece mettere davanti alla porta della chiesa); c’era quando chiesero ripetutamente l’interessamento del presidente della Repubblica; c’era quando si trattò di mobilitare il quartiere in una festa commemorativa per Falcone e Borsellino (una festa con lo slogan «rancaccio per la vita!»); c’era quando si trattò di chiedere udienza al presidente della Commissione parlamentare antimafia (due giorni prima che l’uccidessero)...
Non faceva l’agitatore politico o l’assistente sociale, ma non diceva nemmeno «tocca ai laici farlo»: come i laici erano con lui in chiesa, così lui era con i laici in strada o in Comune, perché il corpo ecclesiale è uno solo. E c’era per un duplice motivo: sia per insegnare che il Vangelo predicato in parrocchia era destinato a «incarnarsi nel territorio della parrocchia»; sia in forza del suo stesso celibato sacerdotale.
Nel suo quartiere incarnare il Vangelo voleva dire rischiare la vita, e — se la rischiava chi aveva moglie e figli — come poteva non rischiarla lui che era rimasto «vergine» (cristianamente: innamorato solo di Cristo) proprio per poter curare e difendere il suo gregge? Spiegava agli amici: «Voi avete famiglia. Io non ho nessuno. Non ho né moglie né figli, e anche se mi ammazzano non mi interessa», e si preoccupava che non andassero a trovarlo a tarda ora, perché non facessero brutti incontri.
D’altra parte proprio quello era un tipico e tradizionale avvertimento mafioso: «Lascia perdere, e pensa alla famiglia!». Perciò si vedeva padre Puglisi accompagnare i suoi laici e attrarre su di sé l’attenzione: non certo per ostentare la propria bravura, o coraggio, ma quasi per suggerire che potevano sacrificare lui, se un sacrificio era necessario. Intanto i mafiosi e i benpensanti (anche qualcuno che gli era più vicino) spargevano la voce che quel prete, per la sua voglia di protagonismo. «faceva fare brutta figura al quartiere». Cominciarono a ucciderlo così. Ma l’opera più inaccettabile ai mafiosi — quella che esprimeva tutta la «carità» del prete e tutto il progetto rivoluzionario dei suoi laici — fu la creazione del centro di accoglienza «Padre Nostro».
C’era in vendita una palazzina cadente, situata a trecento metri dalla casa dei boss. S’informò sul prezzo: chiedevano 180 milioni di lire. Ma quando seppero che voleva acquistarla il prete, la richiesta balzò subito a 290 milioni. Sapevano tutti che non aveva una lira. Ma padre Puglisi accettò la sfida: chiese aiuto all’arcivescovo, a numerosi confratelli, ai tanti amici che s’era fatto nel corso della vita, e per il resto ipotecò il suo stipendio di insegnante. Ma espose l’elenco delle offerte e degli offerenti alle porte della chiesa.
L’idea gli era venuta da quando si era accorto che la mafia non solo s’era appropriata delle più belle parole cristiane (come «famiglia», «onore», «amicizia» «fedeltà») stravolgendole, e stravolgendo perfino alcuni riti e devozioni cristiane, ma di fatto insegnava e diffondeva una specie di parodia vissuta del Padre nostro. Anzi, assieme ad alcuni amici, padre Pino aveva provato a esplicitare l’«antipreghiera del mafioso»: quella di chi si rivolge al suo boss riconoscendolo come Padrino della famiglia, il cui nome dev’essere onorato; la cui volontà dev’essere fatta a costo della vita; che dà a tutti i suoi picciotti pane e lavoro; che non ammette il perdono perché è infamità; e che solo può liberare i suoi fedeli dal rischio di cadere in mano dei poliziotti e della Legge. Così è sempre stato e così sarà sempre... Su questo raffronto padre Puglisi impostò anche, per i suoi parrocchiani, una serie di incontri dal titolo significativo: «Itinerario per una catechesi sul Padre nostro a confronto con la cultura e la mentalità mafiose».
E se a qualcuno può sembrare esagerata o esasperata la formulazione di una simile «antipreghiera» e relativa catechesi, gli gioverà leggere — nella sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Palermo — che a Brancaccio il boss in carica era nominato «Madre Natura» («Madre Natura ha mandato a dire di fare questo omicidio»), e il responsabile del «gruppo di fuoco» era noto come «u Signuri» («il Signore», cioè Dio) perché — dicevano i mafiosi nel loro incerto italiano — «aveva il potere di salvare le persone e di poterle ammazzare. Bastava una sua parola per morire o per campare una persona». Ed era anche universalmente noto che il vecchio boss della zona (in carcere da tempo) era soprannominato «il Papa». Così fu creato il «Centro ’Padre Nostro’» (guidato da due religiose «Sorelle dei Poveri» e gestito da un folto gruppo di volontari e amici), in modo che la preghiera insegnata da Gesù potesse mostrare tutta la sua bellezza e la sua efficacia. Vi si tenevano lezioni di recupero scolastico per ragazzi e per adulti; c’era una bibliotechina per adolescenti; un piccolo deposito di medicinali, di giocattoli, di vestiti; vi si poteva avere un pasto caldo (in certi periodi ne furono distribuiti quasi cento al giorno) o trovare sostegno infermieristico e anche consulenza legale) Si organizzavano visite domiciliari, visite ai ragazzi racchiusi nel carcere minorile e alle loro famiglie. E non mancava una piccola macchia di verde per respirare e un giardinetto dove si poteva passeggiare (padre Pino lo usava per i colloqui personali con i ragazzi). Ma la più profonda azione educativa del Centro si realizzava per il solo fatto della sua esistenza e per il nome che aveva. Fin dall’inizio padre Pino s’era immaginato i bambini del quartiere che si dicevano l’un l’altro: «Andiamo al Padre Nostro!», «Io vado al Padre Nostro!», e la strada risuonava di quella notizia ch’era già in se stessa una professione di fede! E difatti uno dei ritornelli dei mafiosi, durante il processo, per motivare l’omicidio, sarà: «Lui si prendeva i bambini.., per non farli cadere, diciamo, nelle mani della mafia...». Fu dopo la «marcia per la vita», organizzata per ricordare la strage di Capaci, che iniziarono intimidazioni sistematiche.
Il giorno dopo la manifestazione fu bruciato il furgone della ditta che eseguiva i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. Poi danneggiarono la povera macchina del prete. Poi furono incendiate contemporaneamente le porte di casa dei tre membri più attivi del Comitato Intercondominiale, poi vennero minacciati dei ragazzi, uno dei quali fu pestato a sangue e inviato con l’ambasceria: «Digli al prete che ci deve lasciar lavorare in pace!». Il Giornale di Sicilia ne diede notizia: «Attentati in serie contro la parrocchia antimafia», ma padre Pino scosse la testa commentando: «Il mio lavoro è sempre stato ’per’, non ’anti’».
E dopo l’incendio delle porte dì casa dei suoi amici aveva sì stigmatizzato il fatto in predica. ma aveva anche inviato un accorato appello ai mandanti: “Sono qui. Sono disposto a parlare. Voi avete vissuto da piccoli in questa chiesa e quindi anche voi siete figli di questa chiesa. A questo punto vi aspetto e ne parliamo...”. E ancora: “Mi rivolgo anche ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi, conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi cerca di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile...”. Preferirono ucciderlo, tentando di far passare l’omicidio per il delitto di un tossicodipendente. Ed era così indifeso che non dovettero affaticarsi nell’esecuzione. Era il giorno del suo compleanno: al mattino aveva celebrato due matrimoni, poi s’era recato in Comune per l’ennesimo inutile tentativo di ottenere quella sospirata scuola media; al pomeriggio si era intrattenuto con alcuni amici per fare insieme un po’ di festa e per ricevere un biglietto di auguri; poi aveva preparato alcuni genitori al battesimo dei loro bambini; poi s’era diretto verso casa per un ultimo incontro con due sposi che desideravano parlargli. Il gruppetto che doveva eliminarlo era nei paraggi, solo per un primo sopralluogo, per studiare la situazione. Ma la situazione era così semplice, la vittima così esposta, che ritennero inutile attendere. Mentre padre Pino infilava la chiave nel portoncino di casa, una mano lo prevenne e si posò sul suo borsello: «Padre, questa è una rapina», disse il complice. Padre Pino si voltò appena: «Me l’aspettavo», disse, con un indimenticabile sorriso buono, mentre l’esecutore gli sparava alla nuca.
Si «aspettava» di dover dare la vita proprio in quell’istante? Non lo sappiamo, perché non vide il suo assassino o forse ne percepì solo confusamente la presenza minacciosa alle spalle.
Ma certo aspettava il compimento della Via Crucis sulla quale s’era liberamente incamminato: sapeva che ogni violenza che lo raggiungeva era una «sacra stazione» del suo cammino verso il Calvario.
In quegli ultimi anni — pur essendo parroco a Brancaccio e padre spirituale del Seminario Maggiore — non aveva voluto abbandonare un incarico a cui teneva molto, quello di cappellano in una casa-rifugio per ragazze madri.
Proprio a loro il giorno prima aveva fatto una stranissima predica sulla passione di Gesù. Aveva detto:
«Quando noi abbiamo paura o proviamo una sensazione intensa di calore, scattano le contrazioni sotto la pelle. Lì ci sono come delle borsette piene che si svuotano e fanno uscire il sudore. Ma quando la contrazione è più forte, perché la paura è diventata angoscia, tensione insopportabile, si rompono i capillari. Ecco perché si dice che Cristo sudò sangue... Sudò sangue per la paura umana del dolore. E sulla croce implorò il Padre di evitargli l’amaro calice prima di unirsi al Suo volere. Tutto questo ci fa sentire ancora di più Cristo vicino a noi, come un fratello. Da questo abbiamo conosciuto l’amore di Dio. Egli ha dato la vita per noi e anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli”. Ora sappiamo che cosa aspettava padre Pino Puglisi: aspettava il momento in cui Cristo crocifisso l’avrebbe abbracciato e stretto a Sé.