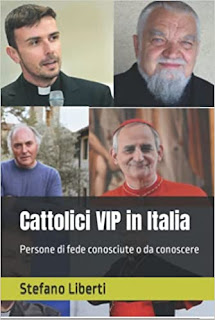Che cosa resta del prete?
Premessa
È, questo che viviamo, ancora un tempo per noi? Un tempo, cioè, per noi che abbiamo accolto e abbracciato la vocazione di diventare preti? Non sono, in verità, molti i segni che dicono che nell’epoca che ci tocca vivere lentamente ma abbastanza seriamente stia come perdendo valore e significato il ministero sacerdotale cui abbiamo deciso di dedicare la nostra esistenza?
I dati statistici circa le nuove vocazioni al sacerdozio, almeno qui nell’Occidente avanzato, non abbisognano di tanti commenti: sono sempre di meno i giovani che entrano nelle schiere di un clero che è già mediamente anziano e i non pochi casi molto anziano. Avremo ancora preti italiani, francesi ed europei in genere da qui a qualche decennio? Difficile non porsi la domanda.
Anche quando poi non già alle prese con la cura del proprio corpo che si ammala e invecchia, i preti adulti sembrano sempre comunque in affanno, in riserva: non hanno letteralmente mai tempo, tante sono le incombenze che loro toccano, tra il tanto sacro e il tanto profano, cui devono dedicare le loro giornate. C’è chi non riesce neppure a preparare una predica come papa Francesco comanda!
Ed ancora: non è forse vero che sono non pochi i casi di sacerdoti che fanno a fatica ad imprimere un minimo di entusiasmo al loro impegno pastorale e che piuttosto portano avanti il ministero come un ininterrotto ciclo di produzione che non dice quasi più nulla alla loro stessa esistenza? Che cosa è rimasto degli anni del Seminario, dello slancio della prima ora, della prontezza con cui si era detto di sì al Signore Gesù?
E che cosa dire poi di fronte a quei confratelli che per le ragioni più disperate – ma aventi a che fare più o meno sempre col sesso e con il denaro – finiscono sulle pagine dei giornali o all’attenzione di quel giornalismo popolare che tanto ama intrattenere i propri spettatori su tali argomenti?
Ma forse la prova più grande che oggi ci tocca vivere e che ci interroga sul profondo circa la nostra presenza in questa società ha a che fare con una sensazione di disagio più generale: il disagio di non riuscire più a comunicare con la parte vitale di quella parte di popolazione che gravita nelle nostre parrocchie e comunità. Penso qui ai tantissimi giovani che stanno ben lontani dai nostri luoghi; penso ancora alle donne giovani adulte o già adulte, le mamme e le lavoratrici per intenderci, le quali, terminato il cammino di iniziazione dei loro figli, sembrano non avere più tempo né interesse per ciò che noi preti diciamo e celebriamo; penso ancora agli uomini e alle donne di cultura o delle istituzioni pubbliche di un certo rilievo, i quali, pur nel rispetto per la realtà ecclesiale e per noi suoi rappresentanti, celano sotto sotto l’idea di aver a che fare con noi e con il nostro lavoro come con un piccolo souvenir di un mondo che fu. Li vedi così a qualche battesimo, matrimonio, funerale e quasi più nessuno di loro ricorda neppure quando è il momento di alzarsi oppure di sedersi.
Ma possiamo dimenticarci di quelli che in Chiesa ancora ci vengono? Non alberga da qualche parte nel nostro cuore la seguente domanda: davvero ci stanno ascoltando? Sul serio riusciranno a misurare i parametri del loro vivere quotidiano alla luce di quella bella ma impegnativa parola di Gesù che tramite noi li raggiunge di domenica in domenica? Non sembra anche in questo caso che tali persone, alla fine dei conti, per ciò che davvero conta nella loro vita siano loro a decidere quale o quanto Vangelo mettere in pratica? E noi, a che serviamo allora?
Ci restano, certo, i poveri, che di frequente bussano alla nostra porta: la solidarietà è fuori discussione, ma il fatto che ritornino così spesso e che ai quelli della prima ora se ne aggiungano altri di continuo e che quasi nessuno riesca ad uscire da questa immensa catena umana di persone che semplicemente faticano a mettere insieme il pranzo con la cena getta, pure questo, un po’ di tristezza. Quanta povertà genera questo tempo e si troverà forse un qualche punto di equilibrio in questa strana economia che governa il mondo?
E forse è qui che troviamo anche noi, in questa riflessione, un primo punto di sintesi: questo tempo che viviamo è per noi preti, innanzitutto, un tempo di povertà; sì, anche noi fatichiamo a mettere insieme lodi e compieta, in quanto viviamo un momento storico in cui abbiamo perso alcune coordinate culturali e sociali che hanno dato sino a giorni non molto lontani dai nostri un contesto, uno charme e una fisionomia chiara al nostro essere preti. Ed è da qui che si deve forse partire per poter rispondere alla domanda sul come sia possibile oggi continuare a essere preti.
Quel che abbiamo perso
Quello che viviamo è un tempo di povertà per noi preti. Siamo chiamati al nostro ministero di annuncio del Vangelo e di guida delle comunità a noi affidate senza poter far più affidamento ad alcuni sostegni che sono stati di grande forza sino ad un passato recente: siamo così preti senza disporre più di un linguaggio dell’umano che sia condiviso tra esperienza del vivere e quella del credere, senza godere più di una credibilità personale e di gruppo che naturalmente ispirava fiducia in chi ci accostava, senza ancora poter più appoggiare la nostra specifica autorevolezza su archetipi e immaginari diffusi, senza infine sapere quanto ancora le risorse economiche sinora messe a nostra disposizione ci aiuteranno mantenere in piedi e “in buona forma” le tante strutture e iniziative sui cui facciamo girare la vita delle comunità. Proviamo a meglio entrare nei dettagli di un tale nuovo scenario in cui si gioca oggi il nostro impegno sacerdotale.
Tutti sappiamo e diciamo che è finita la cristianità. Siamo infatti nell’epoca della postmodernità, che non è semplicemente un’epoca di cambiamento ma un vero e proprio cambio d’epoca. Ma tale evento non è qualcosa che lascia indenne la figura e il ruolo del prete, inteso qui soprattutto come annunciatore del Vangelo. Quando si dice che la cristianità è finita, si tratta propriamente di prendere coscienza che quell’unità di cultura e quella cultura di unità, vigente in Occidente sino alla rivoluzione culturale del Sessantotto, non c’è più. Non solo: si tratta pure di capire che non c’è quasi più alcun riferimento e alcuna osmosi vivente tra le istruzioni per vivere e quelle per credere. Sotto questa luce il cambiamento d’epoca che viviamo e che annuncia la fine della cristianità, fa sì che tra me e mio nonno ci sia molta più differenza nell’intendere l’umano che tra mio nonno e un qualsiasi cittadino medio del Medioevo!
Per provare ora a meglio visualizzare un tale cambiamento, si faccia mente al fatto che noi diventiamo umani e cittadini di un dato tempo, facendo nostro il linguaggio umano in generale e più specificatamente il linguaggio di quel dato contesto storico e culturale, che tradisce ed indica un ordine delle cose del mondo e del mondo delle cose. Il linguaggio è il luogo dove si sedimenta l’immaginario condiviso e che comanda l’apprezzamento del reale, cioè ciò che noi diciamo i valori di fondo. Ebbene negli ultimi decenni, con l’imporsi della cultura postmoderna, abbiamo assistito ad un mutamento delle parole e del loro ordine, all’eclissi di alcune e all’emergere di altre. Sino agli anni Ottanta del secolo scorso le parole decisive della vita umana erano eternità, paradiso, verità, natura, legge naturale, fissità, maturità, adultità, spirito, mascolinità, sobrietà, sacrificio, rinuncia, autorità, diritto, tradizione. Oggi, al centro della nostra sensibilità immediata, del nostro essere abitanti di questo tempo e di questo spazio culturale, si trovano le parole finitezza, alterità, pluralismo, tolleranza, sentimento, tecnica, salute, cambiamento, aggiornamento, corporeità, donna, consumo, benessere, giovinezza, longevità, singolarità, sessualità, democrazia, convinzione, comunicazione, partecipazione.
Esattamente questo provoca – e qui è il punto – la rottura della cristianità, cioè di quella unità tra cultura e fede, tra esistenza e preghiera, tra quotidiano e santo, che, non senza qualche ombra come è naturale che sia, ha molto favorito il lavoro della Chiesa e di noi preti: in casa, a scuola, per la strada i codici linguistici – umano e credente – passavano facilmente da una parte all’altra. Ciò non ci è più dato. Assistiamo perciò ad un divenire estraneo del cristianesimo all’uomo comune; più in generale la stessa questione di Dio non appare più qualcosa di veramente decisivo per una vita umana qualificata come riuscita ed infine quasi più nessuno di noi riesce a trovare il giusto stile e la giusta frequenza per trasmettere la fede alle nuove generazioni.
Viviamo in tempo poi che ci spoglia di quell’aura di credibilità derivante dalle nostre scelte che sempre sono apparse forti e controtendenza rispetto alla vita ordinaria della gente: l’obbedienza, la povertà e la castità. Ma quanti scandali si sono abbattuti sull’intera nostra categoria negli ultimi anni! Quante ferite ha dovuto subire e di continuo subisce la credibilità dell’immagine complessiva del prete. In un tempo in cui non si crede più alla grazia, all’azione dello Spirito santo, alla forza della preghiera ed in cui ben più naturalmente ci si lascia ispirare dalla potenza della psicologia, i preti rischiano di risultare sospetti proprio per queste scelte così forti e rigide, proprio per essere gli ultimi rimasti che non si vogliano arrendere, almeno come scelta di fondo, all’invasività del discorso del sesso, del denaro e dell’autodeterminazione. Che strana parabola, dunque, ci capita di vivere: dal tempo in cui proprio perché casti, poveri e obbedienti ispiravamo tanta fiducia ad un tempo in cui proprio perché casti, poveri e obbedienti siamo costantemente sottoposti ad una sorta di permanente controllo qualità che genera inevitabilmente sfiducia e risentimento.
Ancora più in profondità dobbiamo riconoscere che ciò di cui soffriamo è il venire meno nella nostra cultura del “discorso del padre”, la perdita cioè di autorevolezza dell’autorevolezza, la scomparsa della qualità adulta dell’umano. I genitori e gli educatori sono stati per così dire invasi dall’ansia della cura, della preoccupazione, del controllo, della manutenzione indolore e asettica della vita di coloro che sono loro affidati e risultano così incapaci di asimmetria, di conflitto, di generatività. Viene meno l’idea che volere bene a qualcuno a noi affidato sia sempre da coniugare con il volere il suo bene: il volere cioè la sua crescita, la sua emancipazione dalla nostra orbita, la sua capacità di stare con le sue solo gambe da solo davanti al mondo e alla storia, certo grazie a noi, ma soprattutto senza di noi. Dove possiamo pertanto oggi appoggiare nell’immaginario diffuso il nostro essere “i più anziani” (traduzione letterale di presbiteri), i più saggi, i più adulti, in un tempo in cui gli adulti non vogliono più essere adulti, in cui non sono più disposti a rinunciare al proprio ego per far posto alla presa in carico d’altri che è sempre finalizzata al lasciarlo crescere in autonomia e per questo sanno fare spazio anche a quel lato “ruvido” che pur appartiene al gesto educativo? Non c’è il rischio che anche il prete si trasformi per i nostri ragazzi e per i nostri giovani, come le loro mamma e i loro papà, in una sorta di amico, di “falso giovane”, di povero cretino caduto sotto la pressione del discorso del mercato? E se invece prenderà sul serio il mestiere dell’adulto, non dovrà il prete trovare il coraggio di affrontare i tanti “falsi giovani” con cui deve condividere la responsabilità educativa delle nuove generazioni? Si vede bene qui che le così tanto amate alleanze casa-scuola-oratorio vanno del tutto ripensate e ristrutturate.
Merita ancora un accenno la questione economica. Veniamo da tempi di vacche grasse e forse ancora siamo in quei tempi, ma si annunciano delle ombre all’orizzonte e probabilmente, tra il calo delle offerte private e la riduzione dei finanziamenti statali, sarà necessario un ripensamento di come potremo realizzare la gestione economica delle nostre strutture, a volte davvero enormi. In molti paesi del nord Europa è ormai una questione d’ogni giorno quella della vendita degli edifici sacri per mancanza di fondi per la loro manutenzione, oltre che per quella di personale ecclesiale da destinarvi. Come iniziare a ripensare tutto ciò? Che cosa sarà veramente essenziale da conservare e di cosa si potrà invece fare a meno? Come evitare che il necessario lavoro per il reperimento di risorse economiche utili per la vita della comunità non assorba e non inquini la libertà del nostro ministero pastorale e la forza della nostra parola profetica?
E da ultimo come dimenticare l’aumento della vita media di tutti e quindi anche nostra? Ce la faremo con la nostra pensione a far fronte ai tanti nuovi inediti che la condizione longeva dell’umanità ci pone davanti? E sarà davvero possibile essere fedeli alla nostra scelta di prete per un periodo così lungo di anni?
Come è dunque possibile tutto ciò?
Ciò che non abbiamo ancora afferrato
Non sarebbe però del tutto completa la descrizione dello scenario in cui oggi siamo chiamati a vivere l’avventura della nostra esperienza sacerdotale se non tenessimo insieme conto delle tante opportunità che, proprio questo tempo che pur ci mette tanto alla prova, ci offre.
La prima di tali opportunità è sicuramente il coraggio che ci viene dal recente magistero petrino. Penso qui alla centralità del tema della nuova evangelizzazione e dell’attenzione ai giovani in san Giovanni Paolo II, penso ancora alla centralità della questione della fede in Benedetto XVI e penso, infine, all’appello di papa Francesco al tema della creatività pastorale, anche a rischio di qualche caduta e di quale accidente di percorso.
Mi piace così sottolineare che la parola creatività ritorni in Evangelii gaudium diverse volte (11, 28, 134, 145, 156, 278) ed è in fondo come l’invito ad immaginare percorsi nuovi e proposte innovative. Ebbene, è una cosa di cui tutti siamo convinti, una cosa che sentiamo a pelle: tanti nostri gesti di fede che proponiamo non funzionano più o almeno non funzionano più bene come noi ci attenderemmo. Basterebbe pensare ai percorsi di iniziazione cristiana o all’impegno per la pastorale giovanile. Ed è proprio per questo che papa Francesco ci invita a non temere di cambiare, dando vita pure ad un curioso neologismo: «Primerear – prendere l’iniziativa».
Il nostro è allora il tempo per la presa di una parola nuova, di una nuova immaginazione evangelizzatrice, di una nuova stagione della vita parrocchiale. Faccio eco a due espressioni assai concrete di papa Francesco: la prima, al numero 73 di Evangelii gaudium, dove, ricordando i grandi cambiamenti avvenuti nelle città, richiede di «immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane»; la seconda riguarda la bella difesa che egli fa della parrocchia, sempre in Evangelii gaudium (qui n. 28), ma con l’indicazione che essa necessita della docilità e della creatività missionaria del pastore e della comunità: la parrocchia è dotata di «grande plasticità» e «può assumere forme molto diverse». E chi dovrebbe prendere l’iniziativa in tutto questo se non appunto noi preti?
La seconda opportunità che questo tempo ci offre è quella di essere quasi gli ultimi custodi e profeti di quell’umanesimo della cura adulta delle relazioni private e pubbliche di cui si sta perdendo troppo velocemente traccia e memoria. La nostra condizione di soglia rispetto al gioco fin troppo vischioso delle strategie educative e rispetto alle contorsioni individualistiche e narcisistiche del discorso socio-politico ci permette di rilanciare la vera scommessa aperta della nostra società: ci servono gli adulti, adulti veri, capaci di tenere a bada le pulsioni del proprio io e di mettere al centro della propria esistenza la cura d’altri, sia in termini di emancipazione dei figli che in termini di sostenibilità del loro diritto di succedere semplicemente a noi nella catena delle generazioni umane.
La terza opportunità che ci dona il tempo che ci è dato vivere sta nel fatto che, per quanto ammaccati e in parte sfiduciati almeno come categoria, possiamo ancora far valere il diritto di Dio di essere Dio. Nulla di umano, per quanto teso all’infinito delle sue risorse, potrà mai surrogare Dio. Penso qui alla sessualità, al lavoro esasperato, all’accumulo di denaro, alle illusioni della bioingegneria, al potere esercitato sino alla propria morte. Ciò che è terrestre resta terrestre anche se ammantato di paramenti divini. E forse proprio a causa dei tanti scandali scatenati dai alcuni nostri confratelli, riscopriamo ancora meglio che in quanto preti, non abbiamo mai preteso di essere altro che semplici rinvii, link, mediatori, piccoli «pontefici», alla lettera costruttori di ponti: di essere semplici dita che indicano la luna e mai abbiamo pensato di essere la luna. Ebbene, il nostro compito è e resterà sempre quello di ricordare ancora la parola ultima di ogni autentica salvezza: è Dio che ci assolve dalla necessità e terribile illusione di salvare noi stessi, gli altri e il mondo.
La quarta opportunità di oggi per noi preti è forse quella di fare i conti con i nostri investimenti economici che forse non sono semplicemente economici. Ci serve ancora una chiesa come «istituzione totale» all’interno di un quartiere o di un piccolo centro di periferia; una chiesa che si occupi di tutto, dalla culla al cimitero? Ci servono ancora tante strutture? E se invece oggi ci venisse chiesto più semplicemente di insegnare agli uomini e alle donne l’antica arte del pregare e del relazionarsi all’altro con libertà e fiducia?
Per concludere
La domanda finale non può che essere la seguente: che cosa resta del prete oggi? Qual è il nucleo irrinunciabile della sua presenza e della sua missione in questo nostro mondo, che sempre di più sembra fare a meno del Dio del Vangelo e della Chiesa? A me pare che ciò che resta del prete sia la funzione di rappresentare un punto mancante in questo meccanismo quasi assoluto di singolarità autoreferenziali, più o meno infelicemente tenute insieme dal meccanismo di produzione e smistamento delle merci. In tale contesto, la sua missione mi pare essere proprio quella di ricordare la grande «utilità» che riveste il sentimento della mancanza all’interno della struttura dell’umano: quel vuoto intorno al quale orbita ogni esistenza umana, quella precarietà originaria di cui siamo tutti impastati.
L’uomo, infatti, non vive solo di ciò che possiede e tiene stretto tra le sue mani ma anche di ciò che gli manca, di ciò che non ha. Ecco dunque ciò che resta del prete oggi: egli è colui che, con il suo corpo, con le sue scelte ancora tanto impopolari, con il suo stile di vita, ricorda che ciò che oggi rischia di mancare di più – e che forse farebbe vivere tutti più da umani – è la mancanza.