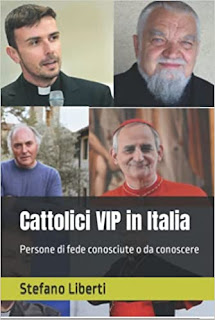I Parte: sinodalità e collaborazione nel presbiterio
1. Resistenze alla fraternità presbiterale
“I sacerdoti sono uniti in una fraternità sacramentale, pertanto la prima forma di evangelizzazione è la testimonianza di fraternità e di comunione tra loro e con il Vescovo”. Così papa Francesco nel discorso del 3 ottobre 2014 alla plenaria della Congregazione per il clero. Se il vescovo e il presbitero sono servi della comunione ecclesiale, essi non possono certamente esserli chiudendosi in un dorato isolamento o in atteggiamenti ieratici o cedendo alla mondanità dell’individualismo imperante. Essi sono chiamati a vivere la comunione anzitutto tra di loro, tra di loro presbiteri, e tra presbiteri e vescovo, pena, la smentita del loro ministero, la loro non-credibilità. La loro concreta fraternità è la loro prima testimonianza e forma di evangelizzazione. Prima di ogni preoccupazione pastorale, di ogni attività organizzativa, anche di ogni celebrazione cultuale, il ministero presbiterale si caratterizza per questa fraternità. Secondo il vangelo di Marco, Gesù, dopo aver stabilito i Dodici “perché stessero con lui e per inviarli a predicare” (Mc 3,14), li inviò “a due a due” (Mc 6,7; cf. anche Lc 10,1). Perché la prima e fondamentale testimonianza a Cristo e al vangelo passa attraverso la capacità relazionale, la capacità di incontro e sopportazione, e magari anche la concreta carità vissuta reciprocamente. “Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri”. Certo, questa fraternità incontra in realtà numerose resistenze nel vissuto personale dei presbiteri. Perché?
Il prevalere del ruolo
1. Anzitutto, c’è il rischio del prevalere del ruolo: un rischio è divenire funzionari, magari efficienti, iperattivi (e il peso delle cose da fare è a volte davvero eccessivo), dimenticando la cosa più importante, ovvero, la costruzione della propria umanità, l’attenzione alle virtù umane, alla relazione con gli altri. In verità, tendere concretamente a vivere il proprio presbiterato insieme, con gli altri presbiteri, ovvero, nel corpo presbiterale di una diocesi, è molto più impegnativo e faticoso che fare le cose da soli, senza gli altri, realizzando di fatto la figura di un piccolo manager piuttosto che di un servo della comunione, e configurando la comunità ecclesiale come macchina o azienda piuttosto che come corpo. Ma questo è cedere alla tentazione dell’individualismo dominante. È fare come fanno tutti. Le parole di Gesù ai Dodici nell’ultima cena secondo il vangelo di Luca portano un’indicazione che regola il ministero apostolico nei confronti della mondanità: “Voi però non così” (Vos autem non sic: Lc 22,26). L’avversativa dice che c’è una lotta da fare.
La fatica di amare chi non si è scelto
2. L’attenzione alla fraternità presbiterale implica un’attenzione agli altri e un lavoro su di sé. Perché prima che presbiteri siete uomini chiamati ad amare. E amare è un lavoro, una fatica esigente. Per giungere a relazioni improntate a fraternità e amore, o almeno a rispetto e carità nel presbiterio, occorre esercitarsi all’arte di amare chi non si è scelto. Se nel matrimonio i partner si scelgono in base all’attrazione e all’amore, ai sentimenti, nel presbiterio si è chiamati a cercare di amare chi ci è dato come co-presbitero. Si tratta di andare al di là di simpatie e antipatie per mettere in atto l’amore intelligente secondo il vangelo. Un amore nell’obbedienza. Un amore che è obbedienza. Un amore che è effettivo ancor più che affettivo e si nutre di disponibilità alla collaborazione e anche di attenzione all’altro, ai suoi momenti di difficoltà, alle sue solitudini.
La resistenza al cambiamento e alla conversione
3. Se quanto detto è vero, la resistenza alla fraternità, che diviene poi difficoltà a un lavoro insieme, alla sinodalità, è resistenza a quel concreto cambiamento di sé in cui consiste la conversione. Chiediamo agli altri la conversione con la predicazione, ma noi siamo disposti a cambiare? Accettiamo il lavoro trasformativo su di noi che viene grazie alla relazione attiva e concreta con gli altri, e anzitutto con gli altri presbiteri? Tertulliano scriveva che unus christianus, nullus christianus, ovvero, che il cristiano esiste sempre in un corpo, in un insieme, in una relazione, non da solo, quanto più questo vale per il presbitero che è a servizio della comunione del corpo ecclesiale e che fa del presbitero, di ogni presbitero una delle membra che formano il corpo. Quel corpo che è anzitutto il presbiterio, nella comunione tra presbiteri tra di loro e tra presbiteri e vescovo.
2. Chiamati alla sinodalità
Il ministero ricevuto pone il presbitero a servizio della comunione della comunità cristiana. Egli, dice il Concilio Vaticano II “è stato consacrato per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino” (LG 28). Questo compito egli lo svolge nella coscienza di essere in mezzo a un popolo di consacrati, cioè di uomini e donne “unti” (il NT usa il verbo chríein), “santificati” (il NT usa il verbo haghiàzein) mediante il battesimo, un popolo di “messianici”, potremmo dire, perché discepoli di Gesù il Messia. Il compito del vescovo e del presbitero è quello di porsi a servizio del camminare insieme della comunità nella comunione e nella diversità dei carismi. Ora, fin dall’epoca neotestamentaria la sinodalità è la pratica ecclesiale della comunione.
Se il cristianesimo viene chiamato “la via” (hodòs: At 9,2; 18,25-26; ecc.), la modalità di viverlo è il sýn-odos, “il cammino fatto insieme”. Nella chiesa, che è corpo del Signore nella storia, un’unica linfa vitale scorre nelle varie membra sicché costitutivo della pratica ecclesiale è il fare le cose insieme (sýn) e nella reciprocità, gli uni per gli altri (allélon). Anzitutto, insieme: Paolo parla di collaborare (Fil 1,27; 4,3), di con-soffrire (1Cor 12,26), di con-gioire (Fil 2,17), di con-riposare (Rm 15,32), di con-vivere (2Cor 7,3), ecc. Paolo crea neologismi in greco per accentuare questa dimensione comunionale che deve divenire pratica quotidiana nella vita ecclesiale. Poi Paolo parla di reciprocità: si tratta di pregare gli uni per gli altri (Gc 5,16), di perdonarsi gli uni gli altri (Ef 4,32), di correggersi gli uni gli altri (Rm 15,14), di consolarsi a vicenda (1Ts 4,18; 5,11), di sopportarsi gli uni gli altri (Col 3,13), di accogliersi gli uni gli altri (Rm 15,7), in una parola, di amarsi gli uni gli altri (cf. Gv 13,34). Nel discorso di Paolo in 1Cor 12 sulla chiesa come corpo formato di molte e diverse membra l’apostolo afferma che come nel corpo nessun membro può dire all’altro “io non ho bisogno di te” (1Cor 12,21), così nella chiesa nessuna componente ecclesiale può fare le cose senza o contro le altre né al di sopra o all’insaputa delle altre. La chiesa è il luogo della povertà condivisa: la comunione nasce non dall’accumulo delle forze e competenze dell’uno e dell’altro, ma dalla condivisione delle povertà di ciascuno.
Il NT presenta la prassi sinodale all’opera in alcuni momenti decisivi della vita ecclesiale e non la presenta mai nella forma di una democrazia diretta, ma nell’articolazione tra “tutti”, “alcuni” e “uno solo”. Gesù, durante la sua vita, fra tutti i discepoli ne ha scelti alcuni (i Dodici) e tra questi ha distinto Pietro (uno solo). Al momento di completare il collegio dei Dodici (alcuni) menomato per la defezione di Giuda, Pietro (uno solo) si rivolge all’assemblea plenaria dei fratelli (tutti) che propone due nomi. Dopo aver pregato, viene tirata la sorte e scelto Mattia (At 1,15-26). Questa logica partecipativa è all’opera anche al momento di risolvere una tensione sorta fra cristiani di origine palestinese e cristiani ellenisti circa il sostentamento da assicurare alle rispettive vedove: non si agisce di autorità, ma i Dodici formulano una proposta che, approvata da tutta l’assemblea, porta alla decisione (At 6,1-7). Il cosiddetto Concilio di Gerusalemme (At 15), in realtà un incontro in cui si è pervenuti a un accordo tra chiese che erano in contrasto su un punto preciso, l’obbligatorietà o meno della circoncisione e dell’osservanza della Legge mosaica da parte dei cristiani provenienti dal mondo pagano, mostra bene lo stile sinodale presentando interventi di autorità delle chiese, riunioni ristrette e infine riunioni assembleari, in plenaria, diremmo noi.
Ora, il principio sinodale, ovvero la strutturazione a piramide rovesciata “tutti-alcuni-uno”, si accompagna al principio di strutturazione della comunione per cui vi è un primato. Nella chiesa non si dà sinodalità senza primato, né primato senza sinodalità. Il Nuovo Testamento, proprio nel passo paolino in cui con più chiarezza si parla della chiesa come corpo articolato in membra diverse con differenti funzioni ma tutte convergenti verso l’unità dell’insieme, esprime la strutturazione della comunione ecclesiale con il ricorso alla gerarchizzazione del “primo, secondo, terzo”: “Dio ha posto alcuni nella chiesa in primo luogo (próton) come apostoli, in secondo luogo (deúteron) come profeti, in terzo luogo (tríton) come maestri” (1Cor 12,28; cf. Rm 12,6-8; 1Cor 12,7-11; Ef 4,11). E la comunità ecclesiale vede i presbiteri costituire insieme al loro vescovo un unico presbiterio. Se il vescovo è chiamato ad assumere e ad esercitare una concreta paternità nei confronti dei suoi preti, rendendosi disponibile ad incontrarli, interessandosi della loro vita, della loro salute, delle condizioni in cui vivono, così i preti sono chiamati ad entrare con il loro vescovo in un rapporto leale, onesto, schietto, rispettoso, collaborativo. Un rapporto non di adulazione, ma di rispetto, non di ribellione e di maldicenza, ma di parresía. Io non intendo soffermarmi sui fondamenti teologici della comunione tra presbiteri e tra presbiteri e vescovo, sulla necessità che il presbiterio, come dice Ignazio di Antiochia, sia “armonicamente unito al vescovo come le corde sono unite alla cetra” (Agli Efesini 4,1), ma voglio solo ricordare alcuni atteggiamenti esistenziali e spirituali che possono rendere possibile nel concreto la comunione presbiterale e tra preti e vescovo. Atteggiamenti da porre in atto certamente nelle riunioni, nelle assemblee, nelle giornate di aggiornamento e nei vari consigli, per esempio nel consiglio presbiterale, dunque nelle istituzioni sinodali, ma che, più in generale, devono reggere la relazione quotidiana tra presbiteri e tra presbiteri e vescovo.
3. La prassi della sinodalità e della collaborazione nel presbiterio
Anzitutto è importante che il vescovo vigili perché ci sia una buona informazione di tutti i presbiteri circa la vita diocesana. Una dimensione della sinodalità è l’informazione. L’informazione tende all’edificazione del corpo ecclesiale. È importante che i presbiteri conoscano con chiarezza le linee di governo del vescovo, conoscano motivazioni e finalità dell’agire pastorale che viene loro richiesto, altrimenti, presto o tardi, ci si troverà di fronte a un rifiuto inconscio o anche aperto della decisione. Ci si troverà di fronte a una demotivazione, a un divorzio se non dal ministero, almeno dalla volontà di impegnarsi.
Da parte dei presbiteri occorre la volontà di essere presenti alle occasioni di incontro e di fraternità e di non cedere troppo facilmente alla tentazione di dire “Non servono a nulla”, “sono inutili”, “tanto non cambia mai niente”. Occorre accettare di essere scomodati. E combattere la pigrizia, il cinismo e la sfiducia.
Perché la fraternità divenga responsabilità e corresponsabilità tra presbiteri e tra presbiteri e vescovo occorre mettere in atto diversi atteggiamenti relazionali che comportano un impegnativo lavoro su di sé e la disponibilità a sempre ricominciare.
1. Serietà. Si tratta di prendere sul serio ciò che si fa: il proprio e l’altrui ministero, la propria vita di fede e di preghiera, le relazioni con gli altri, … In particolare, si tratta di prendere sul serio le occasioni sinodali e i momenti assembleari disponendosi a una partecipazione convinta e attiva.
2. Rispetto. Mi riferisco al rispetto dei preti tra di loro e del prete verso il vescovo e viceversa. Ma è anche rispetto delle opinioni diverse dalla propria, rispetto delle debolezze dell’altro. Rispetto è anche capacità di vedere (re-spicere) i propri limiti, le proprie debolezze, per non travalicare, per non peccare di hybris, per non cadere nell’arroganza, nella prepotenza, nel disprezzo.
3. Fiducia. Un vescovo è il primo responsabile della creazione di un clima di fiducia reciproca nel presbiterio. La sua disponibilità all’ascolto e all’incontro dei suoi preti, il suo prendersi cura delle situazioni che gli vengono presentate, nella coscienza che la sollecitudine per i presbiteri è il suo primo compito, il suo essere “di parola”, il suo ricordarsi delle situazioni di ciascuno, tutto questo favorisce un clima di fiducia e fa sentire come affidabile il vescovo stesso. Ovvio che questa apertura di fiducia deve vigere anche nei presbiteri e tra di loro. Senza fiducia non vi è alcuna possibilità di comunione e di fraternità.
4. Lealtà. Sulla fiducia si costruisce la lealtà, che è legame di alleanza con gli altri, accordo per costruire insieme e camminare insieme. La lealtà è impegno della volontà che si orienta verso un fine comune, un obiettivo non individualistico, ma comune.
5. Sincerità. La sincerità accompagna la lealtà e impedisce di nascondere, celare, mentire, dire verità parziali. Uno dei significati etimologici del termine “sincerità” rinvia a “senza cera”, in riferimento agli scultori che non facevano ricorso alla cera per mascherare i difetti delle loro opere. L’idea sarebbe quella di “genuino”, “autentico”, “senza finzione”. Sincerità rinvia anche a quella parresía che è libertà di parola e che deve contraddistinguere ogni riunione sinodale e ogni rapporto intraecclesiale autentico. Sincerità si deve accompagnare a chiarezza di comunicazione, perché caritas è anche claritas.
6. Responsabilità. La responsabilità mi situa in rapporto vitale con Dio e con gli altri e mi spinge a rispondere di me, di ciò che faccio, del ministero che ho ricevuto, della mia vita di fronte al Signore, di fronte alla mia coscienza, di fronte alla comunità. E anche, per il presbitero, di fronte al vescovo. Della responsabilità fa parte costitutiva, anche etimologicamente, la parola, la risposta. Una piena responsabilità non può essere muta o non comunicativa.
7. Discrezione. Va infine ricordata la necessaria, anzi vitale, discrezione. Discrezione da parte del vescovo che si trova a conoscere dettagli di situazioni ecclesiali e personali di presbiteri che richiedono di non essere divulgati, discrezione da parte di ogni presbitero per non cadere in quella tentazione così spesso stigmatizzata da papa Francesco della chiacchiera, della mormorazione, del parlar male degli altri, del vescovo o di altri presbiteri.
II Parte: ascolto, parola, affettività
Queste osservazioni ci introducono nella seconda parte della mia relazione in cui individuo tre punti cruciali su cui si costruiscono la fraternità e la comunione presbiterale: l’ascolto, la parola, l’affettività.
1. L’ascolto
Il ministero affidato ai presbiteri, secondo il Nuovo Testamento, è ministero della Parola, parola celebrata, annunciata, testimoniata. I presbiteri sono affidati alla Parola di Dio, dice Paolo in At 20,32). Il ché significa che essi, per essere servi della parola di Dio, devono ascoltarla ogni giorno, farne il loro nutrimento spirituale quotidiano, il loro pane quotidiano. E devono divenire uomini di ascolto a servizio di quella chiesa che si pone davanti a Dio “in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia ” (come recita il Prologo della Dei Verbum). Lì si afferma che la Chiesa esiste in quanto serva della Parola di Dio, sotto la parola di Dio, nel doppio movimento di ascolto e annuncio della parola di Dio: “è come se l’intera vita della Chiesa fosse raccolta in questo ascolto da cui solamente può procedere ogni suo atto di parola”, scrisse il teologo Joseph Ratzinger commentando il passo di DV. Per essere ecclesia docens, la Chiesa deve essere ecclesia audiens. Ora, il presbitero, a servizio della comunione ecclesiale che nasce dall’ascolto della parola di Dio, come potrebbe lui sottrarsi a questo imperativo dell’ascolto? Il ministero della Parola non può che essere anche ministero di ascolto. Della parola di Dio certo, nella lectio personale come nella liturgia, ma poi di ascolto degli altri. Diventare un uomo capace di ascolto: questo è vitale per il lavoro pastorale (dove un presbitero ha relazioni a 360 gradi e deve diventare esperto in relazioni differenziate: con bambini e anziani, con sposi e fidanzati, con malati e morenti, con giovani, ecc.) e questo è essenziale anche per i rapporti tra presbiteri. Chiediamoci: che cos’è ascoltare? Che cosa richiede? Una fraternità presbiterale e una comunione nella comunità, si creano a partire dalla qualità del vostro ascolto.
1. L’ascolto è un atto intenzionale. A differenza del sentire che è meccanico, automatico, l’ascolto esige una decisione, una volontà. L’ascolto esige concentrazione, rientrare in sé, rispettare ciò che si ascolta senza manipolare, senza forzare, senza interpretare arbitrariamente. L’ascolto tende a far emergere ciò che l’altro dice e sente per far emergere chi l’altro è. Ascoltare è impegno di tutta la persona, è un essere presenti all’altro senza riserve, senza distrazioni, con piena attenzione. Nell’ascolto tento di comprendere l’altro coinvolgendomi con lui. Un ascolto distaccato, asettico, non coinvolto, semplicemente fallisce l’incontro a cui l’ascolto vuole condurre. L’ascolto come fatica tesa alla comprensione dell’altro è atto che tende all’accoglienza dentro di sé dell’altro (cum-prehendere). La fraternità presbiterale e l’amore pastorale nascono dalla volontà di ascolto.
2. L’ascolto non ascolta solamente le parole e le frasi ma anche il corpo. Anche il corpo parla, anzi normalmente il corpo non mente a differenza delle parole che mascherano o mentono apertamente. Nella comunicazione umana sappiamo che i gesti, il tono della voce, i lineamenti del volto, le posture del corpo, gli sguardi, comunicano molto di più del contenuto delle parole. Ascoltare è anche osservare, fare attenzione, cogliere i tic verbali e i movimenti del corpo che si accompagnano alle parole dette, notare i riflessi emotivi che sottolineano certi passaggi del parlare dell’altro. Ascoltare l’atteggiamento del confratello presbitero che vedo preoccupato, teso, e che, forse, attende solo qualcuno che gli offra la possibilità di dire ciò che lo sta facendo soffrire. Certi abbandoni della vita presbiterale forse si sarebbero potuti evitare se il prete avesse avuto l’occasione (certo, anche il coraggio) di dire ciò gli gravava sul cuore, la crisi che stava vivendo.
3. L’ascolto suppone che si rompa con i pregiudizi sull’altro. Precomprensioni, etichette e pregiudizi sono un impedimento all’ascolto. Ascoltare significa operare una purificazione delle idee che avevamo sull’altro. Il nostro ascolto sincero può provocare un cambiamento anche in colui che tutti giudicano impossibilitato a cambiare. L’altro non è una categoria, ma una persona, un volto, una unicità irripetibile. E questo io lo riconosco solo con l’ascolto. Occorre essere aperti alle smentite e alla novità quando ci si dispone all’ascolto. Il rischio è quello di proiettare sull’altro le cose che sappiamo di lui o quelle che crediamo di sapere. Ascoltare significa uscire dalla pigrizia per cui etichettiamo l’altro e ingessiamo i rapporti con lui arrivando a cadere, a volte, in rapporti tra presbiteri superficiali o infantili, solamente scherzosi o banali. Rapporti regressivi.
4. Ascoltare significa dare tempo all’altro. La fretta è nemica di un buon ascolto. Occorre rimettersi ai tempi dell’altro, non forzargli la mano, ma acconsentire ai suoi tempi perché arrivi a dire ciò che vuole dire. Ascoltare è, come io preferisco dire, dare ascolto. Dare ascolto, dare tempo è dare vita. Spendere la propria vita, donare il proprio tempo perché l’altro sia e viva. Spesso l’altro fatica a trovare le parole, ha vergogna di quel che pure vorrebbe dire, fatica a esprimere ciò che intende significare, parla in modo non chiaro, non padroneggia le parole, spesso la comunicazione è una sofferenza, e l’ascolto una vera ascesi. Ma guai a far sentire all’altro che non si ha tempo, che lo si ascolta guardando l’orologio. L’altro deve sapere che ha tempo e che può dirsi. Soprattutto quando vuole e cerca di dire cose pesanti, di cui si vergogna: più che mai allora deve trovare una persona che lo accoglie incondizionatamente. Se l’altro, ascoltandomi mi accoglie in ciò che io sento di irricevibile in me, allora anch’io posso accogliermi. Posso dirmi di sì, se un altro me lo dice con il suo ascolto. Ascoltare è dire di sì all’altro e apprestargli uno spazio di rinascita. L’ascolto crea fiducia, che è la matrice della vita.
5. Ascoltare è ospitare. L’ascolto è atto di ospitalità verso l’altro. Occorre pertanto sgombrare il proprio io da pensieri, distrazioni, rumori, immagini che riempono e non lasciano spazio all’altro di trovare dimora. Se il nostro cuore trabocca di preoccupazioni, sofferenze, pensieri autocentrati, non si rende libero per ascoltare e chiude all’altro la porta e la possibilità di entrare in sé. L’ospitalità dell’ascolto si deve accompagnare al pudore e alla discrezione. L’altro ci fa fiducia consegnandoci timori, problemi, paure, parole delicate, angosce, situazioni inerenti la sfera sessuale o morale: questo esige pudore, non intrusività, non curiosità fuori luogo o morbosa, perché allora l’ascolto diventerebbe violenza e abuso, pretesa e prevaricazione.
6. Ascoltare implica anche il fare silenzio. Non solo il tacere, ma il fare silenzio, il fare del silenzio un’attività interiore. Il silenzio interiore è silenzio delle conversazioni interiori, dei litigi interiori, delle voci e dei rumori, delle immagini che ci attraversano e ci disturbano. Anche dei ricordi che ci tengono prigionieri del passato. L’ascolto esige l’ascesi mentale, il dominio della facoltà dell’immaginazione. Solo così ciò che l’altro ci dice e ci comunica ci può raggiungere in modo limpido.
7. Ascoltare è discernere. L’ascolto opera una cernita, un discernimento, una scelta tra gli elementi che compongono il messaggio dell’altro. L’ascolto è atto intelligente, selettivo: legge dentro, fra, negli interstizi del detto e del non-detto, tra parole e gesti, nota le parole chiave e rivelatrici dell’altro. Tante parole dette non sono essenziali al fine della conoscenza dell’altro, ma spesso per comunicare qualcosa di importante si avvolge il messaggio con parole che costituiscono un cuscinetto protettivo che attutisce il colpo della rivelazione che sta a cuore. Ascoltare implica anche il vedere e nominare le paure che possiamo avere nell’ascolto. Le resistenze all’ascolto: ho il fastidio di chi è noioso, di chi è lento, di chi per dire una cosa che ho già capito quale sarà, percorre un giro interminabile per arrivarci, ho il terrore delle persone confuse e poco capaci di esprimersi con chiarezza. L’ascolto diviene così anche ascolto di sé, svelamento delle nostre miserie, delle nostre debolezze, delle nostre fragilità. È importante, quando si ascolta una persona ascoltare anche la risonanza in noi di ciò che dice o comunica. Comprendiamo così che l’ascolto dell’altro è anche, inscindibilmente, ascolto di sé. E, tra i frutti che porta, non c’è solo la conoscenza del’altro, ma anche di se stessi. E, dunque, la conoscenza del Signore che è in noi, come è nel fratello. Dunque, un presbiterio diviene realmente tale quando si crea in esso un clima di ascolto reciproco.
2. La parola
In un dialogo con i preti della diocesi di Caserta, il 26 luglio 2014, papa Francesco si è così espresso:
“Non è sempre facile per un prete mettersi d’accordo con il Vescovo, perché uno la pensa in una maniera l’altro la pensa nell’altra, ma si può discutere … e si discuta! E si può fare a voce forte? Si faccia! Quante volte un figlio con il suo papà discutono e alla fine rimangono sempre padre e figlio. Tuttavia, quando in questi due rapporti, sia con il Vescovo sia con il presbiterio, entra la diplomazia non c’è lo Spirito del Signore, perché manca lo spirito di libertà. Bisogna avere il coraggio di dire “Io non la penso così, la penso diversamente”, e anche l’umiltà di accettare una correzione. E’ molto importante. E qual è il nemico più grande di questi due rapporti? Le chiacchiere. Tante volte penso – perché anche io ho questa tentazione di chiacchierare, l’abbiamo dentro, il diavolo sa che quel seme gli dà frutti e semina bene – io penso se non sia una conseguenza di una vita celibataria vissuta come sterilità, non come fecondità. Un uomo solo finisce amareggiato, non è fecondo e chiacchiera sugli altri. Questa è un’aria che non fa bene, è proprio quello che impedisce quel rapporto evangelico e spirituale e fecondo con il Vescovo e con il presbiterio. Le chiacchere sono il nemico più forte della diocesanità, cioè della spiritualità. Ma, tu sei un uomo, quindi se hai qualcosa contro il Vescovo vai e gliela dici. Ma poi ci saranno conseguenze non buone. Porterai la croce, ma sii uomo! Se tu sei un uomo maturo e vedi qualcosa in tuo fratello sacerdote che non ti piace o che credi sia sbagliata, vai a dirglielo in faccia, oppure se vedi che quello non tollera di essere corretto, vai a dirlo al Vescovo o all’amico più intimo di quel sacerdote, affinché possa aiutarlo a correggersi. Ma non dirlo agli altri: perché ciò è sporcarsi l’un l’altro”.
La fraternità è costruita (o distrutta) anzitutto dalle parole. Può stupire, ma gran parte dei testi biblici riguardanti il prossimo verte sul parlare: “Dite ciascuno la verità al proprio prossimo” (Ef 4,25); “Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo” (Es 20,16; Pr 25,18); “Colui che adula il prossimo gli tende una rete” (Pr 29,5); “Con la bocca l’empio rovina il suo prossimo” (Pr 11,9), ecc. L’etica della fraternità esige un’etica della parola, una responsabilità della parola. In particolare, nello spazio della sinodalità, nella vita di un presbiterio, occorre assumere la discussione come metodo spirituale. La ricerca che si fa attraverso dibattito e discussione, magari anche accesa, in cui si scontrano opinioni diverse, è la forma spirituale, cioè mossa dallo Spirito santo, di ricerca di forme e modalità comunionali. Altre forme che potrebbero sembrare più spirituali, sono solo devozionali o magiche. Tommaso d’Aquino si oppone a coloro che aprivano a caso la Bibbia per risolvere le controversie riconoscendo che una simile pratica è un’offesa allo Spirito santo, mentre i cristiani hanno come metodo quello di dibattere e discutere in assemblea: “Invece di cercare l’accordo con gli altri si fa ingiuria allo Spirito santo che noi crediamo fermamente essere presente nella chiesa e nelle assemblee” (Quodlibet XII,36). Né si deve aver paura della diversità di opinione, di esprimere un parere difforme da ciò che altri o la maggioranza hanno espresso. “La vera concordia è intrecciata con la diversità, è intessuta con essa”, dice Nicola da Cusa nel suo De concordantia catholica (CC II,32,233).
Negli incontri come nelle relazioni quotidiane è bene che non ci siano toni categorici, scatti d’ira, mancanze di rispetto, insulti o ingiurie. La parola è lo strumento elaborato dagli umani per creare spazi alternativi alla violenza. Per evitare la violenza occorre che la parola lasci sempre spazio all’altro. La sinodalità è dunque il metodo di ricerca insieme della verità e di costruzione comune di un senso attraverso il dialogo, lo scambio della parola. Metodo che accorda importanza essenziale all’interlocutore come soggetto e non lo considera mero terminale della propria parola e della propria volontà (questo sarebbe ricadere nella violenza). Se è vero che, nello spazio cristiano, ogni istituzione sinodale è preceduta e nasce dall’evento fondante della comunione, così ogni istituzione, ogni riunione sinodale deve condurre alla comunione, creare comunione, avere la comunione come obiettivo ultimo. Comunione che si edifica per la via faticosa del comune ascolto, della comune discussione, della comune consultazione, della comune deliberazione. In questo occorre anche dire che nella chiesa non vige in modo assoluto il diritto della maggioranza, ma il diritto della comunione (lo jus communionis di cui parlano Cipriano e Agostino ) che si sposa anche con opinioni differenti su questioni diverse. Il processo sinodale può essere sintetizzato in queste quattro tappe:
1) ascolto reciproco
2) dibattito, discussione e confronto di posizioni
3) discernimento
4) decisione
In tutto questo non deve essere temuto nemmeno il conflitto. Il sinodo sulla famiglia ha portato allo scoperto posizioni non solo diverse, ma anche opposte e inconciliabili: solo dando voce al conflitto, esso può essere affrontato e elaborato. Il conflitto è rivelativo di ciò che normalmente resta celato e nascosto. Del resto, la dimensione conflittuale è presente nella vita delle chiese fin dai più antichi tempi neotestamentari, ne fa parte. Noi siamo in un contesto culturale che ha relegato spesso il conflitto nello spazio del negativo, lo ha visto in modo unilateralmente negativo, quando invece il conflitto è parte della vita, e non è scandaloso che abiti anche il vivere ecclesiale e comunitario. Una realtà senza conflitti non è solo una realtà senza passioni e senza convinzioni, ma più in profondità, è una realtà senza vita.
Nella chiesa abbiamo bisogno di un’ascesi della parola, per giungere a una disciplina della comunicazione. Non si dimentichi mai che ogni parola è un gesto, che può fare del bene o del male. E ogni parola ha una valenza etica: essa esige il rispetto di colui a cui parlo, di me che parlo (il menzognero offende la propria dignità di persona) e della parola stessa che non sopporta di essere manipolata, travisata, violentata. E si stia attenti alle parole che giudicano, che etichettano, che deridono il confratello, si stia attenti al gossip ecclesiastico.
Strumento decisivo di una fraternità autentica e non solo di facciata nella chiesa è la correzione fraterna. Nella comunità cristiana la correzione del fratello, del presbitero in questo caso, che cade nell’errore è una responsabilità connessa all’essere tutti membra dello stesso corpo. “Io sono custode di mio fratello”, dice colui che assume la responsabilità della correzione fraterna e così si sottrae al rischio di divenire, come Caino, l’uccisore del fratello (cf. Gen 4,9). Assumendo il compito della correzione io esco dall’indifferenza in cui spesso mi riparo per proteggermi dal faticoso incontro con l’altro; con essa io mostro di essere responsabile della santità del fratello e che il suo peccato è come se fosse mio. Per questo le lettere del Nuovo Testamento mostrano che la correzione fraterna è inerente anzitutto al ministero dell’apostolo (1Ts 5,12; cf. At 20,31; 1Cor 4,14), che non può sottrarvisi, ma che essa spetta, in verità, a ogni cristiano. Paolo riconosce nella capacità di correzione dei cristiani di Roma un elemento della loro maturità di fede: “Voi siete capaci di correggervi l’un l’altro” (Rm 15,14). La correzione, la parresía, il coraggio della parola che svela il male al fratello per curarlo, è un atto di autentica fraternità, di amore. Sì, l’amore autenticamente spirituale è capace di correggere e ammonire l’amato. Il rischio è infatti di tacere il peccato per amore del peccatore, divenendone così complici.
La correzione fraterna, rettamente intesa e vissuta, può divenire una relazione sacramentale in cui, attraverso un uomo, Dio stesso si fa presente presso un altro uomo. Certo, a essa si oppone la paura. Paura di inimicarci la persona da correggere, paura delle sue reazioni, paura che si mimetizza dietro tanti alibi: “non tocca a me”, “chi sono io per correggere un altro?”, “forse non ho valutato bene”… La tentazione insita nel tacere invece di correggere è quella della complicità: io non dico nulla di lui, lui non dirà nulla di me quando io mi trovassi nella stessa situazione. Nemici della correzione sono il paternalismo, la cecità di chi rifiuta di vedere la trave che è nel proprio occhio e pretende di togliere la pagliuzza che è nell’occhio del fratello (cf. Mt 7,4-5), il meccanismo della proiezione (il rigettare sull’altro ciò che non vogliamo vedere e riconoscere in noi stessi). Essa richiede discernimento: scegliere il momento opportuno; esercitarla in modo da accrescere, non diminuire, la stima che il fratello ha di sé; evitare che sia l’unica maniera con cui ci si rapporta a quel fratello; esercitarla sulle cose veramente essenziali; tendere a liberare, non a giudicare o a condannare; correggere sapendo di essere a propria volta peccatori e bisognosi di correzione. Se tutto questo avviene la correzione potrà procurare un frutto di pace e di benedizione e accrescere la comunione e la fraternità.
3. L’affettività
Il discorso di papa Francesco precedentemente citato parla di un celibato presbiterale sterile, infecondo. E di una vita umana del presbitero che può immiserirsi, divenire meschina. Sì, vivere rapporti di autentica fraternità richiede un’umanità salda e sana. Anche per un presbitero che vive il celibato è importante e vitale la dimensione dell’amore. Anch’egli deve porsi la domanda, soprattutto, nel passare degli anni: Chi mi ama? Chi io amo? Questo non pone in discussione la condizione del celibato sacerdotale, ma interroga la modalità di vivere l’affettività di ogni presbitero. Maturità affettiva implica la rottura del cordone ombelicale e l’uscita da una maniera infantile e adolescenziale di vivere gli affetti. Implica la responsabilità di farsi educatore e di troncare con la tentazione di farsi seduttore. Implica il vivere in maniera adulta e responsabile le relazioni con gli altri preti e con le persone che collaborano in parrocchia. Implica la rinuncia alle relazioni impulsive e il lavoro di integrare il celibato nella propria personalità. Anche il presbitero non deve dimenticare che è anzitutto un uomo e un cristiano. Dunque una persona chiamata a umanizzarsi e a coltivare e nutrire la propria fede. Non si dimentichi mai che, nel cristianesimo, in cui l’umanità di Gesù di Nazaret narra pienamente Dio, ciò che è autenticamente umano è anche autenticamente spirituale, e ciò che è autenticamente spirituale è anche autenticamente umano. Guai se l’esercizio del ministero diviene paravento per nascondere identità deboli e immaturità umane o affettive che purtroppo prima o poi si manifesteranno creando sofferenze se non scandali. Una sana e equilibrata cura di sé è essenziale per una vita umanamente buona. Molto più che da difetti di teologia del ministero o da carenze e incertezze della spiritualità presbiterale, molti problemi dei presbiteri oggi nascono dalla schizofrenia tra ministero e umanità, nascono da un rapporto non armonico tra ministero e vita umana, tra ministero e relazioni interpersonali. Se il presbitero si situa sulla scia della missione di Gesù stesso, egli è chiamato anche a seguire Gesù nella pratica della sua umanità, senza mai dimenticare che lo straordinario di Gesù si situa sul piano umano, non su quello religioso. Gesù ha rivelato Dio, ha mostrato il volto di Dio nella sua umanità e nel modo in cui ha vissuto la sua umanità. Oggi che l’autorevolezza di un presbitero non è più connessa a segni esteriori o a un ruolo, essa emerge dalla sua qualità umana, dalla qualità delle relazioni che vive, dalla profondità delle parole che pronuncia e della vita interiore che nutre. È dunque vitale ripetere l’invito apostolico alla vigilanza. Paolo dice ai presbiteri di Efeso: “Vegliate su voi stessi” (At 20,28). Analogo avvertimento è rivolto a Timoteo: “Vigila su te stesso” (1Tm 4,16). Sì, vigilare su se stessi, sul proprio corpo, sul vestito, sul cibo, sulla casa in cui si abita, sul ministero, sulle parole e sui silenzi, sulle relazioni e sui gesti che le accompagnano. La vigilanza è richiesta a tutti, ma essa assume connotati particolari in cui vive la condizione del celibato e deve dunque dotarsi di una struttura dialogica interiore che si misura con la propria coscienza e con le esigenze del vangelo. Coltivare la vita interiore leggendo, studiando, pensando e riflettendo; trovare del tempo per pensare la propria vita davanti a Dio nella preghiera personale; mantenere una guida spirituale con cui confrontarsi, sono solo alcuni degli elementi che possono aiutare il presbitero a crescere umanamente e spiritualmente, fuggendo i rischi dell’iperattività pastorale, del non aver mai tempo per se stessi, dell’inaridire la propria vita spirituale. Ma anche divenire uomo di relazioni mature, uomo capace di fraternità, uomo che evangelizza già con il suo essere, con la sua umanità e con la qualità delle sue relazioni.