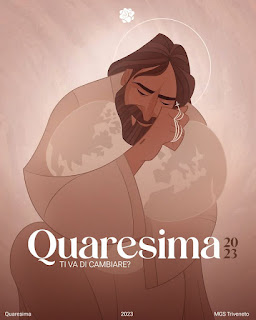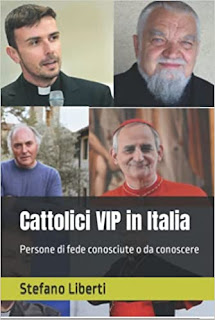La Bibbia sullo schermo (G. Ravasi)
LA BIBBIA SULLO SCHERMO, Jesus, ottobre 2016
Il cardinale Gianfranco Ravasi riflette sull'immagine come via per dire Dio in tv e al cinema. Ma la via privilegiata dal grande schermo è quella "parabolica" e parte dallo stesso metodo comunicativo di Gesù.
---------
di Gianfranco Ravasi
Nel suo saggio The Mechanical Bride del 1955, Marshall McLuhan non esitava a dichiarare che «oggi i modelli di eloquenza non sono più i classici, bensì le agenzie pubblicitarie». Era, certo, una frase provocatoria, ma dalla sostanza indiscutibile. La comunicazione è una delle sfide capitali che coinvolgono oggi anche la Chiesa, proprio perché i nuovi modelli di connessione stanno creando un modello umano dai lineamenti inediti.
Anche se forse esagerata, è per certi versi condivisibile l’affermazione di John Perry Barlow della Electronic Frontier Foundation: «Siamo di fronte alla più significativa trasformazione tecnologica dopo la scoperta del fuoco». Ma una sua profonda verità conserva anche la battuta che in un’intervista al New York Post del 22 settembre 1955 (si noti la data…) il grande poeta Thomas S. Eliot formulava: «La televisione è un mezzo di intrattenimento che permette a milioni di persone di ascoltare contemporaneamente la stessa barzelletta, e rimanere ugualmente sole». L’immagine è abusata ma rende l’idea: si levano sui tetti le parabole e si moltiplicano nelle stanze gli schermi, e intanto si blindano le porte che si aprono sulle strade. A questa nuova cultura “elettronica”, che adotta grammatiche di comunicazione ben diverse da quelle della retorica classica, non si può certo opporre un’aristocratica indifferenza.
Ora, la religione – che di sua natura è annuncio (kérygma è, nel greco neotestamentario, il compito primario dell’apostolo, cioè l’atto dell’araldo che proclama un messaggio in pubblico) – non può isolarsi in una comunicazione autoreferenziale e progressivamente incomprensibile (il cosiddetto “ecclesialese”). Già Paolo VI – e siamo nel 1975 – nella Evangelii nuntiandi non esitava ad ammonire che «la Chiesa si sentirebbe colpevole di fronte al Signore se non adoperasse questi potenti mezzi» (n. 45). Ancor prima, il Concilio Vaticano II, nel decreto Inter mirifica (1963), riconosceva che gli strumenti della moderna comunicazione sociale «contribuiscono mirabilmente a sollevare e ad arricchire lo spirito e a diffondere e a consolidare il regno di Dio» (n. 2).
Significativo è stato, poi, il magistero di Giovanni Paolo II, un Papa di sua natura “mediatico” (come per altro lo è l’attuale Pontefice), che nell’enciclica Redemptoris missio del 1990 non esitava a riconoscere ormai il sorgere di una «nuova cultura» che si alimentava «prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi messaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici... È, perciò, necessario integrare il messaggio cristiano in questa “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna» (n. 37), naturalmente con tutti i rischi che questo comporta perché non c’è bisogno di rievocare il motto del citato McLuhan del «mezzo come messaggio» per capire che una mutazione di linguaggio incide anche nella sostanza del contenuto.
Eppure questa fu la via sempre imboccata dalla tradizione cristiana, a partire dall’apostolo Paolo, colui che attuò il primo grande progetto di inculturazione del cristianesimo ricorrendo a un linguaggio e a un’attività missionaria pronta a usufruire delle risorse offerte dalla cultura greco-romana, dalle sue tecniche oratorie, dalle arterie di comunicazione dell’impero, dagli ambiti della polis coi suoi areopaghi e le sue agorà, dalla forza della parresía, cioè della libera diffusione del pensiero. E sulla sua scia continuerà la Chiesa nei secoli successivi in forme sempre nuove.
Ora, l’impresa del dire Dio in televisione è certamente ardua. Lo è anche per due paradossi insiti di primo acchito nella religione biblica. Da un lato, infatti, si ha il monito “aniconico” che scende dalla vetta del Sinai col primo comandamento del Decalogo: «Non ti farai immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra» (Esodo 20,4). Mosè ricorda a Israele che «il Signore vi parlò dal fuoco. Voce di parole voi ascoltavate. Nessuna figura vedevate: era solo una voce» (Deuteronomio 4,12). Siamo dunque di fronte alla irrappresentabilità del divino nell’ebraismo (e, per derivazione, nell’islam).
D’altro lato, anche il cristianesimo rivela la consapevolezza di una radicale diversità dell’evento religioso rispetto a quello civile e sociale: «Il mio regno non è di questo mondo», dichiara Cristo all’emblema del potere pubblico, il governatore romano Pilato (Giovanni 18,36). Egli non aveva esitato a bollare ogni ostentazione magniloquente della spiritualità: scribi e farisei «fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini» (Matteo 23,5). «Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto» (Matteo 6,6). Spesso Gesù compie i miracoli in disparte dalla folla, escludendo ogni atto “pubblicitario” e promozionale. Siamo davanti all’esatto contrario dell’ostentazione pubblica televisiva.
L’interrogativo a questo punto è scontato: è irreligioso o anticristiano approdare in televisione per dire un messaggio così “silenzioso” a livello sia iconografico sia testimoniale? In realtà, la religione ebraico-cristiana di sua natura non è esoterica e il duplice paradosso a cui accennavamo è esplicitamente sciolto – oltre che dalla grande tradizione artistica e culturale cristiana – dagli stessi testi sacri. Basterebbe soltanto rimandare a un detto di Gesù riferito, sia pure con varianti, dai Vangeli di Matteo (10,27) e di Luca (12,3): «Quello che avete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce e ciò che avete sussurrato all’orecchio nelle stanze più segrete sarà annunziato dalle terrazze», che erano poi i tetti di allora, un’immagine che ben s’adatta alle antenne e alle parabole televisive odierne.
È per questo che in un testo capitale del cristianesimo com’è il Discorso della montagna Cristo afferma: «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 5,14-16). C’è, dunque, una “pubblicità” da manifestare che esclude una concezione meramente privatistica della fede, anche perché l’uomo e la donna di loro natura sono anima e corpo, interiorità e comunicazione, privatezza e socialità. Il cuore del messaggio cristiano è collegato nell’incarnazione secondo la quale «il Verbo si è fatto carne» (Giovanni 1,14), quindi visibile e fin palpabile, un volto umano e una parola storica.
Il duplice paradosso, a cui ci siamo riferiti, si risolve allora stando su un crinale delicato. C’è l’immagine legittima di Dio. Essa è innanzitutto la crea-
tura umana: «Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò» (Genesi 1,27). Le persone con la loro capacità d’amore (è la coppia “l’immagine” di Dio!), di dialogo e di generazione vitale, con le loro storie e vicende, possono parlare di Dio meglio di ogni statua che può condurre lungo la china scivolosa dell’idolo.
C’è, poi, Cristo che – come dice san Paolo – è eikōn, icona perfetta del Dio invisibile (Colossesi 1,15), e quindi legittima e giustifica sia l’arte, escludendo ogni iconoclasmo, sia la rappresentazione religiosa all’interno dei nuovi modelli espressivi com’è la televisione, ferma restando sempre la soglia idolatrica. Quanti prodotti cinematografici e televisivi, attraverso la banalizzazione del sacro, hanno varcato questa soglia, ma quanti ne hanno custodito e manifestato il significato genuino anche senza un rimando esplicito didascalico (basti solo citare per il cinema nomi come Bergman, Bresson, Dreyer, Kieslowski, Tarkovskij, lo stesso Pasolini ecc.)?
Oltre all’immagine c’è, però, l’altra via autentica per condurre a Dio ed è quella della parola. Il discorso si fa in questo caso quasi provocatorio nei confronti di una comunicazione che è di sua natura “visiva”. Tuttavia, è noto che l’analogia fondamentale biblica per dire Dio è proprio quella della parola. Ebbene, in che modo quella parola diventa visiva e televisiva? Attraverso la sua qualità radicale: essa è storica e simbolica.
Proprio perché non è astratta elaborazione teoretica sull’essenza divina, ma è una narrazione di eventi ed è intarsiata di simboli, la parola sacra è una sorta di filmato continuo che ti rivela il divino nel quotidiano. Emblematiche a questo riguardo sono le 35 parabole di Gesù (72 con le metafore espanse) che rappresentano una categoria teologica, «il regno dei cieli», ma partendo dal terreno ove poggiano i piedi dell’uomo storico: campi pietrosi, semi, pecore e pastori, vigne, messi, gigli, serpi, avvoltoi, scorpioni, venti, piogge, arsure, cene nuziali, braccianti, amministratori e giudici corrotti, figli difficili, casalinghe, portieri notturni, debitori e creditori, ricchi e poveri, costruttori, vedove, prostitute, tesori e monete, cibi kasher e impuri e così via. È per questa via che l’esistenza umana e il creato, la storia e lo spazio diventano epifania del mistero, svelamento del trascendente, anche attraverso la rappresentazione artistica e televisiva.
Il cardinale Gianfranco Ravasi riflette sull'immagine come via per dire Dio in tv e al cinema. Ma la via privilegiata dal grande schermo è quella "parabolica" e parte dallo stesso metodo comunicativo di Gesù.
---------
di Gianfranco Ravasi
Nel suo saggio The Mechanical Bride del 1955, Marshall McLuhan non esitava a dichiarare che «oggi i modelli di eloquenza non sono più i classici, bensì le agenzie pubblicitarie». Era, certo, una frase provocatoria, ma dalla sostanza indiscutibile. La comunicazione è una delle sfide capitali che coinvolgono oggi anche la Chiesa, proprio perché i nuovi modelli di connessione stanno creando un modello umano dai lineamenti inediti.
Anche se forse esagerata, è per certi versi condivisibile l’affermazione di John Perry Barlow della Electronic Frontier Foundation: «Siamo di fronte alla più significativa trasformazione tecnologica dopo la scoperta del fuoco». Ma una sua profonda verità conserva anche la battuta che in un’intervista al New York Post del 22 settembre 1955 (si noti la data…) il grande poeta Thomas S. Eliot formulava: «La televisione è un mezzo di intrattenimento che permette a milioni di persone di ascoltare contemporaneamente la stessa barzelletta, e rimanere ugualmente sole». L’immagine è abusata ma rende l’idea: si levano sui tetti le parabole e si moltiplicano nelle stanze gli schermi, e intanto si blindano le porte che si aprono sulle strade. A questa nuova cultura “elettronica”, che adotta grammatiche di comunicazione ben diverse da quelle della retorica classica, non si può certo opporre un’aristocratica indifferenza.
Ora, la religione – che di sua natura è annuncio (kérygma è, nel greco neotestamentario, il compito primario dell’apostolo, cioè l’atto dell’araldo che proclama un messaggio in pubblico) – non può isolarsi in una comunicazione autoreferenziale e progressivamente incomprensibile (il cosiddetto “ecclesialese”). Già Paolo VI – e siamo nel 1975 – nella Evangelii nuntiandi non esitava ad ammonire che «la Chiesa si sentirebbe colpevole di fronte al Signore se non adoperasse questi potenti mezzi» (n. 45). Ancor prima, il Concilio Vaticano II, nel decreto Inter mirifica (1963), riconosceva che gli strumenti della moderna comunicazione sociale «contribuiscono mirabilmente a sollevare e ad arricchire lo spirito e a diffondere e a consolidare il regno di Dio» (n. 2).
Significativo è stato, poi, il magistero di Giovanni Paolo II, un Papa di sua natura “mediatico” (come per altro lo è l’attuale Pontefice), che nell’enciclica Redemptoris missio del 1990 non esitava a riconoscere ormai il sorgere di una «nuova cultura» che si alimentava «prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi messaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici... È, perciò, necessario integrare il messaggio cristiano in questa “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna» (n. 37), naturalmente con tutti i rischi che questo comporta perché non c’è bisogno di rievocare il motto del citato McLuhan del «mezzo come messaggio» per capire che una mutazione di linguaggio incide anche nella sostanza del contenuto.
Eppure questa fu la via sempre imboccata dalla tradizione cristiana, a partire dall’apostolo Paolo, colui che attuò il primo grande progetto di inculturazione del cristianesimo ricorrendo a un linguaggio e a un’attività missionaria pronta a usufruire delle risorse offerte dalla cultura greco-romana, dalle sue tecniche oratorie, dalle arterie di comunicazione dell’impero, dagli ambiti della polis coi suoi areopaghi e le sue agorà, dalla forza della parresía, cioè della libera diffusione del pensiero. E sulla sua scia continuerà la Chiesa nei secoli successivi in forme sempre nuove.
Ora, l’impresa del dire Dio in televisione è certamente ardua. Lo è anche per due paradossi insiti di primo acchito nella religione biblica. Da un lato, infatti, si ha il monito “aniconico” che scende dalla vetta del Sinai col primo comandamento del Decalogo: «Non ti farai immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra» (Esodo 20,4). Mosè ricorda a Israele che «il Signore vi parlò dal fuoco. Voce di parole voi ascoltavate. Nessuna figura vedevate: era solo una voce» (Deuteronomio 4,12). Siamo dunque di fronte alla irrappresentabilità del divino nell’ebraismo (e, per derivazione, nell’islam).
D’altro lato, anche il cristianesimo rivela la consapevolezza di una radicale diversità dell’evento religioso rispetto a quello civile e sociale: «Il mio regno non è di questo mondo», dichiara Cristo all’emblema del potere pubblico, il governatore romano Pilato (Giovanni 18,36). Egli non aveva esitato a bollare ogni ostentazione magniloquente della spiritualità: scribi e farisei «fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini» (Matteo 23,5). «Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto» (Matteo 6,6). Spesso Gesù compie i miracoli in disparte dalla folla, escludendo ogni atto “pubblicitario” e promozionale. Siamo davanti all’esatto contrario dell’ostentazione pubblica televisiva.
L’interrogativo a questo punto è scontato: è irreligioso o anticristiano approdare in televisione per dire un messaggio così “silenzioso” a livello sia iconografico sia testimoniale? In realtà, la religione ebraico-cristiana di sua natura non è esoterica e il duplice paradosso a cui accennavamo è esplicitamente sciolto – oltre che dalla grande tradizione artistica e culturale cristiana – dagli stessi testi sacri. Basterebbe soltanto rimandare a un detto di Gesù riferito, sia pure con varianti, dai Vangeli di Matteo (10,27) e di Luca (12,3): «Quello che avete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce e ciò che avete sussurrato all’orecchio nelle stanze più segrete sarà annunziato dalle terrazze», che erano poi i tetti di allora, un’immagine che ben s’adatta alle antenne e alle parabole televisive odierne.
È per questo che in un testo capitale del cristianesimo com’è il Discorso della montagna Cristo afferma: «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 5,14-16). C’è, dunque, una “pubblicità” da manifestare che esclude una concezione meramente privatistica della fede, anche perché l’uomo e la donna di loro natura sono anima e corpo, interiorità e comunicazione, privatezza e socialità. Il cuore del messaggio cristiano è collegato nell’incarnazione secondo la quale «il Verbo si è fatto carne» (Giovanni 1,14), quindi visibile e fin palpabile, un volto umano e una parola storica.
Il duplice paradosso, a cui ci siamo riferiti, si risolve allora stando su un crinale delicato. C’è l’immagine legittima di Dio. Essa è innanzitutto la crea-
tura umana: «Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò» (Genesi 1,27). Le persone con la loro capacità d’amore (è la coppia “l’immagine” di Dio!), di dialogo e di generazione vitale, con le loro storie e vicende, possono parlare di Dio meglio di ogni statua che può condurre lungo la china scivolosa dell’idolo.
C’è, poi, Cristo che – come dice san Paolo – è eikōn, icona perfetta del Dio invisibile (Colossesi 1,15), e quindi legittima e giustifica sia l’arte, escludendo ogni iconoclasmo, sia la rappresentazione religiosa all’interno dei nuovi modelli espressivi com’è la televisione, ferma restando sempre la soglia idolatrica. Quanti prodotti cinematografici e televisivi, attraverso la banalizzazione del sacro, hanno varcato questa soglia, ma quanti ne hanno custodito e manifestato il significato genuino anche senza un rimando esplicito didascalico (basti solo citare per il cinema nomi come Bergman, Bresson, Dreyer, Kieslowski, Tarkovskij, lo stesso Pasolini ecc.)?
Oltre all’immagine c’è, però, l’altra via autentica per condurre a Dio ed è quella della parola. Il discorso si fa in questo caso quasi provocatorio nei confronti di una comunicazione che è di sua natura “visiva”. Tuttavia, è noto che l’analogia fondamentale biblica per dire Dio è proprio quella della parola. Ebbene, in che modo quella parola diventa visiva e televisiva? Attraverso la sua qualità radicale: essa è storica e simbolica.
Proprio perché non è astratta elaborazione teoretica sull’essenza divina, ma è una narrazione di eventi ed è intarsiata di simboli, la parola sacra è una sorta di filmato continuo che ti rivela il divino nel quotidiano. Emblematiche a questo riguardo sono le 35 parabole di Gesù (72 con le metafore espanse) che rappresentano una categoria teologica, «il regno dei cieli», ma partendo dal terreno ove poggiano i piedi dell’uomo storico: campi pietrosi, semi, pecore e pastori, vigne, messi, gigli, serpi, avvoltoi, scorpioni, venti, piogge, arsure, cene nuziali, braccianti, amministratori e giudici corrotti, figli difficili, casalinghe, portieri notturni, debitori e creditori, ricchi e poveri, costruttori, vedove, prostitute, tesori e monete, cibi kasher e impuri e così via. È per questa via che l’esistenza umana e il creato, la storia e lo spazio diventano epifania del mistero, svelamento del trascendente, anche attraverso la rappresentazione artistica e televisiva.