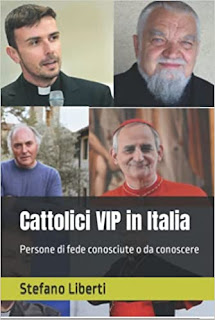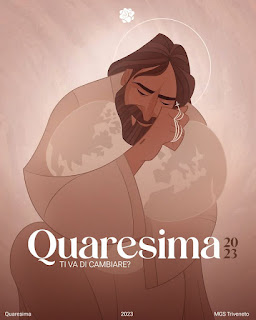L'hate speech: l'odio nei social, frutto di pregiudizi
L’odio al tempo dei social: poco orgoglio e troppo pregiudizio
Si è accesa in questi giorni una polemica sui possibili rimedi all'esplosione di odio ed aggressività che si sperimenta, da tempo ormai, sulle piattaforme sociali. L'hate speech sta diventando la cifra che caratterizza molte, troppe, delle nostre interazioni virtuali
di Vittorio Pelligra (3 novembre 2019)
Si è accesa in questi giorni una polemica, a tratti anche aspra, sui possibili rimedi all'esplosione di odio ed aggressività che si sperimenta, da tempo ormai, sulle piattaforme sociali. L' hate speech sta diventando la cifra, quasi un genere letterario, che caratterizza molte, troppe, delle nostre interazioni virtuali. La diffusione di queste modalità comunicative rozze e violente ha ricadute profonde e misurabili sul livello di fiducia interpersonale e sul benessere individuale che riportano coloro che ne sono, in qualche modo, vittime o anche solo spettatori incolpevoli.
Il tema è rilevante non solo per la qualità del dibattito pubblico e per il suo pluralismo, ma anche per la vulnerabilità che hanno dimostrato i social a manipolazioni politiche e ideologiche.
Il pregiudizio alla radice di tutto
Alla radice di questa conflittualità che si accende così facilmente sul web, c'è quasi sempre il tema del pregiudizio: una divisione in schieramenti opposti che si costruiscono intorno ad un insieme di credenze fondate, nella definizione classica, sulla paura, l'ignoranza, la mancanza di modelli di vita e obiettivi condivisi e, spesso, rinfocolate e rafforzate dall'uso strumentale dell'autorità. Il dibattito sul ruolo che i social hanno nell'alimentare e dar voce a questa ondata di odio online e sull'uso strumentale che certa politica può farne, si è concentrato prevalentemente sulle caratteristiche proprie dello strumento.
Alla radice di questa conflittualità che si accende così facilmente sul web, c'è quasi sempre il tema del pregiudizio: una divisione in schieramenti opposti che si costruiscono intorno ad un insieme di credenze fondate, nella definizione classica, sulla paura, l'ignoranza, la mancanza di modelli di vita e obiettivi condivisi e, spesso, rinfocolate e rafforzate dall'uso strumentale dell'autorità. Il dibattito sul ruolo che i social hanno nell'alimentare e dar voce a questa ondata di odio online e sull'uso strumentale che certa politica può farne, si è concentrato prevalentemente sulle caratteristiche proprie dello strumento.
L'attenzione, cioè, si è focalizzata in gran parte sulle peculiarità del mezzo, sul tema dell'anonimato, sull'uso e abuso di profili fake, degli agenti automatizzati, sul fact checking che i gestori delle piattaforme dovrebbero o non dovrebbero porre in essere, solo per fare qualche esempio. Ma il pregiudizio, la radice della diffidenza e dell'odio per il “diverso”, non nasce certo coi social; semmai questi lo hanno potenziato e, soprattutto, ne hanno moltiplicato la scala. Semplicemente, oggi, interagiamo anche solo telematicamente, attivamente o passivamente, con molte più persone di quanto non facessimo fino a pochi anni fa.
Ne deriva una esposizione a una diversità di opinioni, di ragioni, di pensiero, a volte estreme e difficili da far rientrare nei nostri canoni abituali, mai sperimentata prima, che può generare una naturale tensione tra “in-group” e “out-group”, tra quelli con i quali ci identifichiamo e con i quali condividiamo una certa visione del mondo, da una parte, e dall'altra tutti gli altri, tutti quelli che stanno fuori dal nostro gruppo.
L’equazione del Web: più distanze, più conflitto
Ma se questo è vero, allora, la differenza tra l'esperienza del conflitto interpersonale pre e post-social, non è tanto una differenza di qualità, ma piuttosto, di quantità. Più interazioni, più eterogeneità, maggiori distanze e differenze nei pensieri e nelle opinioni e, di conseguenza, maggiore conflitto. E' di quantità più che di qualità anche la differenza giocata dalle cosiddette echo-chambers.
Ma se questo è vero, allora, la differenza tra l'esperienza del conflitto interpersonale pre e post-social, non è tanto una differenza di qualità, ma piuttosto, di quantità. Più interazioni, più eterogeneità, maggiori distanze e differenze nei pensieri e nelle opinioni e, di conseguenza, maggiore conflitto. E' di quantità più che di qualità anche la differenza giocata dalle cosiddette echo-chambers.
I gruppi sociali si sono sempre assortiti sulla base delle similarità: la stessa musica, il cinema, il tifo calcistico, la fede politica e così via. Una forma di auto-selezione in gruppi che aveva, per un verso una funzione difensiva, ma al tempo stesso, quella rafforzativa dell'identità del singolo. Ci si confermava nelle proprie credenze a vicenda.
Oggi sul web accade lo stesso, ci si espone, consapevolmente o meno, a quelle fonti informative che ci fanno arrivare i messaggi più aderenti alle nostre pre-comprensioni di partenza, messaggi che poi noi rilanciamo a persone che hanno convinzioni simili, che a loro volta vengono rafforzate, il tutto in un gioco di echi e rimandi che identificano e chiudono i gruppi alle influenze esterne. Per questa via, non solo le posizioni si rafforzano, ma si polarizzano, diventano più estreme e distanti e, quindi, potenzialmente più conflittuali.
Il pregiudizio nasce prima della Rete
Eppure, la radice di questo processo, il pregiudizio, era lì prima del web. Caratterizza le nostre interazioni da molto prima che i bit iniziassero a viaggiare attraverso la fibra ottica. Se quindi vogliamo affrontare seriamente il tema della conflittualità dell'onlife, dovremmo andare alla radice, uscire dalla cornice e cercare rimedi che sappiano guardare all'origine del problema, non solo ai sintomi più appariscenti. Come combattere il pregiudizio, dunque, diventa la vera questione-chiave. Ma il pregiudizio è in qualche modo un concetto originario, perché nasce dalla presenza dell'altro.
Eppure, la radice di questo processo, il pregiudizio, era lì prima del web. Caratterizza le nostre interazioni da molto prima che i bit iniziassero a viaggiare attraverso la fibra ottica. Se quindi vogliamo affrontare seriamente il tema della conflittualità dell'onlife, dovremmo andare alla radice, uscire dalla cornice e cercare rimedi che sappiano guardare all'origine del problema, non solo ai sintomi più appariscenti. Come combattere il pregiudizio, dunque, diventa la vera questione-chiave. Ma il pregiudizio è in qualche modo un concetto originario, perché nasce dalla presenza dell'altro.
È perché c'è un altro diverso da me, infatti, che diventa necessario formarsi una visione dell'altro. È la sua alterità, quella che mette in discussione la mia individualità, che rende necessario scoprire che l'altro è un altro “io”. Ma prima che questa scoperta si compia, come magistralmente ci ha insegnato Tzvetan Todorov, l'altro sarà un non-noi; una immagine che ci formiamo per segnarne la differenza, la distanza, l'irriducibilità al mio io. Questa è l'origine e la radice del pregiudizio. E se questa è l'origine, l'antidoto non può che stare nel processo di “scoperta” dell'altro.
«L'altro dev'essere scoperto – ammonisce Todorov – e la cosa può stupire, se si pensa che l'uomo non è mai solo, né sarebbe ciò che è senza la sua dimensione sociale (…) E poiché la scoperta dell'altro percorre diversi gradi – dall'altro come oggetto, confuso con il mondo circostante, fino all'altro come soggetto uguale all'io, ma da esso diverso con un'infinità di sfumature intermedie – è possibile trascorrere la vita senza mai giungere alla piena scoperta dell'altro» (La Conquista dell'America. Il problema dell'altro. Einaudi, 1984).
La difficile scoperta dell’altro
Paradossalmente, le interazioni mediate dal web, pur crescendo potenzialmente in numero, rendono questa scoperta sempre più difficile, perché l'altro, veramente, rischia di diventare un «oggetto confuso con il mondo circostante». Ed è per questo, quindi, che maggior forza dovrebbe assumere la lotta al pregiudizio. Uno dei lavori che maggiormente ha contribuito a gettare le basi della comprensione della genesi del pregiudizio, ma anche dei suoi possibili anticorpi, è il volume di Gordon Allport, The nature of prejudice (Basic Books, 1954).
Paradossalmente, le interazioni mediate dal web, pur crescendo potenzialmente in numero, rendono questa scoperta sempre più difficile, perché l'altro, veramente, rischia di diventare un «oggetto confuso con il mondo circostante». Ed è per questo, quindi, che maggior forza dovrebbe assumere la lotta al pregiudizio. Uno dei lavori che maggiormente ha contribuito a gettare le basi della comprensione della genesi del pregiudizio, ma anche dei suoi possibili anticorpi, è il volume di Gordon Allport, The nature of prejudice (Basic Books, 1954).
Allport è anche il padre dell'«ipotesi del contatto» una ipotesi secondo cui la conflittualità e il pregiudizio tra in-group e out-group si potrebbero grandemente ridurre a seguito di un contatto tra i membri dei due gruppi differenti, gli odiatori con gli odiati, per rimanere nell'ambito dei conflitti sui social. Naturalmente affinché questo possa avvenire occorre che questo contatto possa avvenire sotto determinate condizioni: lo status delle persone coinvolte dovrebbe essere non troppo differente.
Le diversità di istruzione, reddito, esperienza non aiutano a trovare un piano comune di comprensione e quindi dovrebbero essere minimizzate; bisognerebbe strutturare l'incontro attorno a degli obiettivi comuni. I gruppi devono lavorare o affrontare problemi condivisi che li aiutino a congiungere sforzi e risorse, per il raggiungimento di un fine unico; in ultimo, queste attività di incontro dovrebbero ricevere supporto da figure autorevoli, dalla legge o da processi consuetudinari, che dovrebbero incoraggiare il contatto amichevole ed egualitario e scoraggiare ogni forma di competizione e conflittualità tra gruppi.
La storia dell’analisi sul pregiudizio
Erano gli anni del dopoguerra, quando Allport propose la sua ipotesi e lanciò un intero programma di ricerca volto alla analisi delle caratteristiche del pregiudizio, delle sue dinamiche contagiose e dei rimedi possibili. Negli stessi anni gli Stati Uniti inauguravano importanti processi di desegregazione ed emancipazione dei cittadini neri e delle donne e l'ipotesi di Allport forniva una utile guida teorica ed operativa. Negli anni successivi il progetto di ricerca è andato avanti e sono stati prodotti centinaia di studi che hanno testato la validità empirica dell'ipotesi del contatto.
Erano gli anni del dopoguerra, quando Allport propose la sua ipotesi e lanciò un intero programma di ricerca volto alla analisi delle caratteristiche del pregiudizio, delle sue dinamiche contagiose e dei rimedi possibili. Negli stessi anni gli Stati Uniti inauguravano importanti processi di desegregazione ed emancipazione dei cittadini neri e delle donne e l'ipotesi di Allport forniva una utile guida teorica ed operativa. Negli anni successivi il progetto di ricerca è andato avanti e sono stati prodotti centinaia di studi che hanno testato la validità empirica dell'ipotesi del contatto.
Nel 2006, Pettigrew e Tropp hanno condotto una meta-analisi su 515 studi condotti tra gli anni '40 e il 2000 (“A meta-analytic test of intergroup contact theory”, Journal of Personality and Social Psychology, 90(5), pp. 751–783). Nonostante i limiti metodologici di alcuni degli studi meno recenti, il quadro che emerge fornisce un robusto supporto all'ipotesi del contatto.
Ribaltando questi risultati sul problema della proliferazione dell'odio online potremmo certamente sottolineare un dato di pessimismo: se il contatto favorisce la scomparsa del pregiudizio, rapporti mediati da tecnologie che, per loro natura, prevengono il contatto, saranno certamente incubatori di pregiudizio.
Gli anticorpi si formano nella vita offline
Se questo è vero, si capisce perché è necessario che gli anticorpi si formino ed inizino ad operare fuori dalla dimensione virtuale, a partire dalla vita reale. E qui gli ambiti di intervento certo non mancano. Due per tutti: la scuola e le città.
Se questo è vero, si capisce perché è necessario che gli anticorpi si formino ed inizino ad operare fuori dalla dimensione virtuale, a partire dalla vita reale. E qui gli ambiti di intervento certo non mancano. Due per tutti: la scuola e le città.
La tradizione di inclusione della scuola italiana, che mette a “contatto” nelle stesse classi persone con disabilità fisiche e intellettive, bambini di provenienze sociali differenti, di etnie e religioni differenti, in un processo di integrazione e conoscenza reciproca, rappresenta un caso di eccellenza che andrebbe sempre più riconosciuto, valorizzato e rafforzato con adeguati strumenti ed investimenti.
Non solo queste esperienze hanno un effetto positivo sulla resa scolastica degli studenti, ma contribuiscono a disinnescare sul nascere i processi di germinazione del pregiudizio e della diffidenza. Sul piano della progettazione urbanistica sarebbe interessante riflettere quanto le nostre città abbiano favorito la segregazione di gruppi omogenei, la separazione, lo scontro, invece che l'incontro.
È sempre più urgente “ricucire” le nostre periferie individualizzanti e de-umanizzanti e costruire spazi di incontro e conoscenza reciproca, luoghi dove fare esperienza della diversità, dove imparare a cooperare, a darsi fini comuni e a condividere risorse materiali e immateriali. Perché l'odio sul web si combatte, innanzitutto, coltivando germogli di civiltà fuori dal web e creando quante più occasioni possibili di “contatto” per scongiurare che i più possano finire per “trascorrere la vita senza mai giungere alla piena scoperta dell'altro” e passare l'esistenza rinchiusi nella peggiore delle celle possibili: il proprio io.