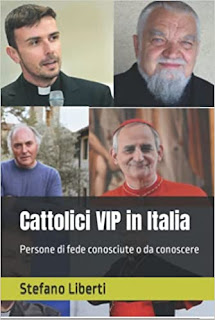La cena del Signore secondo Matteo: una meditazione di p. Giulio Michelini
Il sito La parte buona ha pubblicato un estratto dal volume “Stare con Gesù. Stare con Pietro”, di Giulio Michelini, con le meditazioni agli esercizi spirituali tenuti alla Curia Romana nella Quaresima 2017 (Edizioni Porziuncola). In questa meditazione l’attenzione si concentra anzitutto sulla dimensione teologica, antropologica ed esistenziale del mangiare insieme; si passerà poi ad analizzare le parole di Gesù sul pane e sul calice, secondo la specifica lezione di Matteo. Accenneremo anche al tradimento di Giuda e alla profezia dell’abbandono.
Stare alla stessa tavola
Non entreremo nel merito di questioni di liturgia e teologia sacramentaria, che pure sono così importanti per questa pagina riguardante l’ultima cena di Gesù, e nemmeno faremo riferimento a temi così fondamentali come quello del memoriale («Fate questo in memoria di me»), che emerge però non tanto nel racconto della passione di Matteo, ma nelle versioni della cena di Paolo (1Cor 11,24-25) e Luca (22,19). Commentiamo invece da vicino l’inizio del racconto della cena, che potremmo rischiare di tenere in poca considerazione. Ma il racconto dell’istituzione dell’eucaristia inizia proprio così: «Si mise a tavola coi dodici» (Mt 26,20).
Vogliamo perciò sottolineare alcuni aspetti culturali e antropologici dell’esperienza del mangiare insieme. Infatti, la dimensione sacramentale della cena del Signore non ci deve far perdere di vista la base umana, così semplice ma fondamentale, che si trova anche nell’ultima cena di Gesù.
Il cibo ha condizionato lo sviluppo dell’umanità[1]. I primati si nutrivano soprattutto di vegetali (e questo elemento ci ricorda che nella Bibbia Adamo era vegetariano: solo dopo la caduta, e il diluvio, gli viene dato il permesso di nutrirsi degli animali). I primati che svilupparono caratteristiche di ominidi divennero carnivori e quindi predatori, e questo contribuì a rafforzare il comportamento sociale degli individui, che dovevano collaborare per la caccia e per la preparazione dei cibi.
Il cibo è poi una forma di linguaggio preverbale che unisce, e permette di comunicare valori anche senza parlare. Si pensi a cosa significhi il preparare il cibo per un’altra persona: può davvero significare un atto di amore. Il Risorto stesso, secondo il vangelo di Giovanni, ha preparato per i suoi discepoli che non avevano pescato nulla «un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane» (Gv 21,9), e quindi aveva cucinato per loro. Questa comunicazione preverbale è talmente forte, che riguarda anche il rapporto con Dio: ecco perché il cibo, allo stato naturale o preparato, è stato dall’inizio offerto alla divinità. La prima forma di preghiera registrata nella Bibbia, quella tramite il sacrificio di Caino e Abele, vede proprio del cibo (in forma vegetale per Caino, di animali per Abele) come offerto ad Adonai (cf. Gen 4).
Il cibo e il mangiare mettono però in luce anche il peccato dell’uomo, come anche il suo egoismo e la sua fragilità. Non ci sfugge certo la simbolica biblica della prima disobbedienza compiuta a causa del cibo («È vero che Dio ha detto “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”»; Gen 3,1), e del primo peccato mortale, l’omicidio di un fratello, avvenuto a causa della gelosia di Caino per l’offerta da parte di Abele di «primogeniti del suo gregge e il loro grasso» (Gen 4,4); non ci sfugge nemmeno il fatto che un’ulteriore divisione tra fratelli, Giacobbe ed Esaù, abbia luogo per la fame del secondo, che ha svenduto la primogenitura per un piatto di minestra rossa (Gen 25,34); e potremmo andare avanti così a lungo. Se poi parliamo di egoismo in rapporto al cibo, allora basterà rileggere la Laudato si’, di cui dirò brevemente alla fine. Anche per questa ragione Gesù – per insegnarci la condivisione – ha dato il cibo a chi aveva fame, come ricordato da tutti e quattro i vangeli, che hanno fatto del miracolo del pane e dei pesci dati alle folle quello narrato più volte: due in Marco, due in Matteo, una in Luca e una in Giovanni.
Mangiare insieme i pasti, dunque, è elemento che dice la bellezza dello stare insieme, ma che svela anche la nostra umanità. Tutti e due questi elementi sono presenti nella cena di Gesù. Chissà con quanto amore sarà stata preparata, quanto amore viene condiviso durante quella cena, ma quanto odio, e quanta fragilità, emergono in quella cena. Prendiamo in considerazione questi aspetti da diversi punti di vista.
Mangiare: segno del limite umano
Mangiare del cibo, non l’abbiamo ancora detto, è infatti segno in primo luogo di una vera e propria fragilità antropologica: è un bisogno che dice umanità e debolezza. Così ha scritto, commentando le «Regole per ordinarsi nel mangiare» date da Ignazio di Loyola per i suoi Esercizi spirituali, Jean-Paul Hernandez sj: «Ignazio ha colto il posto centrale che mangiare occupa nell’esperienza umana. Si potrebbe dire: dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Mangiare è prima di tutto ricevere la vita da fuori di sé, cioè riconoscersi non autosufficienti. In altre parole: riconoscere il proprio limite. Mangiare insieme ad altri è confessare davanti ad altri questa condizione di creatura […]»[2]. Per questa ragione, aggiungiamo noi, gli angeli non mangiano: ci riferiamo alla conclusione del libro di Tobia, nel quale Raffaele, che si era finto uomo per accompagnare il giovinetto nel suo viaggio, solo alla fine svela la sua identità e dice: «Quando voi mi vedevate mangiare, io non mangiavo affatto: ciò che vedevate era solo apparenza» (Tb 12,19). Ma anche nella letteratura rabbinica si sottolinea la stessa idea. E se nel libro della Genesi si legge che mentre Abramo stava in piedi presso i tre ospiti che aveva accolto nella sua tenda, vicino alle querce di Mamre, questi angeli mangiavano (Gen 18,8), l’interpretazione rabbinica insiste sul fatto che era solo un’illusione, perché in realtà il cibo che era stato dato loro veniva divorato da un fuoco divino. A questo livello potremmo intendere il tempo di Gesù passato nel deserto digiunando per quaranta giorni e quaranta notti (cf. Mt 4,2), e che, guarda caso, mette in rilievo la sua fame, e la prova connessa da parte di Satana. Ed è forse ancora per questo che Gesù, secondo alcuni, avrebbe fatto un voto di nazireato promettendo – questa volta abbiamo a che fare piuttosto con una bevanda, e non tanto col cibo – di non bere più vino (cf. Mt 26,29: «D’ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio»). Detto questo, però, dobbiamo rilevare la grande differenza tra l’atteggiamento di Gesù nei confronti del cibo, e quello del suo mentore Giovanni. Molti infatti hanno ipotizzato che i vangeli – ritraendo il Battista come colui che vive nel deserto, si veste di peli di cammello con una cintura ai fianchi e si nutre di miele selvatico – volessero rievocare a suo riguardo figure profetiche del Primo Testamento, come l’Elia di 2Re 1,8. Da una prospettiva storica e teologica, è maggiormente apprezzabile la spiegazione per cui il tipo di vita di Giovanni non dovrebbe essere visto solo come una forma “penitenziale” o ascetica, ma si spiega con le pratiche di purità di qualche corrente del giudaismo di allora: «Era necessario, secondo Giovanni, guardarsi da ogni forma di impurità: l’impurità impediva di accostarsi a Dio e a Dio di accostarsi all’uomo. Queste idee spinsero Giovanni ad evitare di mangiare cibi toccati da altri, perché l’impurità poteva celarsi in ogni contatto umano. Era difficile essere sicuri che il pane non fosse stato toccato da un essere in stato di impurità. Il miele selvatico, e quindi non toccato da nessuno, era certamente puro, come pure erano le cavallette, che trovava anche nel deserto. Il deserto e la solitudine divennero il luogo preferito da Giovanni per vivere il suo rapporto con Dio»[3]. In definitiva, nel modo di vivere e di mangiare del Battista vi era qualcosa che dice la sua visione del mondo e, conseguentemente, di Dio, visione diversa da quella di chi – proprio al suo confronto – diventava così un «mangione e un beone» (cf. Mt 11,19).
Infine, non deve sfuggirci il fatto che diverse malattie moderne hanno a che fare col cibo. Se è vero quanto abbiamo detto sopra, forse si può arrivare a dire che mangiare, in fondo, significa accettare la propria umanità, e quindi accettare di non essere perfetti.
Mangiare insieme: comunione e fragilità
Ma torniamo al tema della fragilità. Forse la fragilità più grande nello stare insieme a tavola è data dal fatto che chi mangia insieme ad altri è egli stesso toccato dal limite. Tralasciando storie di cene e banchetti durante i quali vengono allo scoperto tensioni, odi familiari, tradimenti (come quelli di cui si parla nel film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese) o tragedie, ci fermiamo sull’esperienza della comunità cristiana primitiva. Ricordiamo cioè quella cena che veniva celebrata a Corinto, per la quale Paolo lamentava che «ciascuno, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto (1Cor 11,21)» da solo. Che situazione imbarazzante per dei cristiani: «Paolo non può fare a meno di dare un’indicazione pratica, da cui traspira tutto il suo sdegno: per lui sarebbe meglio mettere fine a questa farsa! In breve: converrebbe che ciascuno mangiasse a casa propria e poi si recasse alla celebrazione eucaristica»[4].
Ecco perché anche in quell’ultima cena di Gesù emerge, alla fine, quello che doveva covare da tempo. Parleremo più diffusamente, nella quinta meditazione, della figura di Giuda, ma qui rileviamo che secondo la più antica attestazione della cena del Signore, essa ebbe luogo «nella notte in cui veniva tradito»: allora Gesù «prese del pane, e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse…» (1Cor 11,23-24). Mi ha sempre colpito questo riferimento così improvviso, di passaggio, come del resto è narrata in modo repentino l’istituzione della cena da Paolo. L’Apostolo non dice nulla del suo carattere pasquale, esce totalmente dal contesto della situazione in cui quella cena viene consumata, tranne che per un elemento: il fatto che ebbe luogo in quella notte in cui fu consegnato. L’abuso più scandaloso nella comunità di Corinto avveniva durante la memoria dell’ultima cena di Cristo: e proprio durante questa cena Gesù veniva ferito da un suo discepolo. A volte penso che se io fossi stato al posto di Gesù, sapendo che uno dei miei amici (e così infatti Gesù chiamerà ancora Giuda, nel Getsèmani; cf. Mt 26,50) mi avrebbe tradito, avrei detto così: “Questo non è il mio corpo; questo non è il mio sangue. Non ve lo meritate…”.
Se gli abusi contro la comunione, purtroppo, hanno ancora luogo tra i discepoli di Gesù, e proprio a riguardo della cena, parliamo ora di come la fragilità e il peccato siano intervenuti anche nell’ultima cena di Gesù.
Le parole sul pane
Gesù aveva capito quello che stava per accadere, e l’aveva anche sottolineato riferendosi alla prossimità di chi l’avrebbe consegnato: non uno, cioè, “esterno”, ma uno che mangiava abitualmente con lui, prendendo in modo amicale il cibo dallo stesso piatto. Nonostante questo, o forse proprio per questo, Gesù dice le parole che sempre ripetiamo anche noi sul pane e sul vino. Pensiamoci bene: se è col cibo e nel mangiare insieme che si mostrano il limite umano e le nostre fragilità personali e relazionali, allora è proprio per mezzo del cibo mangiato insieme che Gesù lascia un esempio e il segno della sua futura presenza.
Gesù – nato a Betlemme, nella “casa del pane”, e deposto in una mangiatoia (cf. Lc 2,7), nato da una famiglia in cui entrerà a far parte anche una donna straniera, moabita, Rut, andata essa stessa a lavorare a Betlemme, raccogliendo gli avanzi dell’orzo per nutrire la suocera Noemi – Gesù aveva già dato il pane alle folle di Galilea. Ora gli mancava soltanto di dare il suo corpo come pane, cioè tutto ciò che poteva ancora donare. Un intellettuale ebreo, Jonathan Rosen, ci aiuta a cogliere questo concetto, partendo dalla differenza principale tra la nostra fede e quella dell’ebraismo: «Secondo la mia tradizione, Dio si rivela nelle parole, vive nelle narrazioni e assolutamente non si può vedere né tantomeno toccare. Il Verbo, nel giudaismo, non si è mai fatto carne. La volta che Dio si è avvicinato di più a una qualche forma di incarnazione fisica è stato nel Tempio di Gerusalemme, dove la presenza divina era considerata più fisica, palpabile […]. Ma il Tempio è stato distrutto. Nel giudaismo dunque è la carne che si è fatta parole. E le parole sono diventate per tradizione il rifugio del popolo ebraico. […] E i bambini, nel medioevo, mangiavano dei dolci con dei versetti della Bibbia, un’immagine che io trovo toccante, ma anche, in un certo senso, profondamente triste»[5].
La carne, nel giudaismo, si è fatta parola, mentre per noi credenti in Gesù Cristo, è proprio la parola che si è fatta carne. Tutto ciò che il Figlio aveva già offerto di sé, ovvero la sua divinità, era stato offerto con l’incarnazione, come Paolo ci ricorda di Cristo Gesù, che «pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio» (Fil 2,6). La sua umanità, ora, doveva essere donata. Cioè la sua carne, perché era in questa carne che quella Divinità, la Parola, era diventata tale.
Un ulteriore elemento però rende questa offerta ancor più particolare. Quando Gesù dice ai suoi che possono mangiare il suo corpo come pane, lo fa mentre viene consegnato (paredídeto), cioè con il cuore toccato da quel tradimento, ma accetta, con questo ultimo atto d’amore, di dare tutto quello che gli rimaneva da donare. Si tratta, direbbe Francesco d’Assisi, della vera povertà che siamo chiamati a vivere anche noi, sull’esempio della povertà vissuta da Gesù: questa non consiste soltanto nel non possedere cose, quanto piuttosto, diremmo oggi, in una povertà in rapporto alle relazioni. Leggiamo nella sua Ammonizione intitolata «La povertà di spirito», a commento di Mt 5,3 («Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli»): «Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno molte astinenze e mortificazioni corporali [dunque, diremmo noi, una povertà concreta e ascetica], ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona, o per qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati subito si irritano. Questi non sono poveri in spirito, poiché chi è veramente povero in spirito odia se stesso e ama quelli che lo percuotono sulla guancia» (Ammonizione XIV, FF 163).
Gesù è totalmente povero perché ora, a partire dalla sua passione, non ha nemmeno più nulla da difendere, e ama anche quelli che percuoterà. Non difende se stesso, perché si è consegnato come pane, che è l’alimento più semplice e basilare dell’alimentazione; non difende il suo messaggio, perché Gesù non parla più (come si è già visto), e sarà la verità ad avere la propria forza: così ha inteso Matteo, applicando a lui l’immagine del Figlio/Servo che – già negli scontri con i farisei, in Galilea – è descritto mentre non contesta, non alza la voce, non grida (cf. Mt 12,18-21, che riprende Is 42,1-4); Gesù non difende nemmeno i discepoli, perché li sta affidando al Padre (cf. Gv 17,15). Gesù è libero e povero e non ha più niente da difendere. Meglio, forse: non difende più nulla per essere ancora più libero.
Con le parole sul calice, che commentiamo ora, Matteo insiste invece sul perdono dei peccati.
Le parole sul calice
È nelle parole sul calice di quell’ultima cena che Matteo è particolarmente originale, rispetto alle altre tre testimonianze sulla cena di Gesù (Marco, Luca, Prima lettera ai Corinzi). Infatti, solo in questo vangelo il sangue di Gesù è connesso al perdono dei peccati, nell’inciso che chiude il v. 28 sul sangue «che sarà versato per molti, per la remissione dei peccati». Anche sul piano strutturale, a guardar bene, le parole di Gesù sul calice sono al centro dei vv. 26-30: il v. 26 («detta la benedizione») corrisponde al v. 30 («dopo aver cantato un inno»); il v. 27 (il calice che devono bere tutti) corrisponde al v. 29 (il non bere più del frutto della vite), e dunque al centro rimane il v. 28 riguardante il calice e il sangue dell’alleanza.
Con queste parole finalmente l’evangelista spiega il significato del nome di Gesù, che aveva lasciato in sospeso, alludendovi quando scriveva che quel nome significa «egli salverà il suo popolo dai suoi peccati» (cf. Mt 1,21). Il nome di Gesù, nella lingua ebraica, significa Dio salverà, ma Matteo in quell’occasione, all’inizio del suo vangelo, attraverso le parole dell’angelo a Giuseppe, aveva fornito al lettore un’informazione fondamentale: quel nome ha qualcosa a che fare con il peccato del popolo, quel popolo di Israele che si ritrova nell’espressione «i molti» (pollōn) di Mt 26,28: «sarà versato per i molti». I peccati a cui pensa Matteo sono quelli di Israele, come ormai deve aver capito il lettore. Ricordiamo il percorso che questi ha fatto fino a questo punto, leggendo il vangelo.
Attraverso le parole di Gesù il lettore ha già scoperto l’annuncio della misericordia per i peccatori. Ma il Messia si è anche scontrato con il male e il peccato, e ha incontrato Satana. Al lettore però manca ancora di conoscere il modo in cui Gesù reagirà quando il Maligno e il peccato si presenteranno sotto nuove forme. Non bastano gli esorcismi di Gesù, per dire che egli è potente contro le forze che tengono prigioniero l’uomo. E non basta nemmeno, a guardar bene, una delle pagine più importanti dei vangeli sul perdono dei peccati, quella della guarigione del paralitico. Siamo di nuovo in Galilea, a Cafarnao, e Gesù dice a un paralitico che gli viene portato davanti: «i tuoi peccati vengono rimessi» (Mt 9,2). Il perdono viene da Dio, ma i lettori di Matteo capiscono che in Gesù è Dio stesso ad agire. Rimane però anche qui la domanda: sarà davvero così «facile» (Mt 9,5) la liberazione dai peccati, quanto la guarigione da una paralisi? Se è più facile per il Figlio dell’uomo guarire un paralitico, sarà sempre attuata in questo modo la sua azione di liberazione del male?
Solo con le parole sul calice, e con ciò che esse annunciano, la passione del giusto, solo ora il lettore può finalmente comprendere in quale modo avverrà la liberazione dai peccati. Se ci pensiamo bene, infatti, non è forse “troppo poco”, o “troppo facile” dire «Sono stati rimessi i tuoi peccati»? Che cosa costava a Gesù pronunciare quelle parole? Certo, si è guadagnato in quel momento l’ostilità di alcuni che l’hanno bollato come bestemmiatore. Ma come potrebbe accadere anche a noi sacerdoti oggi, quelle e altre parole potevano limitarsi ad essere una semplice formula, qualcosa di formale, estrinseco, che si deve magari pronunciare bene: parole che non costano nulla. Dobbiamo insistere su questo punto. Non bastava sapere, cioè, che Gesù avrebbe salvato il suo popolo dai peccati; e nemmeno dire come Gesù fosse potente in parole e in opere, così da cacciare i demoni e liberare i peccatori; nemmeno che avrebbe dato la sua vita per Israele, lui che aveva detto di essere venuto «per dare la vita in riscatto per molti» (Mt 20,28). Finalmente ora si può conoscere il modo in cui questo prenderà forma, quel modo in cui lo stesso Figlio di Dio, e con lui il Padre e lo Spirito, si sarebbero impegnati a dare la vita per perdonare i peccati. Perché, come dice il Salmo, «l’uomo non può riscattare se stesso né pagare a Dio il proprio prezzo» (Sal 49,8) e nemmeno può, soprattutto, ripagare il prezzo dei propri errori e dei propri peccati. Solo Dio può riscattare l’uomo da se stesso e dal male.
Il sangue nella passione di Matteo però dice ancora molto di più, e infatti dovremo tornare su questo tema in occasione della settima meditazione, quando parleremo del sangue uscito dal costato di Cristo. Ora invece concludiamo con un riferimento al rinnegamento di Pietro e alla solitudine di Gesù.
La profezia dell’abbandono
Gesù annuncia che a iniziare da Pietro, e poi riferendosi anche a tutti gli altri, i discepoli saranno dispersi. Matteo si ispira alle parole tratte dal profeta Zaccaria (Zc 13,7), nelle quali si parlava di un pastore, l’ultimo re di Giuda, Sedecia, che sarebbe stato percosso e di conseguenza il suo gregge si sarebbe perduto. L’esilio delle tribù, la cui dispersione è ora rievocata grazie a questa profezia, è davvero accaduto storicamente con la morte dell’ultimo re di Giuda, Sedecia (già rievocato nella genealogia di Gesù; cf. Mt 1,11-12). Questo esilio, però, lascia intendere Matteo, terminerà con la morte e risurrezione del Signore: tutti i dispersi, allora, verranno radunati, e anche i discepoli di Gesù potranno ritrovarsi. Ma prima si dovrà passare attraverso la desolazione e l’abbandono: solo dopo, solo dopo tre giorni la risurrezione di Gesù ricompatterà Israele e la Chiesa di Cristo.
Pietro, generosamente, dichiara a Gesù la sua fedeltà illimitata. La risposta del Maestro lo spiazza, ma l’apostolo la comprenderà solo quando si sarà consumato il suo rinnegamento. Il canto del gallo di cui Gesù parla al v. 34 ha suscitato diverse interpretazioni. Dal punto di vista della cultura romana poteva richiamare il gallicinium, a cui si riferisce anche Mc 13,35 (alektorophōnía), il canto del gallo che designava la terza veglia della notte (dalla mezzanotte alle 3 del mattino). Ma dal punto di vista della tradizione giudaica, potrebbe trattarsi di un termine tecnico. Nella letteratura rabbinica l’espressione «canto del gallo» infatti indica l’appello dell’ufficiale del Tempio che richiama al loro servizio – tramite lo shofar (cf. Mt 24,31) – tutti i sacerdoti, i leviti e i fedeli (cf. Talmud babilonese, Yoma 20b ecc.). Se Gesù si stesse riferendo a questo strumento, le implicazioni sono interessanti. Mentre viene rinnegato da Pietro, questo peccato non è l’ultima parola sulla loro relazione: Pietro, che era stato per Gesù “voce di Dio”, come la voce dei folli, dei bambini, dei sogni, ora può ascoltare quella “voce” che viene da Dio, attraverso la mediazione del suono dello shofar, e rendersi conto di quanto ha fatto, per poi pentirsi.
[1] Cf. E. Anati, Le radici della cultura, Jaca Book, Milano 1992, 23-29.
[2] J.-P. Hernandez «Le regole sul vitto e altre regole», in Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, a cura di G. Piccolo, Garzanti, Milano 2016, 161-162.
[3] P. Sacchi, Gesù e la sua gente, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003, 77.
[4] F. Manzi, Prima lettera ai Corinzi. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, 161.
[5] J. Rosen, Il Talmud e Internet, Einaudi, Torino 2001, 59-60.