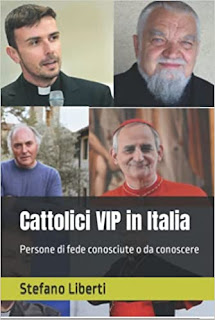6 febbraio: 30 anni fa moriva p. David Turoldo (il ricordo di Ravasi e di Mancuso)
Gianfranco Ravasi su L'Osservatore Romano:
Ricordo di David Maria Turoldo: Quel Dio alla frontiera tra essere e nulla
Trent’anni fa, giovedì 6 febbraio 1992, padre David Maria Turoldo chiudeva la sua esistenza piuttosto unica per intensità, creatività e passione, in una clinica milanese allora gestita dai Padri Camilliani. Quattro giorni prima, nella domenica dedicata dalla Chiesa italiana alla Vita, nonostante i dolori lancinanti inferti dal «mostro», come egli definiva il cancro che si annidava nelle sue viscere, aveva celebrato un’ultima Messa, trasmessa da Rai Uno, suggellando l’omelia con un estremo messaggio di speranza: «La vita non finisce mai!». Anzi, il giorno antecedente alla sua morte aveva ancora intessuto e letto a noi amici un «salmo», ricreando liberamente una delle pagine di quel Salterio biblico che era stato uno dei suoi grandi amori spirituali e poetici.
In quei versi risuonava un tema abissale e supremo che aveva segnato di sangue gli scritti di mistici come Giovanni della Croce o Maestro Eckhart o Angelo Silesio, il Nulla, il Nada, nel quale però sbocciava il fiammeggiare del divino: «Impossibile che sia il Nulla / l’estremo traguardo: / impossibile sarà pensarti / come realmente tu sei, o mio Signore: / sconosciuto Iddio sei tu / nostra unica sorte». Quel germe di luce che, durante la celebrazione funebre del sabato successivo 8 febbraio, il cardinale Carlo Maria Martini aveva idealmente fatto sbocciare nella chiesa milanese di San Carlo al Corso, evocando la «rocciosità» della fede del frate che era vissuto come «Servita di Maria», l’Ordine religioso a cui apparteneva.
Ricomporre la biografia di questo protagonista della storia ecclesiale e culturale del Novecento è piuttosto arduo per la sua debordante ricchezza, varietà e dialettica. Ha cercato di farlo in modo esemplare la storica Mariangela Maraviglia in David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza (1916-1992), un saggio edito nel 2016 dalla Morcelliana. Forse il ritratto simbolico sarebbe da cercare in un’istantanea ideale della folla che nella deliziosa chiesa di Fontanelle a Sotto il Monte Giovanni XXIII si raccoglieva ogni domenica per la liturgia, ascoltando la sua omelia, partecipando ai canti intessuti sui suoi testi, vivendo in profondità l’eucaristia. Oppure si potrebbero fissare in un’altra immagine i volti che nelle sale o nelle piazze seguivano i percorsi ora pianeggianti, ora d’altura, dei suoi discorsi.
A questo punto è necessario introdurre anche un risvolto autobiografico. La mia amicizia con padre David era nata in seguito alla pubblicazione negli anni 1982-1984 di un mio imponente commentario ai Salmi: tre volumi di oltre tremila pagine che Turoldo aveva studiato, riletto e approfondito. Per questo mi aveva cercato ed era iniziata una consuetudine durata poi per anni. Nel pomeriggio di ogni domenica scendeva dalla sua abbazia di Sotto il Monte, il luogo di nascita di Giovanni XXIII , a casa dei miei familiari a Osnago (Lecco), ove io mi recavo, dal Seminario in cui allora insegnavo, per il mio impegno pastorale del fine settimana. Ed era in quelle ore che parlavamo a lungo, che egli mi leggeva i suoi testi, che accoglieva con un’umiltà assoluta anche le mie riserve, che ci si inoltrava lungo i sentieri di altri libri biblici che io allora stavo commentando, come Qohelet e il Cantico dei cantici, destinati a diventare materia di altre sue riflessioni o poesie. Era, così, nata la sua nuova versione poetica dei Salmi Lungo i fiumi… accompagnati dal mio commento, un testo riedito almeno una quindicina di volte fino al 2012 e riproposto in questi giorni dalla San Paolo in una nuova edizione, da me rivista e arricchita, col titolo I canti nuovi.
Di quei pomeriggi, che mi resero padre David amico e interlocutore intimo, c’è una testimonianza curiosa che è anche la “sorpresa” estrema che egli volle farmi. Infatti alla sua opera postuma, edita da Rizzoli nel 1992, Il dramma è Dio (egli, però, aveva scelto come titolo Il dramma è di Dio) aveva apposto una lettera a me destinata ma che aveva voluto rimanesse segreta fino al momento della pubblicazione del libro. La lessi, perciò, quando ricevetti l’opera stampata ed egli era morto da un paio di mesi. Eccone il testo, datato «Festa dell’Ascensione 1991», che ho spesso avuto occasione di citare.
«Gianfranco, mi perdonerai di chiamarti sempre così: amico delle mie — delle nostre — domeniche. È per riconoscenza di questa amicizia e di quei nostri conversari, nell’atrio della tua casa, smentendo che quella sia l’ora del “demone meridiano” (tanta invece era la serenità e la gioia di quei nostri amati colloqui); è per sdebitarmi, dico, del dono di una così ricca amicizia che ora ti dedico questo lavoro… convinto che mi perdonerai di aver osato apparire come un invasore del tuo campo biblico. Ma tu sai che non è vero. Tu più di altri sai con quanto timore e tremore mi accosto a questi abissi; e quanto mi conforta il rispetto verso di voi, insostituibili interpreti. È poi noto che scrivo soprattutto per gli amici…; per gli amici antichi, quelli della resistenza per l’“Uomo”: presenze che sempre evoco nelle mie dediche, al fine di continuare appunto a “resistere”».
Da queste righe emerge in modo nitido il nesso intimo tra amicizia e fede, tra dialogo e ricerca sulla Parola di Dio, tra poesia e confessione. Proprio come aveva scritto in modo lapidario nella prefazione al saggio Il grande male il suo amico Carlo Bo: «Padre David ha avuto da Dio due doni: la fede e la poesia. Dandogli la fede, gli ha imposto di cantarla tutti i giorni». E si potrebbe aggiungere «in tutti i luoghi», dalle zolle della sua nativa Coderno in Friuli fino nei sotterranei della lotta antifascista, tra gli echi delle volte del Duomo di Milano ma anche nella familiarità calda di Nomadelfia, dall’Annunziata di Firenze a S. Maria delle Grazie a Udine, dal monte Berico al Senario, dall’amatissimo ritiro per nulla eremitico di Sotto il Monte alle sale, alle aule, alle piazze vocianti, dai luoghi di un esilio forzato indotto dalle autorità ecclesiastiche, come il Canada lontano e sterminato o l’Austria, la Baviera, la Svizzera, l’Inghilterra e persino gli Stati Uniti, fino ai piccoli centri, fino appunto al villaggio bergamasco o pugliese.
La sua figura imponente e sanguigna («questo vichingo», come lo soprannominarono i Fiorentini), dalla quale fuoriusciva una voce da cattedrale o da deserto, vanamente temperata dall’invincibile sorriso degli occhi chiari, aveva proprio nella Parola biblica il suo alimento vitale. «Servo e ministro sono della Parola», si era autodefinito, consapevole che ormai tutto il suo essere si era trasformato in «una conchiglia ripiena» dell’eco di quella parola infinita come il mare. A lui era profondamente caro il verso di un altro suo amico, unito nella fede e nella poesia, Clemente Rebora: «La Parola zittì chiacchiere mie». Per questo il suo affettuoso ammiratore, interamente ricambiato, il citato cardinale Martini, nella presentazione del volume Opere e giorni del Signore, aveva comparato padre Turoldo a Efrem Siro ( IV secolo) e al bizantino Romano il Melode ( VI secolo), straordinari autori di omelie bibliche cantate.
Forse bisognerebbe in modo sistematico e rigorosamente critico rileggere l’immensa produzione poetica turoldiana proprio inseguendone la filigrana biblica. È noto, infatti, che il flusso letterario e spirituale di questo «cantore delle dense ore di Dio» copre l’intera sequenza delle Sacre Scritture, dalla Genesi, con l’irrompere della creazione dal grembo del nulla, fino all’Apocalisse e al suo sospiro finale del Maranathà, «Vieni Signore», passando soprattutto — come si diceva — attraverso l’amatissimo Salterio. La pagina turoldiana è come un intarsio di citazioni, allusioni, ammiccamenti, evocazioni bibliche: il suo è lo spartito della Parola suprema orchestrata in parole.
Le sue due opere finali sono le più potenti, ancorate anch’esse alla Bibbia, sia pure in una forma originale e inedita. Sono Mie notti con Qohelet e i Canti ultimi, questa seconda raccolta da considerare come il suo testamento e forse il suo capolavoro. In essa ritorna il tema lacerante del Nulla mistico: «Dio e il Nulla — se pure l’uno dall’altro si dissocia… / Tu non puoi non essere / Tu devi essere, / pure se il Nulla è il tuo oceano». Questo groviglio di luce e di tenebra ha la sua raffigurazione emblematica nel Cristo crocifisso («Fede vera è il venerdì santo / quando Tu non c’eri lassù») e padre David ne è stato attratto come da un gorgo avvinghiante.
Già lo era stato in molte liriche precedenti. «E Tu, Tu, o Assente, mia lontanissima sponda… Mio Dio assente lontano… Ma Lui, Lui sempre lontano, invisibile… La tua assenza ci desola… All’incontro cercato nessuno giunge… Notte fonda, notte oscura ci fascia — nera sindone — se tu non accendi il tuo lume, Signore!… Ma tu, Signore, sei bianca statua di marmo nella notte… Un Dio che pena nel cuore dell’uomo…». Negli ultimi scritti, però, Turoldo si mette in viaggio verso questa Gerusalemme capovolta in modo deciso, pellegrino del Nulla e del Tutto. Passa in mezzo a silenzi astrali, scivola nel «cratere» del Dio incandescente, naviga «nei fiordi della speranza» e percorre «tunnel sottomarini» in cui baluginano luci giallastre, inseguito sempre dallo sguardo di Dio «come di un falco appollaiato sul nido».
Ed è proprio alla frontiera tra essere e nulla che Turoldo incontra Dio, come Giacobbe dopo la lotta al fiume Jabbok o come Giobbe dopo il lungo grido tenebroso. Su quella linea di demarcazione non c’è un Dio imperatore impassibile e onnipotente, bensì un Dio sofferente, perché «ogni creatura ti muore tra le braccia nel mentre che si forma e si fiorisce». Un Dio che, nel creare, ha sperimentato il Nulla, il suo antipodo, «Tua e nostra frontiera», e che in Cristo ha bevuto il calice della morte.
Sono note le tensioni con le istituzioni ecclesiastiche che segnarono la vicenda di p. Turoldo, certamente da ricostruire nel contesto di quel periodo storico pieno dei fermenti del Concilio Vaticano II , tenendo conto della sua passione vigorosa e anche del suo ripetuto desiderio di non cercare né dissenso né consenso ma solo un senso profondo e autentico. D’altronde, il suo sguardo — simile a quello di altri suoi amici come don Mazzolari, don Milani, don Zeno, padre Balducci, padre Camillo De Piaz — si proiettava oltre, verso un futuro che solo successivamente si è delineato, sia pure in forme sempre contrastate e contrastanti. A questo proposito vorrei segnalare un curioso ricordo che non ho mai avuto occasione di rivelare. Un giorno, durante uno dei nostri dialoghi — eravamo negli anni ’80 — padre David aveva esclamato: «Mi piacerebbe che un Papa scegliesse come nome quello di Francesco d’Assisi».
Concludendo questa memoria essenziale, si deve comunque riconoscere che la radice dell’impegno di padre Turoldo è stata sempre l’incarnazione del cristianesimo. Una presenza viva che si attestava spesso sulle frontiere più roventi o nei territori più disabitati da presenze religiose. I rischi di queste incursioni erano evidenti e sono a tutti noti. Ma padre David ha sempre tenuto alta la fiaccola della speranza cristiana, convinto che Cristo è con noi «vagabondo / a camminare sulle strade, / a cantare con noi / i salmi del deserto». Convinto anche che la meta ultima della storia è trascendente, là dove «le lettere del divino Alfabeto / saranno in fiore per il Cantico Nuovo».
E nei nostri giorni spesso superficiali è ancor più necessario far risuonare la voce di questo frate e poeta che inquieta la pigra pace delle coscienze col fuoco di quell’Alfabeto che risuona dal roveto ardente.
Leggi anche:
Far risplendere l’umano contro il disumano
di Gabriele Nicolò
L'esperienza della morte quale dono dolcissimo
di Roberto Rosano