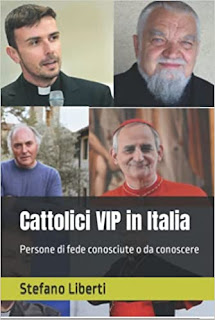CINEMA. Festival di Venezia: premi e recensioni (Sentieri del Cinema)
IMPERDIBILII premi principali del festival del cinema di VeneziaLeone d’oro per il miglior film: Joker, di Todd Philips
Gran premio della giuria: J’accuse, di Roman Polanski
Leone d’argento per la miglior regia: Roy Anderson, per il film About Endlessness
Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Ariane Ascaride, per il film Gloria Mundi
Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: Luca Marinelli, per il film Martin Eden
Miglior sceneggiatura: No. 7 Cherry Lane, di Ji Yuan Tai Qi Hao
Premio Marcello Mastroianni (a un attore emergente): Toby Wallace, per il film Babyteeth
Premio speciale della giuria: La mafia non è più quella di una volta, di Franco Maresco
Miglior film della sezione Orizzonti: Atlantis di Valentyn Vasyanovych
Il film di Todd Phillips conquista, per la storia e soprattutto per la prova straordinaria di Joaquin Phoenix
Con Joker, il regista Todd Phillips fa approdare il cattivo più affascinante dei comics alla Mostra del Cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre): accompagnato da una risata strozzata e da un dramma potentissimo, la parabola di Arthur Fleck sa essere in contemporanea una storia intensamente personale e tragicamente politica. Uomo ai margini della società e con seri problemi psichici irrisolti, Fleck si guadagna da vivere facendo il clown su commissione, mentre si occupa dell’anziana madre e nutre ambizioni da comico, anzi da stand-up comedian. La sua fragilità lo espone però ad una malvagità che sembra aver contagiato la grande metropoli di Gotham (una spaventosa New York da anni 70), esponendola ad un’ondata di crimini violenti e facendo aumentare ancora di più il divario tra ricchi e poveri. Escludendo quasi completamente l’immaginario fumettistico che ha nutrito il personaggio fino ad ora, il film di Todd Phillips immerge il suo protagonista nella melma di un degrado sociale ed esistenziale spaventosamente contemporaneo:qui gli uomini hanno smesso di provare compassione per i propri simili, si nutrono delle violenze consumate nei vicoli deserti di una città arrabbiata e godono del fallimento dei più deboli. Come un vaso di cristallo tra tanti vasi di coccio, colpo dopo colpo il corpo e la mente di Fleck si crepano, fino ad un’esplosione di violenza che porterà alla nascita di un Joker completamente fuori dagli schemi. Il percorso di Fleck verso il nuovo sé stesso è dunque una vera e propria discesa agli inferi, dove ogni dettaglio, ogni icona e ogni accessorio che caratterizzeranno il ben conosciuto personaggio viene motivato da eventi devastanti, terrificanti proprio per la loro verosimiglianza. Oltre a presentarci una parabola evolutiva del personaggio pressoché perfetta, il film di Phillips fa scacco grazie anche alla incredibile interpretazione di Joaquin Phoienix – papabilissimo vincitore della Coppa Volpi – che con un fisico consumato dal dramma, movenze e balli volutamente iperbolici e una risata incontrollata riesce a dare una profondità tragicomica al suo Joker pari a quella del suo collega Heath Ledger nel Cavaliere oscuro. Apoteosi del fallimento della nostra società contemporanea, il film di Phillips è un’opera completamente nuova su un personaggio ormai iconico, che mostra rischi e conseguenze di un sonno della ragione – e dell’umanità di ciascuno – capace di generare veri e propri mostri. (Maria Letizia Cilea)
Roman Polanski porta al Lido un grande film, J’accuse, che prende vita dalla famosa lettera dello scrittore Émile Zola (pubblicata su un quotidiano) e dal caso politico di fine Ottocento, più comunemente chiamato l’affare Dreyfus. Il colonnello George Picquart, lo stesso che ha destituito Dreyfus, è chiamato a dirigere una sezione degli affari segreti. Ostinato e ossessionato dalla perfezione, scoprirà quello che è stato uno dei più grandi errori giudiziari, frutto della corruzione politica e degli affari segreti. Scena dopo scena Polanski costruisce un film politico, pieno di tensione e di azione, senza cedere mai al didascalismo o allo storicismo. Interpretato da un cast di grandi attori (Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric), J’accuse manifesta la grandezza di un regista che non smette mai di regalare al pubblico grandi opere. (Emanuela Genovese)
Marriage Story, il lungometraggio in concorso che scrive e dirige Noah Baumbach (regista newyorchese molto amato per film come Frances Ha, Il calamaro e la balena, Giovani si diventa). Dura più di due ore (esattamente 135 minuti) e non c’è niente di inutile o di forzato in questa storia che racconta l’amore e la separazione di Charlie (Adam Driver) e Nicole (Scarlet Johansson), in via di un divorzio di cui paga le conseguenze anche il figlio. Lui, brillante regista teatrale, lei brava attrice e sua musa. Baumbach coglie il cuore e le fragilità della relazione, racconta due città, New York e Los Angeles, mostra le imperfezioni di vite di artisti che potrebbero sembrare inattaccabili dal dolore, mette in campo le scelte e le strategie (soprattutto degli avvocati); e schernisce anche simpaticamente l’Italia, ironizzando sulla perfezione (anche biblica). Un gran bel film, che diverte e commuove grazie alla forza dei dialoghi e all’intensità dei protagonisti, che vedremo in autunno su Netflix ma forse anche in contemporanea nelle sale (e ce lo auguriamo di cuore). (Emanuela Genovese)
In un futuro prossimo, mentre la Terra subisce inspiegabili tempeste elettromagnetiche, un astronauta è incaricato di raggiungere Marte per provare a contattare una spedizione spaziale guidata da suo padre scomparsa vicino a Nettuno da circa 20 anni. James Gray, uno dei più sottovalutati registi americani contemporanei (tra i suoi film Two Lovers e C’era una volta a New York), con Ad Astra – sempre in concorso – scrive e dirige un film di avventure spaziali stupefacente e intimista. Stupefacente perché racconta il viaggio nello spazio fino a Marte (e poi oltre) e le varie tappe con gusto per l’avventura e la meraviglia, quasi come se fosse una storia di avventure marinaresche (abbiamo pirati lunari, relitti, ammutinamenti) senza però perdere mai il realismo nella messa in scena. Stupefacente a livello visivo, grazie a notevoli effetti speciali, alla clamorosa fotografia di Hoyte van Hoytema; e stupefacente a livello sonoro con le musiche potenti di Max Richter. Stupefacente anche nell’interpretazione di Brad Pitt (una delle sue migliori) che regge tutto il film sulle proprie spalle e sul proprio volto a cui siamo sempre attaccati. Intimista perché lo spettacolo è al servizio e a favore del racconto del rapporto padre-figlio e soprattutto del racconto di un uomo solo. Un uomo solo che viaggia nello spazio per scappare dalla Terra, convinto di trovare nelle stelle qualcosa di altro dall’uomo, per poi alla fine poter imparare a guardare all’uomo che abita sotto le stelle. Imperdibile. (Riccardo Copreni)
CONSIGLIATI
“Babyteeth”, dell’esordiente Shannon Murphy, convince in concorso al Lido.
una sorprendente opera prima, Babyteeth. E già si parla di possibili premi. Milla, 16enne malata di tumore, incontra un giovane spacciatore, Moses, che vive per strada ma non sembra aver paura di niente. Moses risveglia in lei un forte desiderio di vivere e di amare, proprio quando le sue condizioni fisiche si aggravano. Milla, i suoi genitori e tutti coloro che fan parte delle loro vite vengono toccati dallo scompiglio e dall’energia portati dal legame tra i due ragazzi. Il primo film dell’australiana Shannon Murphy, dopo una certa confusione nella prima parte, racconta con un taglio nuovo una storia portata spesso sul grande schermo, quella di una giovane malata terminale. Procedendo per capitoli ellittici, evidenziati anche da interruzioni nella colonna sonora, e con alcuni fugaci sguardi in camera della protagonista (Eliza Scanlen, già nella miniserie Sharp Objects e che vedremo in Piccole donne di Greta Gerwig), il racconto si focalizza innanzitutto sulle relazioni tra giovani, tra adulti e sullo scambio tra questi due mondi. C’é tanto dolore, ma anche umorismo e umanità: ad esempio quella del maestro di violino, che si preoccupa dei suoi allievi e di trasmettere loro la bellezza della musica prima ancora di insegnare a suonare, e quella delle madri, prima senza linee di comunicazione con i figli e poi sempre più desiderose di non perdersi nulla della loro vita, a costo di affrontare una grande sofferenza senza anestesie. E un finale speranzoso riflette sulla possibilità che questi legami siano capaci di durare oltre la morte. (Roberta Breda)
The Laundromat di Steven Soderbergh, seconda produzione Netflix presentata in gara per il Leone d’oro. È il racconto dello scandalo dei Panama Papers, cioè la diffusione delle informazioni di uno studio legale di Panama riguardanti centinaia di migliaia di società offshore in tutto il mondo sul confine tra legalità e illegalità. Seguiamo la vicenda di un’anziana vedova (Meryl Streep), truffata da una di queste società, che combatte per smascherare gli inganni subiti, mentre a spiegarci le dinamiche finanziarie è la coppia di avvocati, il gatto e la volpe, interpretati dal gustosissimo duo Gary Oldman – Antonio Banderas. È un film folle e caleidoscopico, che racconta la finanza con lo stile sovraeccitato e ironico di film come The informant! (dello stesso Soderbergh) o La grande scommessa ma con molta più eleganza. Scott Z. Burns (adattando un romanzo di Jack Bernstein) scrive un copione diviso in capitoli completamente anarchico nei personaggi, nelle situazioni, nell’ironia cinica, nei riferimenti metacinematografici e nelle divagazioni. Alla regia Steven Soderbergh si conferma uno dei più liberi e geniali autori del cinema americano contemporaneo, con una quantità di idee visive strabiliante, un caleidoscopio di forme e invenzioni. Racconta la finanza e la politica come facevano i film degli anni 70, ma lo fa con un’ironia feroce che è tutta contemporanea. In due parole: geniale e irresistibile. Da vedere. (Riccardo Copreni)
Da segnalare poi fuori concorso il notevole Adults in the room, cronaca della crisi economica greca del 2015 raccontata dal punto di vista del ministro dell’economia del nuovo governo di sinistra nel primo anno di mandato. Ritorno al cinema del maestro del cinema politico Costantin Costa-Gravas, autore di alcuni importanti film degli anni 70 come Z-l’orgia del potere. Il film è avvincente e coinvolge lo spettatore per tutte le due ore di durata. Il merito va innanzitutto alla sceneggiatura, tra il thriller e la farsa, scritta dal regista adattando il romanzo dell’ex ministro Yanis Varoufakis. Costa-Gravas sembra aver perso l’eleganza formale dei suoi precedenti capolavori, ma riesce comunque a infondere ritmo e forza alla storia e a far brillare i suoi attori (tra cui la nostra Valeria Golino nel ruolo della moglie del ministro). Il risultato è una cronaca spietata dell’atteggiamento dell’UE nei confronti della Grecia. Un atteggiamento non proprio esemplare, anche se forse, più che un film antieuropeista, è un richiamo ai valori fondativi dell’Unione Europea e un appello disperato a un ritorno a una reale voglia di aiutarsi. (Riccardo Copreni)
Una bella sorpresa è poi il primo film italiano in concorso. Dopo la delusione di un anno fa, quando Mario Martone presentò sempre in gara a Venezia Capri-Revolution, eravamo un po’ timorosi davanti al suo nuovo film, Il sindaco del rione Sanità tratto dall’omonima opera di Eduardo De Filippo già portata sullo schermo negli anni 90 da un modesto film con Anthony Quinn e Raoul Bova. Ci insospettiva – lo ammettiamo – anche l’uscita ridotta, come “evento”, solo per tre giorni (dal 30 settembre al 2 ottobre); come si usa per le fiction portate in anteprima al cinema o per opere troppo sperimentali. E invece Martone, che aveva già portato in teatro l’opera, fa centro nel mettere in scena con quasi totale fedeltà al testo (ci pare di ricordare solo una significativa differenza nel finale) ma libertà di messa in scena e nella rappresentazione dei personaggi che sono più giovani che nell’opera; il che all’inizio può lasciare perplessi. Una storia che anche nell’attualità della Napoli di oggi è credibile, con questo “sindaco” che governa su un quartiere – il celebre rione Sanità – e regola le controversie privatamente, per aiutare gli “ignoranti” che rischiano di essere stritolati dalla giustizia o da chi può permettersi (come lui stesso un tempo) di piegarla a suo piacimento. Un boss ma con un suo senso di giustizia e anche della pace sociale, che cerca di evitare la violenza finché si può e di risolvere le dispute con il peso del suo prestigio (e del timore che incute). Ma un fatto, che mette di fronte un figlio e un padre e che può portare a spargimento di sangue, segna la vita di tanti personaggi. Il contraltare del “sindaco” sono un medico e un ricco panettiere (il padre che ha diseredato il figlio), e nel loro ergersi nella loro dignità sta una delle chiavi del film, in cui pure ogni personaggio ha la sua verità (e lo stesso boss vuole sentire sempre le due versioni dei contendenti). Un’opera convincente – soprattutto se si supera lo spiazzamento di un testo e una recitazione teatrale accompagnata da look a tratti aggressivi e “moderni” e regia a tratti molto movimentata – che si avvale più o meno dello stesso cast della versione teatrale di Martone: in particolare ci sono gli ottimi Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, mentre si inserisce nel gruppo il “dottore” interpretato dal bravo Roberto De Francesco. (Antonio Autieri)
La vérité del maestro giapponese Kore-eda Hirokazu, che per la prima volta dirige un film internazionale. Il risultato un po’ ricorda inizialmente ricorda l’impressione di certi film di analoghi autori che allontanandosi dal loro paese – pensiamo a certi film europei degli iraniani Kiarostami o Farhadi – perdono un po’ della loro forza, forse persino della loro anima. Alla lunga però avvince questa storia su una madre diva del cinema francese interpretata da Catherine Deneuve (inizialmente un po’ simile a tanti altri suoi ruoli un po’ svagatamente e deliziosamente cinici ma ripetitivi, ma poi man mano sempre più emozionante) e la figlia sceneggiatrice (un’ottima Juliette Binoche) che si è trasferita a New York con il marito, attore americano di serie B. Lo sfondo è da un lato un libro di memorie della diva, che ha mentito spudoratamente come in tutta la sua vita, dall’altro il film di fantascienza che sta girando che si intitola La vérité (anche qui su una madre e una figlia, divise dalla malattia della genitrice costretta a vivere nello spazio tornando sulla Terra ogni 7 anni per non invecchiare: alla fine, la figlia è anziana e la madre ancora giovane). Verità che sembra non interessare alla protagonista, più tesa ad affermare sé (anche in contrasto con le colleghe, del passato o del presente) che le persone che ha accanto. Ma la vicinanza con la figlia, anche se conflittuale (per vecchie ferite del passato), forse può riaprire la partita del loro rapporto. Lo stile è lontano dai film che abbiamo conosciuto dell’autore giapponese (Father & Son, Little Sister, Affari di famiglia); non sapendo chi sia il regista, lo si prenderebbe per il classico film francese. Ma al pubblico, che forse lo apprezzerà, non dovrebbe interessare. Ottimo tutto il cast, c’è anche Ethan Hawke nei panni del marito americano che sa di essere un attore mediocre. (Antonio Autieri)
Martin Eden, quarto film, ma primo interamente di finzione, di Pietro Marcello. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Jack London, Martin Eden (interpretato da un sempre più bravo Luca Marinelli) è un marinaio alterna la sua vita tra i viaggi sul mare e la casa della sorella e del cognato a Napoli. Quando un giorno difende un ragazzo picchiato da un uomo violento, Martin viene accolto nella villa della sua famiglia. Il ragazzo è un Orsini, e ha una sorella Elena, bellissima. Martin se ne innamora da subito come si innamora dei libri che lei ha. Inizia la sua lenta, faticosa, immersione nello studio e in quella che è la sua passione più vera: la scrittura. Profondo, mai banale (anche nella scelta dei materiali d’archivio) Martin Eden è un film che non si dimentica. Riguarda tutti noi – come conferma l’ambientazione non in un preciso momento storico come si intuisce dai riferimenti (abiti, oggetti, canzoni, ecc.) a tutta la storia del Novecento – e quel necessario e innato desiderio di trovare il proprio posto nella vita. Martin non misura e calcola, comprende le persone che ha al suo fianco, è generoso e onesto nelle parole e nelle azioni. Sarebbe un film perfetto se non fosse per la ascesa – discesa finale del protagonista; è troppo rapida quella evoluzione – involuzione, troppo amara anche se non elimina mai l’ammirazione per la grande capacità del regista Pietro Marcello e del suo sceneggiatore Maurizio Braucci di trasformare un capolavoro letterario in un piccolo grande film. (Emanuela Genovese)INTERESSANTI (con riserve)
L’esperto regista marsigliese porta in concorso alla Mostra il suo “Gloria Mundi”, dov’è passato anche l’ultimo film italiano, quello di Franco Maresco.
Un regista di lungo corso, il francese Robert Guédiguian. Il titolo del suo film, Gloria Mundi, è tratto dal detto latino “sic transit gloria mundi” (così passa la gloria del mondo) a significare quanto siano effimere anche le cose di maggior successo nella vita. Titolo calzante, visto il paragone tra la vita di due sorelle marsigliesi, entrambe sposate: l’una proprietaria col marito di un negozio, e in procinto di aprirne un altro; l’altra sul punto di essere licenziata, con una figlia neonata e un marito autista di Uber, cui i tassisti hanno rotto un braccio per vendicarsi, e quindi disoccupato. Ma non è che i genitori delle due se la passino meglio: la madre fa le pulizie ed è costretta a fronteggiare ogni giorno il rischio di sciopero che taglierebbe il suo magro salario, mentre il padre è solo un autista di mezzi pubblici. A complicare la vicenda, arriva il vero padre di una delle due sorelle, scarcerato dopo anni di detenzione per omicidio. Guédiguian mostra ancora una volta, con toni da verismo letterario, la vita difficile di molte famiglie che non inseguono sogni di successo semplicemente perché troppo occupate ad arrivare a fine mese, e come sia facile abbandonarsi alla disperazione o a scelte dalle conseguenze dolorose. Utilizzando attori di grande mestiere ormai a lui legati da molti altri film (oltre a sua moglie, Ariane Ascaride, anche i vecchi amici Gérard Meylan e Jean-Pierre Darroussin), il regista cerca uno sprazzo di umanità in una società fatta di opportunismo e spietatezza, dove sempre meno sono le persone capaci di un gesto gratuito o una mano tesa. Peccato però che, a differenza di altre volte (e pensiamo per esempio all’intensità de Le nevi del Kilimangiaro), lo svolgimento della storia sia suggerito a ogni piè sospinto verso una conclusione drammatica e nobile al tempo stesso, ma – in quanto ampiamente annunciata – poco incisiva. (Beppe Musicco)
Convince ancora (molto) meno il terzo e ultimo film italiano in Concorso. La mafia non è più quella di una volta, ma lo stile di Franco Maresco invece sì. Come se fossimo ancora ai tempi di Cinico Tv, il regista siciliano si imbarca con questo documentario per vedere cos’è cambiato nella coscienza dei palermitani a 25 anni dall’uccisione di Falcone e Borsellino, in compagnia della fotografa Letizia Battaglia. Lo fa col suo stile: prende ad esempio le varie manifestazioni studentesche ma anche l’impresario di concerti di neomelodici Ciccio Mira e la sua sgangherata compagnia di giro, che organizza un concerto per la commemorazione di due giudici nel quartiere Zen di Palermo ma nel quale nessuno ha coraggio o volontà di dire che i due sono stati uccisi dalla mafia. Il risultato è tra il ridicolo e l’agghiacciante, come spesso succede nella filmografia di Maresco. E la cosa peggiore è che in fondo non sembra esserci molta differenza tra gli uni e gli altri. (Beppe Musicco)
DELUDONO
Non convincono Roy Andersson e Atom Egoyan. Mentre un documentario dalla Romania ci parla di sanità e di giornalismo…
Om det oändliga (About Endlessness) è diretto dallo svedese Roy Andersson che pochi anni vinse il Leone d’oro con Un piccione riflette seduto su un ramo riflette sull’esistenza che estasiò parecchi al Lido ma non chi scrive (anzi…). Sulla falsariga di quella lunga serie di brevi quadri su vicende contemporanee o del passato, ma tutte segnate dall’assurdità e mostrate con cinico sarcasmo (tipo: un uomo muore in un bar e gli altri avventori si fanno avanti per il panino e la birra che aveva appena pagato), anche il nuovo film ci mostra – con l’accompagnamento di una voce fuori campo che spesso anticipa quello che vedremo – una teoria di personaggi anonimi, di cui non sappiamo nulla, alle prese con vicende surreali, patetiche, disperanti o tragiche: il prete che ha perso la fede e cerca da un medico la soluzione al suo dramma, un padre che ha ucciso la figlia per salvare l’onore della famiglia ma se n’è pentito, un vecchio avvilito dal fatto che un antico compagno di scuola faccia finta di non riconoscerlo, un uomo su un autobus che piange perché non sa cosa vuole, un marito geloso che schiaffeggia la moglie in pubblico. E poi storielle minime che vorrebbero essere buffe o allegre (ma con poca leggerezza, a parte tre ragazze che ballano per strada) ma che spesso sono angoscianti o irritanti, con qualche excursus storico (si vede Hitler). Ma più di tutto lo è lo sguardo del narratore che quasi mai ci mostra i volti delle persone (mai un primo piano, quasi a negare identità a persone – riprese obliquamente – che sono minuscole nell’assurda storia del mondo) e che a suo dire voleva «sottolineare la bellezza di essere vivi e umani» attraverso contrasti e rivelando anche il lato peggiore di un’esistenza di cui si mostrerebbe «l’infinità dei segni». A noi pare uno sfoggio di nichilismo ilare che ci rattrista profondamente, in cui non c’è un grammo di pietà per il dolore umano né tanto meno di bellezza (nonostante l’ultima scena, in cui un uomo sostiene – nell’indifferenza generale e con un tono poco convincente – la bellezza delle cose). Il pregio maggiore: dura solo 76’, crediti compresi (Antonio Autieri)
Om det oändliga (About Endlessness) è diretta dallo svedese Roy Andersson che pochi anni vinse il Leone d’oro con Un piccione riflette seduto su un ramo riflette sull’esistenza che estasiò parecchi al Lido ma non chi scrive (anzi…). Sulla falsariga di quella lunga serie di brevi quadri su vicende contemporanee o del passato, ma tutte segnate dall’assurdità e mostrate con cinico sarcasmo (tipo: un uomo muore in un bar e gli altri avventori si fanno avanti per il panino e la birra che aveva appena pagato), anche il nuovo film ci mostra – con l’accompagnamento di una voce fuori campo che spesso anticipa quello che vedremo – una teoria di personaggi anonimi, di cui non sappiamo nulla, alle prese con vicende surreali, patetiche, disperanti o tragiche: il prete che ha perso la fede e cerca da un medico la soluzione al suo dramma, un padre che ha ucciso la figlia per salvare l’onore della famiglia ma se n’è pentito, un vecchio avvilito dal fatto che un antico compagno di scuola faccia finta di non riconoscerlo, un uomo su un autobus che piange perché non sa cosa vuole, un marito geloso che schiaffeggia la moglie in pubblico. E poi storielle minime che vorrebbero essere buffe o allegre (ma con poca leggerezza, a parte tre ragazze che ballano per strada) ma che spesso sono angoscianti o irritanti, con qualche excursus storico (si vede Hitler). Ma più di tutto lo è lo sguardo del narratore che quasi mai ci mostra i volti delle persone (mai un primo piano, quasi a negare identità a persone – riprese obliquamente – che sono minuscole nell’assurda storia del mondo) e che a suo dire voleva «sottolineare la bellezza di essere vivi e umani» attraverso contrasti e rivelando anche il lato peggiore di un’esistenza di cui si mostrerebbe «l’infinità dei segni». A noi pare uno sfoggio di nichilismo ilare che ci rattrista profondamente, in cui non c’è un grammo di pietà per il dolore umano né tanto meno di bellezza (nonostante l’ultima scena, in cui un uomo sostiene – nell’indifferenza generale e con un tono poco convincente – la bellezza delle cose). Il pregio maggiore: dura solo 76’, crediti compresi (Antonio Autieri)