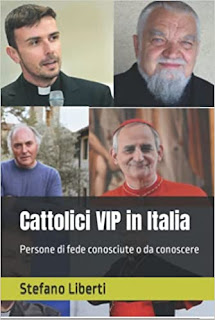Esce oggi il saggio di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti sulla presenza sociale dei cattolici («La scommessa cattolica», Il Mulino, pagine 198, euro 15). Riporto una recensione di Ferruccio De Bortoli per il Corriere e qualche altra considerazione.
Chiara Giaccardi e Mauro Magatti sono moglie e marito. Hanno sette figli. Sono entrambi sociologi. E insegnano nella stessa università: la Cattolica a Milano. Se si dovesse giudicare il loro libro La scommessa cattolica (il Mulino) dalle prime fulminanti pagine — nelle quali non nascondono, come credenti impegnati, un po’ di scoramento — dovremmo concludere che il tramonto della Chiesa è irreversibile. Non solo per gli scandali. È un «pachiderma immobile». Si avvertono «scricchiolii allarmanti». «Difficile immaginare un futuro — sono le loro parole — se la Chiesa rinuncia a dialogare con la parte più avanzata del mondo».«La Chiesa al maschile è anacronistica ma la risposta non è il sacerdozio femminile, è la reciprocità». Tutto ciò non per arretrare. O, peggio, arrendersi. Ma, come insegnava Michel de Certeau, per «spingere il pellegrinaggio un po’ più in là». Essere testimoni del Vangelo in modo diverso, coraggioso. «La Chiesa è un popolo che cammina, un popolo che non è, ma che si fa». E dovrebbe favorire l’esperienza della fede, non arroccarsi nel cercare di trattenere chi la fede ce l’ha o mostra o si illude di averla.Non può fermarsi. Né mostrare di aver perso l’orientamento come un viandante stordito da un vento sconosciuto. È una rete, non una gerarchia. «Nella Chiesa di oggi si ascolta troppo poco». E non può nemmeno illudersi di recuperare il terreno perduto affidandosi a improbabili compagni di viaggio. «Spregiudicati nell’uso dei simboli religiosi», branditi come armi improprie in una battaglia identitaria lontana anni luce dall’universalità cattolica, dai principi evangelici. Il riferimento non è solo alla destra europea, Viktor Orbán in testa.Magatti e Giaccardi sono convinti che mai come in questo momento, in cui l’uomo sembra bastare a sé stesso, lo spazio per la «buona novella» sia ampio e inesplorato. Mai come in questo momento, in cui la tecnologia insegue addirittura l’immortalità, la questione religiosa è stata così importante. Centrale. «La vita non è solo razionalità». L’io si sostituisce a Dio (Homo Deus di Yuval Noah Harari), ma è sempre più insicuro e fragile. Le reti sociali si indeboliscono. «I sintomi di una crescente fatica di vivere si registrano su vari fronti». L’io ipertecnologico soffre di solitudine. Ha meno amici, anche se connesso con tutto il mondo. Insegue la salvezza del corpo, non dell’anima. Ha una povertà spirituale che lo rende oggetto inerte e inconsapevole a disposizione di una tecnica che manipola la sua natura, ne spia ogni passo, ne determina quelli successivi.La tesi di fondo de La scommessa cattolica è che, in una globalizzazione disordinata, ci si dimentica che «la fede cristiana è stata l’architrave dell’ordinamento politico e sociale che ha retto finora l’Occidente». La soggettività occidentale è stata costruita nei secoli nel rapporto tra fede e ragione, tra Chiesa e Stato. «Tutta la predicazione evangelica — sostengono gli autori — è diretta alla persona, alla sua libertà di scelta». La soggettività occidentale nasce dall’alleanza tra Cristianesimo e ragione. Da San Francesco a Dante. Un’alleanza oggi in crisi. «Ma l’amore — che è il nocciolo del Cristianesimo — non contrasta la ragione, la allarga». Altre visioni del nesso tra individuo e società e tra immanenza e trascendenza si stanno impossessando (si pensi solo alla Cina) degli elementi chiave della globalizzazione.Si perde così progressivamente il senso dei valori su cui è stata costruita la democrazia, lo stesso capitalismo. Risuonano, in varie pagine del libro, le parole di Romano Guardini sull’importanza del contributo di umanità e libertà del cattolicesimo a beneficio di tutti, non solo dei credenti: la concretezza del vivere sbilanciandosi oltre sé stessi, protendendosi verso gli altri. L’uomo moderno è come il figliol prodigo della parabola. Il Padre lo aspetta, ma non si sa se ritroverà la via di casa. Il mito dell’autosufficienza è una droga sottile. Invisibile. Asintomatica.Come può allora la Chiesa ricostruire il suo popolo e ritrovare la propria autorità perduta? Andando nelle periferie come esorta Francesco. Il pensiero del Papa è «in continuità nella discontinuità» con l’intuizione più profonda di Benedetto XVI. Ovvero la denuncia «dell’incapacità della ragione nell’illuminare il cammino individuale e collettivo». Ma le periferie esistenziali sono dappertutto. Nella miseria dello spirito più che nella povertà dei mezzi. E allora l’esperienza dei cattolici può strappare l’uomo moderno, il figliol prodigo, dalla tenaglia di due poli contrapposti. Quello della disumanità del cinismo contemporaneo. E quello della transumanità, l’ideologia della perfezione tecnologica.La fede per Giaccardi e Magatti, è affidamento, non è un consegnarsi. Ne può esaurirsi in una esperienza individuale, privata. Peggio: fai da te. Si nutre di voci profetiche, di esempi forti. Ha bisogno soprattutto di una Chiesa che si rimetta in cammino. Che superi l’attuale immobilismo. Con esperienze nuove. Non liturgie stanche (il catechismo ridotto a una «scuolina» insipida). «Portatrice — concludono gli autori — di una dignità infinita che ci provoca e ci impegna. Questa è la via per creare una società più umana».
Critico è, sullo stesso giornale, il
commento di Marco Nese:
La recensione di Ferruccio de Bortoli («Corriere» del 14 agosto scorso) del libro di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti La scommessa cattolica (il Mulino) sollecita alcune riflessioni.
1. La domanda vera non è tanto se la Chiesa cattolica abbia un futuro. Bisogna invece chiedersi se sia giusto rintracciare il senso del nostro vivere solo affidandoci al messaggio di una religione apparsa circa 2 mila anni fa. Ci siamo ristretti a scrutare un orizzonte limitato. Come se la storia dell’umanità fosse racchiusa nell’arco di appena un paio di millenni.
2. La nostra origine biologica non ci parla di esseri soprannaturali, non allude a una trascendenza. Non è certo la storia di Adamo ed Eva che, secondo William King, «altro non era che una burla e una ben congegnata turlupinatura». La nostra storia comincia circa 40 milioni di anni fa, quando compaiono i Primati, da cui si sviluppa poi il ramo umano. Tralasciando tutti i passaggi, arriviamo a noi, all’Homo sapiens, che comincia a calcare il suolo terrestre almeno 200 mila anni fa.
3. Per secoli la Chiesa cattolica ha utilizzato le teorie di pensatori pagani per far credere che gli umani abbiano il privilegio di vivere su un pianeta creato apposta per loro. Un pianeta fermo al centro di uno spazio circoscritto. In realtà il nostro pianeta non è fermo e naviga in uno spazio praticamente infinito. La fisica dei cieli non è diversa dalla fisica della Terra e immaginare un aldilà paradisiaco nell’alto dei cieli non ha più senso. Vendere il Cielo è diventata un’operazione quasi disperata, la Chiesa può sopravvivere solo concentrandosi sulla vita terrena, hic et nunc, privilegiando forme di assistenza sociale.
4. Dal punto di vista mentale, siamo ancora connessi a schemi di pensiero antichi. Dobbiamo imparare a pensare la nostra esistenza in una realtà molto più vasta di tempo e spazio. Non possiamo prescindere dal fatto che la vita ribolliva in varie forme ben prima di noi e se 65 milioni di anni fa non si fossero estinti i dinosauri, forse la vita umana nemmeno sarebbe emersa.
5. Leggo che «la questione religiosa non è mai stata importante come in questo momento storico». In realtà nei secoli passati la questione religiosa aveva un’importanza ben maggiore di adesso. Condizionava la vita degli esseri umani e formava lo spirito dei popoli. Sorretti dall’indomita fede di camminare col Signore al fianco, i Puritani fondarono le colonie americane. Ma oggi la domanda da porsi è: quale religione? Il grande studioso Mircea Eliade diceva che in ogni epoca e in ogni angolo della Terra nel cuore degli esseri umani arde uno spirito religioso. Ma le religioni evolvono e muoiono. Toccherà anche al Cristianesimo.
6. Dice de Bortoli che l’uomo sembra voler bastare a sé stesso e che l’io si sostituisce a Dio. A me sembra il contrario. Un bel libro di Keith Hopkins, docente del King’s College, a Cambridge, è intitolato A world full of Gods. L’invenzione delle divinità segnala la disperazione del vivere e il terrore della morte. Per rendere i giorni sopportabili è un bel sollievo sognare una realtà ultraterrena. Ma il problema è che l’uomo fa le domande e l’uomo dà le risposte.
7. Moderni teologi scrivono libri usando antiche immagini rivestite con parole moderne. Sempre i soliti termini, sacro, anima, soprannaturale, di cui in realtà non saprebbero dare una spiegazione plausibile. Chiusi i libri, ripensi al contenuto e ti sembra un ben confezionato esercizio dialettico che non ti lascia assolutamente nulla. Già il filosofo Francis Bacon all’inizio del Seicento avvertiva che un certo linguaggio, un sapere verboso, crea mondi fittizi spacciandoli per autentici.
L'Avvenire oggi presenta uno stralcio dell'introduzione del libro:
Vedi infine quanto scrive la Giaccardi per Il Sussidiario:
La scommessa cattolica (il Mulino 2019), scritto a quattro mani con Mauro Magatti e frutto di un cammino condiviso con tanti, cerca di sparigliare le categorie rigide che hanno ingabbiato il dibattito, rendendolo a nostro avviso sterile: una battaglia che finisce col diventare ideologica e si aggiunge alle tante che alimentano il clima di generalizzata ostilità. È davvero impressionante constatare il livore con cui tanti cattolici entrano nel dibattito pubblico attraverso i social, su temi cruciali quali l’immigrazione, per esempio.La scommessa non è identitaria, ma antropologica. Il cristianesimo, e in particolare il cattolicesimo che ne è la sua anima maggioritaria (in alleanza, e non in competizione con le altre), ha da dire qualcosa a questo tempo: una parola che fa bene a tutti, e non solo ai credenti, perché porta un contributo senza il quale si rischia di venire risucchiati, paradossalmente in nome della libertà, in un sistema tecnocratico che ci rende irrilevanti e disumani. A patto, però, che all’interno del cattolicesimo ci sia il coraggio di purificarsi dall’inessenziale e ritrovare, nell’infinita ricchezza della tradizione, ciò che può parlare al mondo di oggi e aiutarlo a non restare vittima dei suoi stessi successi. Dentro una unità che non è uniformità (a volte si ha quasi l’impressione che il “pensiero unico” tanto attaccato sia un sogno recondito di omogeneità senza dissensi anche dentro la Chiesa!), ma che è ricca proprio perché comunione di differenze. Come la Trinità – troppo spesso ce lo dimentichiamo.
Il tema della libertà è cruciale, almeno in due sensi. Il primo riguarda il rapporto con una verità che non può essere dimostrata, ma solo cercata, ascoltata, cercata di nuovo e continuamente. La fede non è un possesso né una certezza. Al massimo, con le parole di Guardini, è una “combattuta fiducia”, sempre da alimentare. Si può solo scommettere, nel senso pascaliano, che vale la pena “puntare” la propria vita sulla buona notizia di un Dio che ci ama, perché questo rende il nostro esistere più intenso e più pieno da subito. Un Dio che è padre e quindi ci vuole liberi, ci invita con discrezione, come un vento leggero e non come un tuono, e non impone la sua volontà. Non saremmo a immagine di Dio se non fossimo liberi.
E qui viene il secondo significato, illustrato dalla parabola del figliol prodigo, che nel libro abbiamo letto in chiave escatologica: noi moderni siamo il figlio là fuori, che si è preso la responsabilità di uscire da casa e di vivere autodeterminandosi, nell’illusione di bastare a se stesso. Siamo stati audaci, ma forse ci siamo accorti che il nostro desiderio non ha trovato la risposta che cercava. Che gli effetti dell’autodeterminazione sono solitudine, logica dello scarto, disuguaglianza, distruzione della natura…
Se ci ricordassimo che il padre non solo ci ha lasciati andare, ma ci ha dato la nostra parte di eredità perché seguissimo i nostri sogni anche su una strada lontana dalla sua, forse sapremmo ricostruire un’alleanza nuova, su nuove basi. Il padre che ama non è colui che desidera che il figlio faccia tutto quello che vuole lui, ma colui che desidera che il figlio sia libero, anche a costo di sbagliare. E che lo aspetta con le braccia aperte, pregando. Se il figlio non fosse uscito di casa, avrebbe subìto il comportamento del padre.
Troppo spesso la Chiesa tiene le parti del fratello maggiore che mormora parole di risentimento, quasi utilizzando la sventura di chi è uscito come prova della propria integrità. Ma Dio, che ama tutti, fa festa per chi torna. Con consapevolezza, come scelta libera, non per paura. Il ritorno è una festa, un’alleanza rinnovata e feconda, basata non sulla paura, ma sul desiderio.
La Chiesa non deve avere paura della libertà! È ciò che rende unico l’uomo tra tutti i viventi. Oggi c’è l’occasione per ripensare, anche partendo dai fallimenti della modernità, come giocare questa libertà. Un’occasione che non va persa, tornando alla morale del primo figlio della parabola. Il ruolo della Chiesa è oggi piuttosto quello di essere la voce che ricorda l’amore del padre, facendo maturare il desiderio del ritorno.
È poi ora di uscire dallo sterile dibattito tra progressisti e conservatori, che paralizza il cammino della Chiesa creando divisioni “diaboliche” e neutralizza il ruolo potenziale del cattolicesimo, ideologizzandolo. La scommessa è anche quella di archiviare finalmente questo schematismo. Noi non siamo né progressisti né conservatori: sosteniamo che la modernità ha prodotto cose buone, ma anche enormi distorsioni. Serve uscire da questo schema e assumere un ruolo fedele al messaggio evangelico: essere capaci di farsi lievito in un mondo che ha necessità di cambiare e di restare umano. Senza difese, steccati, dogane. Perché non sono le idee chiare e distinte che ci salvano, ma il movimento paradossale predicato da Gesù: “Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi è disposto a perderla, la trova”. Non si può “mettere in sicurezza” la verità e definirla in maniera esaustiva, circoscrivendola come possesso di qualcuno e come qualcosa a cui bisogna sforzarsi di aderire. Sognare il “rischio zero” dentro la Chiesa è snaturare la buona notizia. Gesù ci offre un metodo (da odos, via), più che un “contenuto” di verità: amare Dio e amare il prossimo. Il resto è camminare dietro di lui, fidandosi e affidandosi. Questa è la via su cui scommettere oggi. Non come “adesione” a qualcosa di esteriore, dalla dottrina ai precetti, ai quali ci si sforza di conformarsi, ma, appunto, come “affidamento” (parola che ha la stessa etimologia di fede, da fides: corda, legame). È un movimento che parte da dentro e trasforma la persona.
Quando Gesù proclama di essere “la via, la verità e la vita” mette, non a caso, la via al primo posto. La verità non è lì bella pronta da predicare, ma bisogna mettersi lungo quel cammino: “la fede vede nella misura in cui cammina” (Lumen fidei 9).
La fede è relazione, non adesione a un contenuto. La fede come affidamento non è un’indicazione morale, ma antropologica che può capire chiunque, anche un non cristiano. Sono due vie molto diverse. La Chiesa ha privilegiato la prima strada anche nella formazione, fissando contenuti semplici, chiari e distinti da trasmettere. Adesso invece, è necessario percorrere la via dell’affidarsi, del camminare dentro l’orizzonte tracciato da Gesù, dell’avviare processi senza avere già chiaro il punto di arrivo, ma con la pazienza del discernimento comunitario.
Non si tratta di un dualismo, ma di una tensione, dove finora è stata privilegiata la via dell’adesione, mentre oggi va coltivata quella dell’affidamento: in un mondo apparentemente sempre più social, che ha sete di legami anche se ne ha paura, questo è un messaggio che può parlare a tutti.
Anche perché affidarci ci aiuta ad andare oltre noi stessi, e il movimento dell’autotrascendimento è potentissimo nell’uomo (l’unico animale, come scriveva Camus, che non si accontenta di essere ciò che è). È la tecnica che intercetta oggi questo desiderio, con le derive che conosciamo. Oggi il desiderio di salvezza è riposto nella tecnica, che può offrire tutt’al più delle sicurezze. La Chiesa ha il compito di re-intercettare questo desiderio. Come far comprendere che quello che noi desideriamo non è la sicurezza (il controllo, l’azzeramento del rischio), ma la salvezza (la pienezza)? Perché “salvo” non vuol dire solo “vivo”, ma “integro”, “felice” e “fecondo”.
È la via, entusiasmante anche per i giovani, di una ad-ventura, di un andare incontro a un futuro che non è già scritto, a un a-venire che introduce l’elemento della libertà nel determinismo del divenire.
Un futuro dove la logica del paradosso consente di superare una volta per tutte il dualismo che ha caratterizzato molto del pensiero della Chiesa, che si è innestato sul pensiero greco. Un dualismo che ha fatto tanti danni, mettendo in contrapposizione ciò che è inseparabile (per esempio, dottrina e pastorale, o unità e pluralità) e ha allontanato le giovani generazioni. Una proposta integrale, di concretezza vivente, non solo è più fedele al Vangelo, ma può essere affascinante anche per loro. Allora l’impasse in cui si trova il cattolicesimo nel mondo occidentale può diventare kairòs di rigenerazione.
In un tempo in cui la Chiesa stessa soffre di individualismo e astrazione e rischia la deriva intellettualistica, che paradossalmente (ma non troppo) si sposa con le spinte populiste, la scommessa può essere vinta se si torna alla concretezza, nel senso in cui ne parla Romano Guardini: se si abbracciano tutte le dimensioni dell’umano a partire dalla relazionalità, filiale e fraterna. La scommessa cattolica è che il Vangelo abbia moltissimo da dire a questo tempo. Non si tratta di ripetere ciò che è stato detto in passato, di tornare a un’età dell’oro che non è mai esistita, ma di scrivere una nuova pagina nella storia della Chiesa.